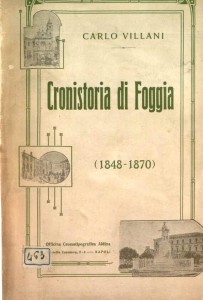Cronistoria di Foggia (1948-1970)
Questo libro scritto circa un secolo fa da Carlo Villani, illustra molto bene le vicende storiche del tempo ed esalta personaggi che hanno lasciato un segno nelle vicende del capoluogo dauno. Il libro è stato trascritto un po’ alla volta e messo a disposizione dei navigatori web da un grande amico di questo sito, Raffaele Fujani… buona lettura!
INDICE – SOMMARIO
- — Prodromi della Costituzione del 1848 — Foggia tra la miseria e il grippe — Indifferenza del governo per essa — Ribasso sul prezzo del sale — Rivoluzione latente — Proclami incendiarli — Arresti—L’intendente Patroni—Metodi loioleschi di governo — Olimpia Verlej — Inizio di libertà di stampa — Primi opuscoli e giornali locali — Indulto agli arrestati politici — Saverio Altamura — Pellegrinaggio popolare — Tolleranza dell’ intendente — Avvento del Bozzelli al Ministero — Pubblicazione dell’ atto sovrano — Esultanza dei foggiani — Agnello lacuzio e gli avanzi della Carboneria — Fascio di giovani liberali — Petrilli e Cassetta —1 Manifestazioni universali di gioia — Funzione in chiesa — Assenza del Capitolo — L’abate Russo intuona il Te Deum — Gala al teatro — Promulgazione dello Statuto — Obolo cittadino — Tre giorni di festeggiamenti—Michele Achille Bianchi — Monforte scende in chiesa—Dimostrazione solenne — Michele Ricca spiega la Costituzione — Carro trionfale — Giovani tribuni — Gaetano Maldacea — De Noia guida la folla — Assedio al seminario — Carica di lancieri—Statella e Monforte — Intervento del sindaco — Allontanamento di Maldacea »
— Guardia nazionale provvisoria— Giuramento di essa, della gendarmeria e delle guardie di onore — Discorso De Anellis — La truppa giura — Un bel gesto di Sta-tella — Sua destituzione — Patroni a riposo — Arrivo di Coppola—Partenza di Monforte— Caos in diocesi — Legge elettorale provvisoria — Convocazione del Par¬lamento — Giunta per le liste — Ulteriori giuramenti — Sospensione di Iacuzio — Gala al teatro — Vincenzo Del Conte — In prò delle orfane — Posti di guardia nazionale — Turbolenze in provincia e a Foggia — De Girolamo e Fania — Inconscienza delle masse — Tolleranza delle autorità — Miseria e malandrinaggio — In’ aiuto degli operai — Minaccia di Monforte — De Noia infiamma il popolo — Protesta al sindaco — Si riaffermano i dritti del Comune — Un boia scacciato — Giambattista De Angelis con Magone — Sua azione — Stampa locale — De Angelis e Magone allontanati da Foggia — Sorteggio e organizzazione della guardia na¬zionale — Dispensa di fucili — Sopraffazione di. un birro — Foggiani e lucerini fraternizzano — Preoccu¬pazioni del governo — Suoi delegati speciali — F. S. Figliolia — L’intendente Coppola in aspettativa — Lombardi nuovo intendente — Consiglio di pubblica sicurezza — Notabili — Tibi boicottato — Eccitamento popolare — I contadini per le terre demaniali — Anar¬chia con parentesi epilettiche — Allarme a Foggia — Partenza di Tibi e di Smith — Proclami dei cala¬bresi — Francesco Romeo —Apprensioni nei popo¬lino — Azione della polizia . . . . . . . …
— Preparativi per l’elezìofxe politica — Nicola Rosati ne detta le norme al popolo — Comizii in S. Dome¬nico — Petrilli e De Maria issano il tricolore sul cam¬panile — Proclamazione dei deputati di Capitanata — Zuppetta e Barbarisi a Foggia — Loro precedenti pa¬triottici — Gaetana Faccilongo — Discorsi elettorali — Entusiasmo cittadino — Giuramento dei liberali—Ga¬briele Cicella — Michele Ricca fornitore di armi e mu¬nizioni — Le sette contraddizioni capitali — Agnello Iacuzio in contatto coi rivoluzionarii delle provincie —Arresto di Romano Mozzicone — Lettera di Crispano a Iacuzio — Proclama di Dardano — Iacuzio compartecipe della cospirazione — Bromuro inefficace — Barbarisi va nella Marina — Zuppetta attacca la Costituzione — Sue latenti minaccie — Arrivo di Fuccilo —Zuppetta parte per Napoli — Ritorno di Barbarisi a Foggia — Consiglio di pubblica sicurezza — Barbarisi insidiato — Suoi ammonimenti al Fuccilo — Agitazione rivoluzionaria in città
— Azione dei deputati di Capitanata — Ferdinando De Luca in casa Lanza e al Ministero — Luigi Zuppetta il 14 maggio ’48 — Saverio Barbarisi alle barricate — Decadenza della dinastia borbonica — I moderati contro Zuppetta — Le milizie cittadine sotto le armi — I deputati di Capitanata il 15 maggio — Scatti di Zuppetta — Giuseppe Ricciardi per un comitato di sicurezza pubblica — Dall’ ammiraglio Baudin — Firme alla protesta di P. S. Mancini — Mano sacrilega sull’arca santa — Allarme a’ Foggia — Inconsulte precauzioni del ff. intendente — Notizia intorno all’ eccidio di Napoli — Affissi a stampa del Fuccilo — Comunicazione di decreti — Cordoglio e indignazione della cittadinanza — Minaccia di barricate — Azione pacificatrice dei maggiorenti — Giuseppe Libetta — Proclama dell’ intendenza — Riunione del comitato liberale — Nomina di un sotto-comitato — Tentativo per un governo provvisorio — Invio di messaggi — Deposito di danaro a scopo rivoluzionario — Tanzi, Garofalo e Giannini — Mancanza di coraggio nei cittadini — Sforzi di Michele Ricca — Venditori ambulanti arrestati — Vitale e Sorrentini — Lavoro febbrile dei liberali — La Dieta di Potenza — Memorandum delle provincie con federate — Inutili sforzi per un governo provvisorio — Foggia immutabile e immutata — Giuseppe Ricciardi nelle Calabrie — Sua pagina gloriosa
— Le nuove elezioni politiche — Circolare del ministro Bozzelli — Risposta di Mariano d’Ayala — Le nuove elezioni considerate a Foggia non legali — Il comitato allontana gli elettori dai comizii — Cipri e Vitale in giro — Zuppetta e il suo proclama incendiario — Protesta di Saverio Barbarisi — A Foggia i comizii deserti — I pochi intervenuti protestano — In qualche circondario si vota — Riapertura del Parlamento — F. De Luca, G. Libetta, S. Barbarisi — Discorso della Corona — Elezioni complementarie suppletive—Lotta titanica — Zuppetta eletto a Foggia — Seppellimento della Costituzione — Lenta e progressiva repressione — Disgregazione di sotto-comitati — 11 comitato di Foggia delibera una Dieta — Tommaso Tonti presidente — Tarantino, Cipri e De Noia raccolgono soccorsi pei Cosentini — Il p. Borsari delle scuole pie — Fuccilo novellamente ff. intendente — Sua azione repressiva —Ritorno di Tibi — Nuovo fermento — Esplosione di fuochi pirotecnici — Timor panico ed arresti — Scioglimento della guardia nazionale — Proclama anonimo — Cipri disarma la truppa per armare il popolo —La Capitanata in obbedienza passiva — Relazione di Fuccilo al Ministero
— Periodo di reazione — Fujano despota della piazza — Saverio Altamura esiliato — La giustizia istru-mento della polizia —Foggia crocifissa sul Calvario — Vitale e Iacuzio arrestati — Si va in cerca di Du¬rante — Vitale e Iacuzio giudicati — Giovanni Rossi relatore — Loro assoluzione — Destituzione del Rossi — La sbirraglia e Fuccilo in gaudio — Persecuzione alle pipe — Fuccilo premiato — Ritorno di Monforte col Maldacea — Sua entrata in città — Arresto momenta¬neo di liberali — L’avvocato Baculo — Nomina di R. Guerra ad intendente — Inizio di sua dittatura — Me¬todi loioleschi — Lega col Monforte — La religione mezzana — Concetto regio — Festa natalizia del re— Il veronal alle masse — I foggiani sotto il mansa-nillo — Freda, De Luca e Siniscalco fuori del Consi¬glio di beneficenza — Scrutinio — Cafarelli destituito — Liberali irretati — Legnate agli Apicella — Ulteriori arresti — Dissimulazione del Guerra — Esercizii spirituali — Espulsione di guardie di onore — Destituzioni ed arresti —Benedizione papale — R. Guerra nelle pubbliche funzioni — Tra la mitra e l’aspersorio — Ricomposizione delle file borboniche — Voto di fedeltà del Decurionato — Una commissione dal re — Suo gradimento — Rianimazione di arresti, di destituzioni e di processi — Amnistia — Ritorno degli arrestati nelle famiglie — Iacuzio, Vitale e Durante in libertà provvisoria — Cicella e De Ninno esiliati — Alessio Barone sindaco — Riapertura del Consiglio provinciale — Terremoto in Basilicata — Soccorsi ad Ascoli e ad altri siti — Ferdinando II su’ luoghi del disatro — Foggiani a Melfi — Scorta di guardie di onore — Il re promette di visitare Foggia
“— Processo pel 15 maggio — Luigi Zuppetta abbandona Napoli — Sue peripezie durante l’esilio — Saverio Barbarisi arrestato — Sua odissea nei sotterranei di S. Elmo —Vesperia e Fuccilo imbastiscono l’accusa contro entrambi — Barbarisi scrive il suo Costituto —Requisitoria di Angelillo — Memoria del Barbarisi —Testimoni delle provincie di Foggia e di Bari — Pollice verso… — Giudizio alla Corte speciale — Conclusioni del P. M. — Contegno dell’accusato — Sentenza — Condanna a morte — Commutazione della pena nell’ ergastolo — Fine miserrima di Barbarisi in S. Francesco — Giudizio in contumacia contro Zuppetta — Sua condanna a morte — Ulteriori peripezie durante l’esilio — Sua esaltamento a S. Marino
— Esercizii spirituali — Questua religiosa — Mise¬ria cittadina — Il cardinale Mattei — La commenda di s. Silvestro a Guerra — Ricomincia la caccia ai libe¬rali — Arresti ed esilii — Reazione sfacciata — Fiera di maggio nel 1853 — Aristocrazia napoletana a Fog¬gia — Prezzi favolosi dei cereali — Pericolo di carestia — Fermento nella provincia — Violenze a Montesantangelo — Riunione di granisti — Lavori agli operai — Il Monte frumentario — Verbali di cautela — R. Guerra immutabile — Il sindaco Barone arrestato —È arrestato lo scolopio Cicella — Stupore nella cittadinanza — Falsa denunzia — Il commissario in carcere — Escarcerazione del sindaco per ministeriale —Momenti difficili — Cicella menato a Napoli — Per avere inneggiato alla Costituzione subisce un processo a Lucera — È condannato ai ferri — Monforte in fin di vita — Suo decesso — L’instancabile Guerra dà addosso ad altri liberali — Antonio Caso gran commissario del Filo elettrico — Lavorio di spie — Suo arresto a Genzano — Reclamato a Napoli con De Toma —Giudizio a Lucera — Sua condanna a morte — Commutazione di pena — Espiazione all’ isola di Procida —Topografìa dei bagni — Sua liberazione
— I bruchi ed il colera — Lazzaretto — Preghiere nelle chiese — Esodo di paurosi — Il sindaco in fuga —R. rescritto — Statistica del colera — Giubileo — L’intendente bacchettone — La chiesa foggiana eretta a vescovado — Sua importanza ab antiquo — Lotta per la mensa vescovile — Costituzione della rendita —Monsignor Iannuzzi sub-delegato apostolico — Confini della diocesi — Dibattito — L’Incoronata e S. Lorenzo —lnstrumento notarile — Riserva pel dritto di patronato municipale — Possesso della nuova cattedra—Festeggiamenti — Ricci e Tizzani rinunciano al pastorale — Bernardino M.a Frascolla primo vescovo — Sua entrata in città — Sua opera in prò del clero-
— Circolare Mazza contro gli attendibili — Ridda di sanfedisti e di spie — Soprusi — Opinioni bistrattate — Visita domiciliare al sindaco—Attentato di Agesilao Milano — L’intendente provoca messe e Te Deum — Omelia del vescovo — Dimostrazione — Indirizzo al re — Deputazioni che partono per Napoli — Il collegio dei gesuiti di Lucerà elevato a liceo — Preferenza offensiva pel capoluogo — Dispiacenza e protesta dei foggiani — Si riaccendono le giuste pretese pel tribunale — Suo antico diritto — Pratiche inutili per ottenere una sezione civile — Inefficace mediazione di Leopoldo e di Ioinville — Trionfo del dritto della forza — Concessione di cattedre universitarie — Il liceo a tempi migliori
— Viaggio di Ferdinando II in Puglia — Preparativi a Foggia — Arrivi della Commissione reale, di truppe, di funzionarne di alti personaggi—Incontro al limite della provincia — Ingresso del re in città—Festeggiamenti — Amnistia — Neil’ oratorio dell’ intendenza,— Partenza per Andria — Promessa di presto ritorno — Onorificenze a vescovi — Movimento pel ritorno del re — Notizia della sua malattia — Passaggio del dottor Ramaglia— Ansiosa aspettazione — Continuazione di preparativi di feste — Mutamento d’itinerario — Il re a Bari — Sbarco di Maria Sofia — Dimostrazioni popolari è Te Deum — Mistero intorno alla malattia del re — Passaggio del conte di Siracusa — Il re a Caserta — Imperiale in giro pei santuarii — Notizia del viatico al re — Annunzio della morte imprevvista — Simulazione delle autorità — Arresto di Sorge e di Tarantino, propalatori di triste presagio — Presentimento di Ferdinando — Caldara ne fa i ritratti — Funerali a Foggia — Giuramento a Francesco II
Amnistia di Francesco II — Abolizione delle liste degli attendibili — Foggiani che riacquistano la pace — Ordine pei festeggiamenti — Onorificenze e ninnoli — Francesco vociato imbecille—Cospirazione di palazzo — Foggia centro della rivolta — Filiasi e Filangieri – Scoprimento della congiura — Dimissioni di Filangieri —R. Guerra messo a riposo — Sua partenza da Foggia —Il nuovo intendente duca di Bagnoli — Visita alla cattedrale — Cappelli prodigiosi — Genetliaco del re —Funzione in chiesa e festa da ballo Alessio Barone novellamente sindaco — Riapertura del Consiglio provinciale— Promesse dell’ intendente — Il Ministero Statella — Corsa alla dissoluzione — Il commissario Chiarini — Un suo atto arbitrario — Lo si trasloca — Eco dello sbarco a Marsala e delle vittorie di Garibaldi in Sicilia — Moisè Maldacea, uno dei Mille — Caduta inevitabile del Borbone — Accesso di necrofobia poliziesca — Arresto di De Noia — Indignazione delle masse —La rivoluzione in marcia — La Costituzione in articulo mortis — Altre comunicazioni di reali concessioni —Ghiaccio nel popolo — Gioia ufficiale — Minacce anonime — Invito alle barricate — Gendarmeria ed eunuchi in moto — Una ferrovia-burletta — Onestà dell’ ultim’ ora — La Sicilia in fiamme — Terrore di Francesco II — Garibaldi minaccia il continente — Dedizione di Nunziante — Il torrente irrompe — Funzionarli che si dileguano — Nuovo sindaco — Il vescovo Frascolla dispare — Stemmi manomessi — Scompiglio dell’ intendente — Intimazioni dei liberali — Riorganizzazione della guardia nazionale — Giunta elettorale — Comitato di ordine e di azione — Santaniello ne propone la fusione — I comitati si fondono — Tumulto per la nomina del presidente — Dimostrazioni in piazza —Divieto di assembramenti — Ultimi sprazzi autoritarii — Genetliaco di Maria Teresa — Levata di scudi del popolo
— Nicola Morra — Uccisione di un guardiano — Venticinque anni di ferri — Evasione da Nisida — Aureola di leggende — Protettori e protetti — Compromissioni — Carlo Giannini sospeso dall’ ufficio — Sue vane proteste — Ricatti in forma di prestiti — Gendarmeria impotente — Episodii romanzeschi — Cavallo di Palazzi — A Cerignola con Buchicchio — Cavallo di Mangiacapo — Alla masseria Piscitella — Sequestro e ricatto a Padula — Restituzione di parte del danaro ricattato — Vendetta contro Pavoncelli —Figliolia nella botte — Siniscalco, De Luca e F amministratore di Laroehefoucauld e del duca di Bisaccia —Cena sul!’ erba — Al guado dell’ Ofanto — I gendarmi burlati — Trappola a Montesquarcillo — Persecuzione ai congiunti del bandito — Le pudende di Loreta Morra — Libello — Quod superest…. — A un moribondo —Per un cambio militare — Per un sequestro giudiziario — Gara per prestargli aiuto — Il tenente Martucci —Teresa Cibelli a Ferdinando II — Messaggi rivoluzionarli — Buchicchio capitano garibaldino—Scontro con Barone — Morra ferito — Sua presentazione spontanea — Passa per Foggia e va a Lucera — Giudizio e condanna — Partenza per S. Stefano — Vecchiezza impenitente
— Il marchese di Rose sindaco — Suo insediamento col Decùrionato — Simpatie de’ liberali per lui — Il conte Gaetani espulso — La casa Cimaglia assediata — Ostracismo a Delli Santi — La guardia nazionale sbaraglia la folla — Fuga dei Cimaglia a Manfredonia — Si rivedono le bucce agli antichi amministratori — Bilancio esposto al pubblico — Tumulto nella festa dell’ Iconavetere — Uno scapatello troiano — Il fuggi fuggi — Schiamazzatori per le vie — Maltrattamenti al comandante della provincia — Dragoni puniti ed escarcerati—Espulsione del comandante—Intimazione a Sellitti — L’intendente mette in salvo il proprio cuoio — Chiusura del Corpo di guardia della gendarmeria — I gendarmi ad Eboli — Comizii differiti — Partenza di truppe contromandate — Il sotto-intendente di Sansevero a Foggia — Violenze contro funzionarii — I pifferi di montagna — Il duca di Bagnoli richiama i domestici — I figli del Mago — Pietro De Luca ff. intendente — Suo saluto agli amministrati — La guardia nazionale e l’ordine pubblico — De Plato e Postiglione — Tentativo sventato di un governo provvisorio — Cesare ed Achille De Martinis — Flores respinge le offerte dei liberali — Sfruttatori di occasione — Il figlio di Antoniella F ombrellaia — Estorsione al marchese Gimaglia — Arresti — Flores con la sua colonna devia per Ordona — I dragoni liberali — Stemmi annientati — Antonio Gargea — Francesco II a Gaeta — Ultimo addio al popolo — Liborio Romano e Garibaldi — Entrata a Napoli del dittatore — Bacio simbolico di d’ Ayala — Dimostrazioni a Foggia — Nastri tricolori — Preti e frati dimostranti — Al convento degli alcanterini — P. Massimo inalbera il crocifìsso —1 dragoni liberali tornano da Candela — Si rende loro il trionfo
— I primi decreti del dittatore — Saverio Altamura nella rappresentanza civica napoletana — Decreti di carattere unificatore — Altri decreti d’istituzioni liberali — Zuppetta e Garibaldi — Rinunzia del primo a formare il Ministero — Zuppetta anima il partito di a-zione — Esce dalla vita, pubblica — Si consacra alla scuola — Foggia centro di arruolamento di volontarii — Caserme improvvisate — Filomena Pepe su’ balconi di S. Domenico — Volontarii calabresi e pugliesi — Loro entrata a Foggia — Sacerdoti in camicie rosse — Nomina di Ricciardi a governatore — Sua rinunzia — Energia del ff. governatore De Luca — Giuramento della guardia nazionale — Arrivo di Del Giudice e di Aolisio — Proclama di Vittorio Emmanuele — Annessione delle Marche e dell’ Umbria — Pubblica esultanza — Rifiuto del vescovo per una funzione in chiesa — Preti e chierici minacciati di sospensione — Si officia dai cappuccini in S. Domenico — Sermone di p. Giammaria — Beneficenze e luminarie — Vittorio Emmanuel’e a Teano — Telegramma comunicato in teatro — Insurrezioni in Capitanata — La guardia nazionale sul Gargano — Arresti — Passaggio di truppe — Reazione a S. Marco in Lamis e a S. Giovanni Rotondo — Garibaldini con cannoni — Razzie di veicoli — Eccidii — Francesco Cascavilla — Fra Domenico — Irretate di rivoltosi — Voluta convenzione a S. Marco — Consiglio di guerra — Difensori ufficiosi — Condanne.
— Plebiscito — Formula del Zuppetta’— Lista dei votanti — P. Boccaccini spiega il valore del sì — Votazione— Cassetta de’ no intatta — Scrutinio — Unanimità affermativa — Poggio Imperiale e Lesina non unanimi — S. Marco in Lamis e S. Giovanni Rotondo non votano — Pubblica esultanza — Marianna Gissi De Chiara — Lucia Salerai Rosati — Caduta della fortezza di Capua — Dimostrazione per le vie — P. Urbano arringa al popolo — Proclama di Vittorio Emmanuele da Sessa — Sua entrata a Napoli — Presentazione del plebiscito — Funzione alla cattedrale di Foggia — Discorso di Santaniello — Parte una deputazione per salutare il rè — Focolari di reazione — Foggia pari a Partenope — Si asside nei primi seggi dell’ Olimpo — Del Giudice collocato a riposo —” Giuseppe Beltrani — Pensiero ai poveri — L’intendente parte per Napoli — Eiezioni politiche—Manifesto del Circolo napoletano — Candidati per la Capitanata — Giuseppe Ricciardi candidato a Foggia — Liste degli elettori — Riunione dei comlzii — Votazione e scrutinio — Ricciardi deputato — Suo ringraziamento da Napoli — Sua visita agli elettori — Arrivo a Foggia — Al santuario dell’ Iconavetere — In casa di- Rose — Festeggiamenti — Incidente a teatro— Il delegato Tonti — Arresto del poeta Brunetti — I liberali protestano — Il governatore dà loro soddisfazione — Partenza di Ricciardi e suo novello ritorno — Ricostituzione del comitato liberale — P. Urbano presidente — Costituzione definitiva della guardia nazionale — Nomina del colonnello De Luca — Ulteriore scioglimento e riorganizzazione—Postiglione colonnello — Lamarmora la ridiscioglie — Diverso riordinamento — Nomina di Navarra a colonnello — È surrogato da Barone — Compiacimento di Orsini — La guardia nazionale spoglia di benemerenze— Indisciplinata e riottosa a combattere il brigantaggio — Voto municipale per la riduzione della legione – – Scioglimento definitivo di essa — Anticipate dimissioni di Barone — Suo bisticcio col sindaco dell’ epoca—Tramonto inonorato della istituzione — Nuove rappresentanze popolari — De Luca presidente del Consiglio provinciale — Il marchese Di Rose sinda¬co — Foggia spera in un avvenire.
— Brigantaggio — Francesco II re dei briganti — Guerra al nuovo ordine sociale — Scompiglio nelle classi cittadine — Provvedimenti di Cialdini — Il generale Focino — Inchiesta parlamentare — Relazione Massari — Flagello indomabile — Soldati al macello — Stragi e ricatti — Accuse di favoreggiamento — Vita lunghissima del brigantaggio — Particolari dal Giornale “patrio — Comitive in forme militari — Condottieri feroci — Lo Zumpo, Caruso, Coppolarossa, Crocco, Schiavone, Rinaldi, Vitullo, Pagliacciello .— Im¬perturbabili alle persecuzioni — Gesti nefandi ed inumani — I proprietarii divenuti schiavi —. Assalti a paesi e villaggi — Stornarella ricaccia la preda in bocca al lupo — Foggia minacciata d’invasione — Carceri ri¬gurgitanti — Fucilazioni —Esposizioni di cadaveri — Paolo Tarantino—Foschi episodii—Sospirato fine di quarantuno municipii — Ricciardi alla Camera subalpina — Movimento cittadino — Risposta di G. De Leonardis all’ anonimo lucerino — Si ripiomba nell’abbandono — Concessione derisoria di un Circolo di Assise.— Importanza ferroviaria e non commerciale — La direzione compartimentale dei telegrafi — Protesta della cittadinanza — Abolizione del contenzioso — Il tribunale di commercio — La direzione delle gabelle, e del demanio e tasse- -L’ orfanotrofio minacciato di trasloco — Dimissioni del consesso civico — Scuole elementari — Abolizione delle cattedre universitarie — Il collegio degli scolopii e il liceo-Lanza —Scuole magistrali, asilo infantile e scuole tecniche — Istituto di civili fanciulle — Consunzione della Società economica — Sue benemerènze — Soppressione del monachismo — Chiostri e monasteri — Discrepanza di opinioni — Esodo di frati e di suore — Biblioteca comunale — Suo incremento e restaurazione—Decoro e lustro civico
— Tra volgimento delle rivoluzioni —Creazione di martiri — Cittadini boicottati — Persecuzione a funzionarti e ad ecclesiastici — Visite domiciliari, arresti, domicilii coatti, violenze — Al convento dei cappuccini—Al conservatorio di s.a Teresa — Ulteriori persecuzioni politiche — Monsignor Frascolla proces¬sato con Chiulli — Condanna di entrambi — Partenza del vescovo per Como — Grazia a Chiulli — Periodo di bufera pe’ foggiani — Amnistia — Ritorno del vescovo Frascolla — Sua malattia e morte — La plebe instigata e imbaldanzita — P. Domenico da Sannicandro — Atti vandalici contro Uomini e cose.— Tentativi di repressione — Allarme generale — Divieto ai quaresimalisti di far prediche — Vincenzo Celentano dimissionario — Antonio Sorrentini in disponibilità – – De Plato e Granata consiglieri dr intendenza
—- Foggia sotto il nuovo regime — Rinnovellata circoscrizione della provincia — Nessuna riparazione pel tribunale — Inutili voti — Petizione al Parlamento di quarantuno municipii — Ricciardi alla Camera subalpina — Movimento cittadino — Risposta di G. De Leonardis all’anonimo lucerino — Si, ripiomba nell’abbandono — Concessione derisoria di un Circolo di Assise — Importanza ferroviaria e non commerciale — La direzione compartimentale dei telegrafi — Protesta della cittadinanza — Abolizione del contenzioso — Il tribunale di commercio — La direzione delle gabelle, e del demanio e tasse–L’ orfanotrofio minacciato di trasloco — Dimissioni del consesso civico — Scuole elementari — Abolizione delle cattedre universitarie — Il collegio degli scolopii e il lieeo-Lanza — Scuole magistrali, asilo infantile e scuole tecniche — Istituto di civili fanciulle — Consunzione della Società economica — Sue benemerenze — Soppressione del monachismo — Chiostri e monasteri — Discrepanza di opinioni — Esodo di frati e di suore — Biblioteca comunale — Suo incremento e restaurazione—Decoro e lustro civico .
— Cinematografia al palazzo della dogana — Il conte Bardesono — I primi carabinieri e le prime guardie di P. S. — I facinorosi contro le pattuglie — Tumulti — Un ribelle ferito — Panico cittadino — La milizia nazionale abbandona il posto — Bardesono a passeggio —. Fuoco a S. Domenico — Azione di rigore — Processi — Quis custodii custodem?— Pacificazione — A Vico e a Cagnano — Minaccia d’invasione di reazionari! — Truppe sul Tavoliere — Il nuovo prefetto Strada — Aspettativa frustrata — De Plato lo ingiuria e viene destituito — Del Giudice ritorna al palazzo della dogana — Promesse energiche contro il brigantaggio — Vien nleno alla prova — L’azione militare si esplica da sé — Foggia in istato di assedio — Poteri nel comandante della provincia — Il prefetto spodestato — Suo esonero dalla carica — Il prefetto De Ferrari—Suo carattere autoritario — Perquisizioni, arresti, destituzioni — Sospetti di relazione coi briganti — P. Urbano al potere giudiziario — Lotta per rifazioni al palazzo prefettizio — Soppressione di giornale — Dualismo col municipio — Eccitamento ad una divisione di partiti — Sfida ai liberali — Protezione al sindaco La Stella — Il prefetto Gadda — Sua azione contro il colera — Fuga e destituzione del sindaco —Scelsi prefetto — Partito nazionale — Facilitazione ai contribuenti — Malusardi — Incremento all’ agricoltura – Comizio agrario — Mostra industriale — Premiigli espositori — Mancanza di tatto del prefetto — Pubblica ammenda — Nomina di Solinas
— Lorenzo Scillitani — Sua prima nomina a sindaco — Nugolo di avversari! — Minacce anonime — Invito del re ai sindaci — Scillitani ad Ancona — Atto protestativo — Sua insussistenza — Rigetto — Scillitani si dimette — Risale di Rose — Scioglimento del Consiglio — Il r. commissario — Sindacato La Stella —Sindacato Scoccherà—Scillitani rinominato sindaco —Sua strepitosa maggioranza — Trasformazione della,città — Spazzamento — Inaffiamento — Pavimentazione di pubbliche vie — Prolungamento del corso S. Antonio abate — Alberazione al largo Gesù e Maria —Demolizione dell’ arco di Portano va — Abbattimento di casupole — Monumento a Lanza — Offerta di suoli edificatorii — Pianta gratuita per mercati— Circolo Dauuno — Inaugurazione di esso — Sala all’ ospedale pei poveri di Foggia — Nascita del principe di Napoli — -Ricovero Regina Margherita — Elemosine —Facilitazioni a’ piccoli proprietarii — Libretti di Cassa di risparmio — Gettone del Banco di Napoli — Difesa deli’ orfanotrofio — Contro le Banche usurane —Contro i sistemi fiscali governativi — Esposizione ippica — Impulso alle scuole — Medaglia di benemerenza per la pùbblica istruzione — Rivendicazione di fabbricati e di rendite — Biblioteca popolare —- Illuminazione a gas— Campana della madonna—Importanza della campana — Somma per rifarla — Nel dì del resurrexit —Scillitani monito ed esempio — lì nocciuolo della popolarità
— Vita cittadina in ogni epoca — Brio di metropoli — Al tempo degli svevi, degli angioini, degli aragonesi, dei borboni, dei napoleonidi — Ferdinanndo II alla fiera di maggio — Visitatori illustri — Giovanni Paisiello, Saverio Mercadante, Giuseppe Regaldi, Giannina Milli, P. P. Parzanese, Rosa Taddei, Francesco Meterangelis, Saverio Baldacchini, Niccola Sole, il marchese di Montrone — Vittorio Emmanuele II. e i principi di Savoia festeggiati clamorosamente a Foggia —Onorificenze a foggiani — Guerra del 1866 — Folla di camicie rosse — Canti patriottici — Foggia grande caserma — Giovanni Nicotera — Menotti Garibaldi —Dono di camicie rosse — Entusiasmo pei fatti guerreschi — Pel 4.° squadrone dei lancieri di Foggia —Medaglia commemorativa — Cordoglio per Lissa — Il dottor Nigri va a curare i feriti — Lagrime e prove di patriottismo — Foggia inneggia all’ annessione del Veneto col lutto nel cuore.
Precipitanza di eventi politici —L’antico voto acuito — Il ré nel Parlamento — A Roma, a Roma — Partiti accentuati — Cavourriani e garibaldini -— Comitato di azione — Congiure, dimostrazioni, insurrezioni— Il prefetto in angustie — Il municipio di Foggia contro il potere temporale — Proclama reale — Telegrammi ministeriali — Le truppe varcano la fron¬tiera— Calma nelle popolazioni — l comitati sfidano le ire del governo — Comitato anticlericale foggiano — P. Urbano — Abbasso il papa-re — P. Grilli —- Vigilanza dell’autorità — I maggiorenti del comitato —Sua violenta chiusura — Proteste — I liberali tenuti di mira — Timori prefettizi! — Terzo anniversario della entrata di Garibaldi a Napoli — Consegna di truppe in quartiere — Dimostrazioni — L’ effigie dell’ eroe in giro — Tumulto —Vecchio comitato ricomposto — Vigilanza della P. S. — Postiglione e De Plato piantonati — Preoccupazioni del governo — Processione del venerdì santo — Vietti e Del Vecchi — Beffe al predicatore — Finimondo — Un fantaccino acciuffato — Ritorno alla calma — Chiese chiuse — Arresti in quartiere— Continuano le paure — Meeting contro le tasse — Carelli e De Nittis — Inutile apparato di forze — Dimostrazione per Mazzini — Il prefetto redarguisce il ff. sindaco — Il popolo amico dell’ordine — Cordoglio per la malattia del re — Bollettino sanitario — Passaggio di Umberto e di Amedeo — Affettuose acco-glienze — Pericolo di vita scongiurato — Manifestazione di gioia ad Umberto ed al re — Festa scolastica — Dimissioni di Ricciardi da deputato — Scillitani candidato — Di Rose e Fioritto lo combattono — Questione di campanile — Trionfo di Scillitani — Il popolo lo acclama — Dimostrazione ostile a Fioritto — La città festante — Sentimento di gratitudine — Ultima tappa della rivoluzione — Napoleone a Sédan —Unità di patriottismo dei foggiani — Marcia su Roma — Breccia di porta Pia — Telegrammi per la presa di Roma — Giubilo universale — Conclusione .
Causa e finalità del libro
Ferdinando Villani, mio padre, che scrisse dei Cenni storici, su Foggia e che sono ormai rimasti come unica fonte più vasta, ove possa attingersi notizia di tutto un passato della nostra città, arrestava il suo volume all’anno 1848, epoca nefasta di rivoluzioni, di slealtà, di spergiuri, e conchiudeva con queste parole che nella loro interezza riproduco: ” E Qui ben m’avvedo d’essere già pervenuto a tempi recentissimi, che possono dirsi appartenere all’età nostra. Dovrei discorrere dell’epoca del 1848, dei tempi posteriori e di quant’altro avvenne in Foggia d’allora in poi, accennando ad uomini e cose indistintamente. Ma io non intendo scrivere la storia contemporanea del mio paese. I concittadini, che mi leggeranno, furono testimoni anch’essi degli avvenimenti del 1848 e dei fatti ulteriori che succedettero sino all’era delle ultime riforme. Gli è perciò che porterei frasche in Vallombrosa se perdurassi nel mio racconto. Bisognerà riservare il resto all’opera dei posteri; e bene a proposito ricorderò col conte Balbo che la storia è la scienza del passato e che essa deve arrestarsi all’epoca di chi scrive o, per dir meglio, conviene che si sofferma prudentemente prima dei tempi da lui vissuti. Il discorrere di questi e polemica non più storia. Tempi che non sieno di parti, soggiunge lo stesso Balbo, io non ne vidi nel genere umano mai; e se ne furono talora in alcuni paesi, ei fu forse difetto delle storie che ne tacquero o dei paesi che non entrarono nel parteggiare ed oprare perenne del genere umano. Così il mio impegno è compiuto e la promessa è sciolta .”
Comincio io, quindi, mia narrazione dal punto preciso ove fu interrotta da lui. Io lo fo più volentieri, incoraggiato all’uopo da amici carissimi ansiosi di veder illustrata vieppiù nella storia la terra che mi dette il soffio soave della vita.
E in cui mi piace ricordare che chiaro professore Consalvo di Taranto, in un suo recente pregevolissimo lavoro su la Capitanata nell’anno 1848, ebbe a darmi anche lui cortese spinta per tale pubblicazione, col dire: ” Un diario riguardante la città di Foggia possiede l’avvocato Villani, e io me ne sarei avvalso se quel galantuomo non avesse in animo di pubblicarlo per conto suo come ricordo di famiglia.Voglio augurarmi che presto veda la luce, potendo essere di completamento al mio lavoro. Forse egli, tardando a renderlo di pubblica ragione, teme di suscitare un vespaio intorno a se, incorrendo nei risentimenti di taluno che discende da borbonici sfegatati ed ora, mutati i tempi, si atteggia a grande liberale? Io penso che narrando gli avvenimenti quali si svolsero, senza spirito di parte, nessuno abbia a risentirsene. I fatti della storia sono di pubblico demanio, e, dopo circa sessant’anni, deve pur prevalere la serenità d’animo e l’equità della mente nel valutare quanto hanno compiuto o fatto nostri nonni. “
Infatti, io posseggo questo diario, battezzato col nome di Giornale patrio, e che fu redatto con costanza quotidiana, dai miei antenati, a cominciare dall’anno 1799, dopo un breve cenno della dimora in Foggia di Ferdinando IV con Maria Carolina d’Austria e i principi Francesco. Leopoldo ed Alberico, loro figli, per incontrarsi quivi con S.A.R. l’arciduchessa Maria Clementina, fidanzata a Francesco, principe ereditario, sino a venire, giù giù ai tempi nostri.
Forse avrei dovuto pubblicare integralmente questo giornale compilato con anacoretica pazienza e senza alcuna vanità o pretensione, scritto cioè alla buona e talvolta fors’anche, direi, in forma patriarcale, il che rispecchia, soprattutto, la semplicità di coloro che ne furono gli autori; ma ho creduto meglio di non farlo non certo pel motivo innanzi sospettato dal Di Taranto, perché so pur io che la storia
……… libro che il preterito rassegna,
chiamata perciò da Federico Schiller tribunale del mondo e irresponsabile innanzi a tutti, come nessun è responsabile innanzi alla storia ma per due salientissime ragioni:
1) perché da esso già fu tolto da mio padre per la sua Nuova Arpi ogni notizia interesse pubblico, e quindi utile per la storia da nostra città fino all’epoca in cui egli scrisse:
2) perché a dir vero sarebbe riuscito in taluni punti noiosissimo e di nessun pregio leggendosi pagine intere ora sul colore del tempo, ora sull’apparizione di una cometa, ora su funzioni liturgiche, ora finalmente, su meschinità di cronaca locale, da non destare addirittura curiosità qualsiasi in chicchessia.
Mi è stato però un tale manoscritto, se non di ricca, di assai buona scorta lungo la mia narrazione, sicché io peccherei di sincerità se non dessi a Cesare quel che è di Cesare mettendo in mostra il faticoso lavoro dei miei avi.
E perché non si possa per avventura tacciare anche me di voler forse polemizzare di straforo coi miei cittadini contemporanei. ed atteggiarmi a critico delle loro pubbliche funzioni, dal che rifuggo e per intimo sentimento e per un conveniente riserbo, soffermo questa mia cronistoria ad un’epoca alquanto lontana da noi, all’anno memorando 1870 in cui può dirsi si sia compiuto veramente l’ultimo ciclo della nostra rigenerazione politica.
Così facendo, mentre ho reso omaggio alla memoria dei miei maggiori, ho cercato di portare altresì il mio modesto contributo al fastigio ulteriore della mia città, che, regina in un antico evo, rifulse sempre del pari nei tempi nuovi, dispensiera e ministra anch’essa di civiltà e di progresso,e che se talvolta mostrò di non amarmi, non mi cancellò, per altro, dal cuore il solco profondo che vi segnava col suo nome, d’un primo ed immutabile amore.
Napoli Ferragosto del 1912
Carlo Villani
I
Diventato rivoluzionario il movimento italiano, rimasto ovunque riformista insino al 1848, doveva esso divampare finalmente da un momento all’altro presso di noi, senza che il Borbone potesse più arginarlo, costretto invece, suo malgrado, di far buon viso a cattivo giuoco. E fin dal dodici gennaio di quell’anno, data ormai impressa a caratteri d’oro negli annali napoletani. Nella cui sera , al teatro San Carlo, si videro lanciare da un palchetto di sesta fila un colombo ed alcuni uccellini con nastri tricolori al collo, tra gli evviva e i battimani del pubblico,Ferdinando II, impettito innanzi al parapetto del palchettone reale, abbozzando sulle labbra un sorriso, ch’era invece contrazione di sdegno e di dispetto, ben ebbe a comprendere che l’assolutismo della sua casa trovavasi alle supreme ore.Sollevata Sollevata quindi Palermo,il Cilento in fiamme, caduto a Napoli e scacciato il Del Carretto,ridonatosi al partito di azione dell’epoca il vero naturale duce nella persona di Carlo Poerio, allora allora uscito dalle prigioni, presentatasi finalmente,con una dimostrazione imponente di popolo, la nota petizione al re per ottenere una forma di governo costituzionale rappresentativo, Ferdinando,preso da brividi di paura, dovè cedere di fronte all’incalzante torrente, e, dimettendo il vecchio Ministero,mostrò di atteggiarsi, senza alcun preavviso, a sensi generosi di libertà, e di soddisfare così il voto dei popoli, salvo a far rivivere i perfidi infingimenti del suo degno avolo, e a ricacciare nel nulla, con l’astuzia e con la violenza, le concessioni strappategli.
In quel torno di tempo giaceva in grembo a grave iattura la nostra Foggia: – tra due grandi malanni essa si dibatteva tuttodì: la miseria e l’epidemia del grippe. Le piogge copiose,che da mesi non avevano fatto mai sosta, le forti nevicate e il freddo intensissimo quasi avean distrutto in taluni siti,specialmente verso l’Ofanto, le innumerevoli e pingui carovane delle pecore, che rappresentavano, oltre all’agricoltura, la più importante industria dei naturali del luogo, i quali perciò, ben potevano dire di sé con frase biblica: Agricultores et pastores ovium sumus, et nos et patres nostri. Non vi era momento quindi, in cui non si deplorasse un disastro or per l’uno o per l’altro di quei proprietarii, messi così tra l’uscio ed il muro, senza sapere a qual santo o a qual demone votarsi in cerca di uno scampo. E, per soprassello, si era scatenata su tutto il Tavoliere un’infezione di grippe in forma si violenta e micidiale, che la maggior parte dei colpiti, sieno vecchi, sieno giovani,sieno fanciulli, era presto,in soli tre giorni, spacciata e messa in viaggio per Acheronte. Fra tanto avvilimento, si morale che materiale, a nulla il governo aveva mai pensato per venire in aiuto specialmente della nostra città, ridotta in si dure condizioni, nulla aveva fatto per lenirne le piaghe, tranne che l’irrisoria concessione o meglio l’elemosina di un meschino ribasso sul presso del sale, che,da grana dodici per ogni rotolo, veniva ridotto a grana otto. Ecco il grande, il munificente atto paterno dei governanti,….nemici, in realtà, dei propri governati.
Pure in mezzo a così gravi pubbliche contingenze, un’estesa azione rivoluzionaria alimentatasi nell’ombra chè animi frementi di amor patrio, stanchi di più tollerare l’asfissiante servaggio, potevano contarsi a mille a mille in quella terra, ardente del bacio più fervido del sole, e, segretamente affratellati coi liberali delle altre città del regno, non aspettavano altro che il segnale per irrompere come un sol uomo ad annientare il dispotismo e a piantare sui ruderi l’albero della libertà, Ed essi appartevansi ad ogni gradazione sociale, perché, con savio consiglio, coloro che avevano una certa superiorità sugli altri o per intelletto o per averi ovvero per nascita erano riusciti a guadagnare alla buona causa grande parte degli umili. Fu per questo che il 21 gennaio 1848, vistisi apparire – come avveniva di consueto – su per le cantonate della città,dei proclami incendiarii, inneggianti alla indipendenza ed alla riforma italiana.alla rivoluzione ed a quel Pio IX, che, dopo aver benedetta l’Italia, la mandò a farsi benedire, furono arrestati un venditore di commestibili ed un caffettiere, di cui duolmi ignorare i nomi, sospettati entrambi di complicità nelle clandestine affissioni.
Imperava a quell’epoca sulla provincia di Capitanata, quale intendente, il cav. Domenico Antonio Patroni, un accorto funzionario nativo di Foggia, il quale, come tutte le autorità del tempo, ostentava, un po’ troppo, purità di costumi e soggezioni alle leggi non solo della morale, ma della Chiesa, due cose che servir doveano di falsariga agli amministrati, educati così ad adottare, quali che fossero le loro convinzioni, metodi addirittura da sepulcra dealbata, come van detti gli iporiti dalla sacra Scrittura. Il parere insomma consideratasi più che l’essere, onde la qualità di baciapile stimavasi a priori garantia di rettitudine, nonché di pecorina obbedienza, senza che niuno venivasi poi preoccupando di ciò che veramente esistesse in chicchessia sotto la docile parvenza di santità.
Eppure i malevoli ebbero, per un momento assai fuggevole, a mormorare su d’una pretesa leggerezza o di un facile abbandono di lui, ripetendo quel quandoque bonus…..del Venosino, fors’anche a torto, perché egli dignitosamente riaffermava poi, senza frapporre tempo, la sua normale costante, inflessibile serietà di carattere e rigidezza di condotta. Trionfava, da parecchie sere, sulle scene di quel .teatro Ferdinando, più che per la sua arte,perché recitava nel ruolo di terza donna, per la sua bellezza statuaria la signorina Olimpia Verlej, figlia naturale d’un marchese Palmieri, datasi all’arte del canto per rovesci finanziarii. Il Patroni se ne innamorò, e le male lingue cantarono allora,in mille toni, di aver vista la bella Verlej insediata clandestinamente nelle più intime stanze del palazzo dell’intendenza anche prima che si chiamasse Olimpia Patroni. Perché l’intendente il ventiquattro di gennaio, la sposò sì col rito religioso che col civile, e, sposandola fece il becco alle gracchianti oche.
Chiudendo, quindi, la breve parentesi, è d’uopo dire che il Patroni con ogni mezzo vegliava affinché l’ordine pubblico non fosse turbato dagli spiriti accesi e, pur facendo le viste di non preoccuparsene, non li perdeva d’occhio un istante solo.
Anzi dovette talvolta secondare, senza frapporre ostacoli, ogni movimento popolare, specialmente quando, emessosi il decreto che poneva la stampa sotto la sola dipendenza del Ministero della pubblica istruzione, condarsi piena facoltà di pubblicare scritti su qualunque tema e di stampare periodici politici mercè la semplice restrizione di una cauzione, ed emessosi altresì il decreto di indulto per gli arrestati politici, ne giunse in Foggia, col corriere del dì appresso, la lieta novella.
Nella lunga flagranza delle rivoluzioni ogni fuoco fatuo pare un sole, ogni meteora un alba, ma, innanzi a codesti due fatti ,l’entusiasmo dei foggiani non poteva, invero, non uscire dall’orbita e spezzare ogni freno, scorgendosi in essi i prodromi di un avvenire, ch’era la realizzazione di un sogno, indarno fino allora carezzato. Tolto dalle labbra il nottolino, la parola libera, limpida e pura come acqua sgorgante dalla fonte, ridiventata la vera rivelatrice del pensiero – concessa la facoltà di poter discutere direttamente della cosa pubblica, delle questioni vitali del paese e dei propri diritti, non poteva di fronte a tutto questo, che indicava di essersi pervenuti alla vigilia di un evo perfettamente nuovo, rimanersi indifferente, come non rimase, infatti ogni animo assetato di libertà, o meglio….di dignità umana. Avrebbe forse tuttavia nicchiato l’intendente, se uomini risoluti non avessero, da quel primo dì, mostrato che non vi era altro tempo da aspettare per aprirsi alle masse ignoranti senza più alcuna riserva o sottintesi. Cominciarono allora, per conseguenza, e continuarono indisturbate le pubbliche arringhe tribunizie; proclami su proclami impiastricciarono senza posa le mura delle case private e dei pubblici edifizi, opuscolo e fogli volanti, giorno e notte, fecero per sè gemere i torchi, come altresì un primo gazzettino locale si senti gridare per le vie dagli strilloni, la cui permissione quasi s’impose all’intendente da un Carmine Durante, da un Gaetano Tanzi e da un Luca Pece, da un Felice Patierno, e alla cui avanguardia, in verità assai battagliera, tenne dietro, dopo assai tempo, altro giornale costituzionale moderato, presosi a compilare dai fratelli Luigi e Achille Moltedo, col semplice intento di rendere comune al popolo le nuove idee politiche, e che assunse a titolo: Il Cittadino.
L’indulto, d’altra parte, che aveva, con Carlo Poerio, aperti i cancelli delle prigioni di Stato a parecchi altri atleti della libertà, aveva pure infranto i ceppi di un cittadino foggiano ,di Saverio Altamura, giovane artista, che dava bellamente a sperare di sé, e che dovea poscia addivenire fulgida gloria della pittura italiana, nonché vanto e decoro della nostra terra,. Questi, che noni avea commessa altra colpa, in quei tempi subdoli di paure e di sospetti, se non di aver gridato con gli altri ” Viva Pio IX” frase simbolica di redenzione, si guadagnò dal tiranno, in premio del suo facile suggestionarsi….la galera. Seguiamone, intanto la narrazione fattane da lui stesso in quell’aureo libricino, cui mise nome di Vita e Arte, e che racchiude tutto un brano di storia intensa, vissuta, e interessante non poco per chi si pasce di ricordi:
” Ero – egli scrive – per la prima volta in Roma. Un giorno, traversando Trastevere per far ritorno al mio Studio, che fiancheggiava quel gioiello di palazzo che è la Farnesina, udii due vassalli romani, che, discorrendo fra loro dicevano : toh sai ch’è morto er sor Gregorio? Codesto sor Gregorio era nientemeno che Papa Gregorio XVI. Lasciò questi fama di gran bevitore, sicchè corse allora per le vie di Roma un motto di Pasquino, che cioè, picchiando il detto papa alle porte del paradiso ed avendogli il portinaio San Pietro domandato del nome, ed avendolo egli declinato, il santo tornò a chiedergli se fosse Magno. Al che il nuovo venuto rispose: no son Gregorio Bevo. Tutti sanno che, dopo la morte del papa, i cardinali si chiudono in Quirinale per scegliere il successore, e la sera si va a vedere la fumata. Dopo qualche giorno si seppe che il nuovo papa era stato eletto, e si andò tutti, io con gli altri, ad acclamarlo. Lo si volle al balcone, e , dopo molto aspettare, si vide per le cento finestre del palazzo passare un lume, e finalmente si aprì il verone ed il nuovo papa salutò e benedisse. Fu allora che da quelle migliaia e migliaia di petti eruppe quel grido di “viva Pio IX, che per molti anni suonò in Italia grido di redenzione, di libertà e di indipendenza. Gridai con gli altri, e scagli la prima pietra chi non ha gridato in quell’epoca; Viva Pio IX.
L’eco di questo nome mi seguì in Napoli, dove feci ritorno;ed una sera, stando riuniti nel caffè de Angelis con Achille Vertunni, Diomede Marbvasi, Camillo deMeis, Luigi La Vista, e ,raccontando io loro con giovanile calore i fatti di Roma, le speranze liberali, gli entusiasmi del popolo, inconsciamente eruppe lo stesso grido dai nostri petti ,e, ponendoci alla testa di una folla di popolo, percorremmo la via di Toledo fino alla reggia. Così fu ripetuto per molte sere, con la folla sempre più crescente, finchè la cosa non increbbe al re; ed una sera ci venne sbarrata la via presso il largo s.Ferdinando da truppe,uscite dal palazzo reale; si fecero varii arresti, ed io fui del bel numero uno.
Nel carcere di S. Maria Apparente, dove fui condotto, devotamente baciai i miei compagni di prigione, ch’erano Carlo Poerio, Maianod’Ayala, il duca di Sandonato ed altri, e da essi e con essi cominciò il mio tirocinio politico. Alessandro Poerio, fratello di Carlo, e che poi morì combattendo a Venezia, nelle sue visite ci rinfocolava gli spiriti con le sue poesie, calde d’amor di patria e di speranze. Conobbi il quell’occasione il bravo generale Roberti, comandante il castello S:Elmo, e feci i ritratti di qualcuno dei miei compagni di carcere con la luce che si rompeva a quadrati sull’umido pavimento. Dopo qualche tempo uscimmo col trionfo dei nostri voti, avendo il re accordata la Costituzione ed indetta la guardia nazionale, nella quale mi arruolai. Passato il pericolo di essere arrestato gridando per le vie, lasciai gli altri gridare per chiudermi nello Studio e riprendere il mio lavoro.”
La notizia di un tale indulto, dunque avea destato in Foggia del pari il più grande entusiasmo. Come a Napoli, dove,dopo il mezzodì del 27 gennaio, una folla delirante portava in trionfo gli scarcerati, messi su d’un carro, sormontato da un grosso gonfalone tricolore e preceduto dal nostro vecchio e venerando concittadino foggiano Saverio Barbarisi, altra fulgida stella del nostro firmamento rivoluzionario-politico, così in Foggia una calca brulicante, mettendo in non cale le sue attuali traversie economiche e sanitarie, e rianimandosi d’una novella vita, a guisa di un fiore che,con sollevare il reclinato capo dallo stelo, si riapre alla rugiada mattutina, invase le pubbliche vie con fremiti non mai visti, con clamori non mai uditi. E quasi come il pellegrinaggio, si conduce sotto i balconi della modesta casa ove nacque Saverio Altamura, in quella storica piazza Pozzo rotondo,che non già opera di uomo, ma semplice forza di tradizione ricorderà sempre da sé alle postume generazioni essere stata un tempo il gran cortile del palazzo imperiale degli Hohenstaufen, come ricorderà del pari che a quel pozzo, ergentesi in allora nel mezzo di esso, e che da poco vandalicamente andò spezzato fin nelle ultime vestigie, venivano i cavalieri, reduci dalle giostre e dai tornei, ad abbeverare i loro cavalli stanchi ed ansimanti. Quivi, tra l’unanime e vivissima commozione,s’improvvisarono quel dì concioni calde di fede e di amore, quivi s’intuonarono inni patriottici, quivi si gridò per la prima volta, con canne spalancate, da mille e mille ardenti: ” viva la libertà “.
L’intendente Patroni, come ho già accennato, lasciò fare senza porre difficoltà e limitazioni di sorta:- certo la sua condotta veniva inspirata da una necessaria prudenza, figlia di ponderato calcolo, e non già perché si sentisse colpito dal raggio di luce sulla via di Damasco, condotta oh quanto dissimile da quella tenutasi dal generale Statella, governatore di Napoli, lo stesso dì in cui il carro trionfale degli escarcerati percorreva la via Toledo, quand’egli in mezzo ad una scorta di appena undici usseri a cavallo,non per paura ma per profondo sentimento, inibiva che la guardia civica e gli svizzeri si opponessero alla solenne manifestazione popolare, e che anzi offrivasi mediatore tra il popolo ed il re, accettando di presentare di sua mano a costui il voto della nazione.
Mutato poscia il vecchio Ministero in quello presieduto dal duca di Serracapriola, e di cui venne a far parte Francesco Paolo Bozzelli per l’interno,l’esultanza dei foggiani si tramutò in vero delirio, giacchè l’avvento a potere del manfredoniano Bozzelli, cldissimo patriota del 1820, rimasto in esilio per diciotto anni e incarcerato nel 1844, vecchio amico di Guglielmo Pepe, sino allora rimasto a capo del comitato dirigente rivoluzionario napoletano, si estimò come la migliore delle garentie per un regime lealmente liberale. Non sospettarono però gli illusi, come nol potette 1′ universale, qual fedigrafo addivenisse costui e di quale azione nefanda e traditrice potesse un dì essere capace. Ma bene, invece, Ferdinando II, esperto nella conoscenza degli uomini, come nota Giorgio Weber, aveva intuita 1′ ambizione, la superbia, 1′ avidità di danaro, di cui era ricolmo l’animo di lui, e seppe soffiarvi “sopra e fecondare queste male passioni in guisa da convertirlo subitaneamente in docile istrumento di tirannide.
Il giorno trentuno di gennaio, per ordine del Patroni, si vide affisso su per le cantonate della città il famoso Atto sovrano, datato da Napoli il ventinove dello stesso mese, con cui si concedeva la Costituzione, e puossi immaginare quale e quanta esultanza dovè questo suscitare negli animi di coloro che, vissuti per anni ed anni nelle più fitte ombre di un oscurantismo senza nome, vedevano finalmente e salutavano per la prima fiata, in ciascuna di quelle linee, l’irradiante luce be-nefattrice. Lo spettacolo, infatti, che dette Foggia, quel giorno, fu veramente nuovo nel suo genere, commovente e grottesco ad un tempo, perché non vi fu persona che, obliando ogni domestica cura ed ogni suo malanno, non fosse uscito, nell’ abbigliamento in cui trovavasi, dalla propria casa o dal proprio stambugio per correre là, ove un sillabo novello e stupefaciente chiamava tutti a raccolta, e per restarvi le ore intere col muso per aria a leggere, a rileggere, a commentare, a benedire quei lunghi lenzuoli di carta, su cui, a caratteri cubitali, il generoso Atto sovrano era disteso. Pareano tutti intontiti all’annunzio improvviso della largita Costituzione; quasi non si credeva ai proprii sensi, e si domandavano perciò 1′ un l’altro se fosse quella una realtà vera o fenomeno di luce ingannatore. Essi non aveano però la vista di Linceo il torriere ; ma se pure l’avessero avuta, rammenteremmo che anche questi fu soggetto all’errore e scambiò la bellissima Elena col sole. I poveri illusi, i quali non aveano mai letto negli astri, né nel volo degli uccelli, né nelle fumanti viscere delle vittime, finirono per credere che fosse stata annunziata in buona fede ai popoli la novella aurora, e ne gioirono dall’ imo del cuore,pur sapendo che niuno possa mai prevedere a questo mondo ciò che ne riserba il destino : unum scio, nos nihil scire.
Se, intanto, erano in Foggia già quasi tutti scomparsi gli avanzi di quella schiera gloriosa, che, sotto il nome di Carbonari, avevano compiuta la rivoluzione del 1820, spazzati chi dalle persecuzioni di una polizia feroce, chi dalla falce del tempo inesorabile, per prender posto nelle eterne pagine della storia quale esempio di virilità alle future generazioni, pur rimaneva un buon nerbo di fautori di libertà, ben degni dei caduti avi. E contavasi ancora, fra i ruderi della vecchia Carboneria, il settuagenario Agnello Iacuzio fu Giacomo, anima ardentissima, che fu poi presidente del comitato rivoluzionario, e che sentivasi fremere ed agitare nelle vene lo spirito bollente del suo congiunto Francesco Paolo Iacuzio, di colui che fu gran maestro dell’Ordine carbonaro e acerrimo pugnace per la Costituzione del 1820, quando il tre di luglio issava in Foggia pel primo lo stendardo nazionale sulla piazza Porta-reale, e quando fu dappoi autorevole componente il Senato della Daunia riunita (1). Non gli erano da meno un Giovanni de Anellis, ex-funzionante primo assistente nella 12.a Vendita dei Carbonari, un Tommaso del Conte, già direttore dei pubblici granai; un Francesco Paolo Vitale, stigmatizzato nei foschi registri della polizia quale liberale pericolosissimo ; un Michele Ricca, vecchio carbonaro anch’ egli, che fu educatore venerato di un’intera generazione al culto della libertà e della patria ; un Orazio Salerni, marchese di Rose, ormai settantenne, che nel 1779, di quattordici anni appena, propugnante le libere istituzioni insieme con suo padre, meritava da Casa Borbone una dura prigionia, e che, posteriormente, nel 1820, per avere spiegato in Foggia un drappo tricolore, venne condannato nel capo. E intorno ad essi si serravano come un sol fascio mille volontà risolute a sagrificare fin la vita pel trionfo di un’ idea, quali Nicola Sanna, Cannine Du-
(1) Questa suprema magistratura, i di cui membri furono : Francesco Paolo Caseitti di Lucera, gran presidente, Graetano Rodino, grande oratore, Giuseppe Tortora, gran segretario, Nicola Barone, gran finanziere, Francesco Paolo Iacuzio, gran guardabollo e suggello, pubblicò il dì 6 loglio 1820 il suo primo proclama con riconoscere Ferdinando I sovrano e capo della nazione napoletana, e con sospendere la leva, nonché con ridurre alla metà il peso fondiario, il costo del sale e delle carte da giuoco, i diritti e i dazii sulle dogane della provincia, come anche sul tabacco, lasciando di quest’ ultimo libertà a chiunque di farne commercio.
Villani — Cronistoria di Poggia
rante, Saverio Mucelli, Pietro de Piato, Orazio Sorge, Antonio Festa, Ferdinando Cipri, Nicola Mancini, Tommaso Tonti, Fer-dinando de Chiara, Gaetano Tanzi, Antonio Caso, Luigi de Noia, Felice Patierno, Luca Pece, Scipione Cafarelli, Saverio Tarantino, Francesco Severo, Giacomo de Maria, Vincenzo Barba-risi, Antonio Carelli, Gaetano e Giovanni Battista Postiglione, Domenicantonio Berardi, Raffaele Mirasole, il falegname Vincenzo Russo, il maniscalco Paolo Annecchino e tanti altri generosi, che man mano avremo occasione di ricordare lungo il corso di questa cronistoria. Ma qui non tralascerò di additare altresì, in ispecial modo, un Vincenzo Petrilli e, più di lui, sua moglie Paola Cassetta, sarta e modista, che fu accanitamente passionata di libere idee. Costei, nelle ore di ricreazione o di riposo, non si stancava di educare le menti delle giovanette, sue operaie, ali’ amore della libertà, e queste, alla loro volta, 1′ ascoltavano con attenzione e si sentivano trasportare dalla sua parola fervente in un orizzonte nuovo e paradisiaco.
Tutti, tutt’ insieme, dunque, costoro intorno al venerando Agnello Iacuzio si videro allora riuniti, con gli occhi imperlati di lagrime, al largo Portareale, ora piazza XX settembre, e si baciavano e si abbracciavano quasi fuori di sé stessi, dimenticando in un momento, nella piena dell’improvviso gaudio, le passate sciagure, i passati martirii, le cui immagini si diradavano e si dissolvevano come le dense nebbie della valle sotto la diffusa vampa del sole. E la folla, ebra anch’ essa di commozione, li circondava gridando « viva il re », senza che la grandezza di questa manifestazione di gioia fosse venuta a turbare neanche per un istante 1′ ordine pubblico ; perche lo squadrone dei lancieri e la gendarmeria, già sotto le armi, pattugliarono a cavallo e a piedi tutto il giorno per pura forma. Organizzatosi quindi un imponente corteo con simiglianti condottieri, si chiese e si ottenne che il sindaco, marchese Luigi de Luca, andasse ad invitare l’intendente, perché in loro compagnia si fosse condotto nella Basilica per intonarvi il Te Deum. A mezzogiorno, infatti, nel nostro maggior tempio, che ci regalò Guglielmo il Buono su di una cripta di Roberto Guiscardo, si videro affratellati ricchi e poveri, nobili e plebei, uomini di lettere e analfabeti, e, tra l’intendente,
Consiglio d’intendenza, il sindaco, il conciliatore, gli eletti della città, si notavano perfino gì’ infimi ed i più ignoti cittadini. Solo brillarono per la loro assenza il comandante delle armi della provincia coi suoi ufflziali per difetto di ordini superiori, nonché V intero Capitolo ecclesiastico, che disparve addirittura, senza avere avuto neppure il coraggio di mentire un qualsivoglia pretesto. Il che, forse, induceva posteriormente l’intendente a trasmettere al Ministero l’inesatta notizia intorno ali’ impressione prodottasi in Foggia dalla largita Costituzione, col dire ch’ essa era stata accolta con freddezza, che la maggior parte dei cittadini ne avea poco gioito e se n’era anzi addimostrata indifferente. L’ abate Antonio Russo, capo-sagrestano del Capitolo, fu il solo ch’ebbe il coraggio di rimanersi in chiesa a rappresentare i fuggiaschi colleghi, e fu quindi colui che, vestitosi dei paramenti festivi, intonava il Te Deum, e impartiva la benedizione tra il suono delle campane e le salve dei mortai. Dopo di che le autorità, circondate sempre da una folla plaudente e precedute da una banda musicale, fecero ritorno, a piedi, al palazzo dell’intendenza, ove si sciolsero. La sera vi fu gala al teatro con triplicata illumi-nazione, mentre in città splendevano di luminarie i palazzi del capo della provincia e del primo magistrato civico.
Venne quindi dal re promulgato lo Statuto costituzionale, fatica speciale del Bozzelli, che lo redigeva sulla falsariga dello Statuto francese, peggiorandolo. Stampato quindi e pubblicato l’importante documento su fogli volanti, come del pari nelle colonne del giornale ufficiale del regno, lo si vide,il quattordici di febbraio, tra mano di quanti foggiani sapessero leggere, abbandonandosi essi, in capannelli, ai più svariati commenti. \ enne improvvisata sul momento altra pubblica dimostrazione, che riempì la città intera di evviva al re e alla Costituzione, e si prese, intanto, accordo tra un comitato e le autorità di festeggiare pubblicamente il lieto evento. L’ apposita e scelta deputazione di gentiluomini del paese (1), coadiuvata anche dai parroci, prese a girare per la città, invitando ognuno a dare un obolo a tale scopo, obolo che oltrepassò nella misura le generali previsioni, e che lasciò un margine ben pingue di duecentocinquanta ducati per soccorrere i poveri. E, in
(!) La suddetta deputazione venne composta del sindaco, presidente, e dei signori marchese Tommaso Antonio Celentano, Francesco Buonfiglio, Pietro de Luca, marchese Saverio Celentano, Giovanni Battista Postiglione e marchese Luigi do Luca.
conseguenza, la città per tre giorni interi festeggiò il lieto evento con dimostrazioni popolari, con concerti di bande musicali, con Te Deum in chiesa e relativo sermone del vescovo Antonio Maria Monforte dei duchi di Lautrito, tolto per forza dal popolo alla sua dimora, nonché con maritaggi a donzelle povere, con veglione e gala al teatro, e fin con un carro trionfale, tirato a mano, recante l’immagine del re dall’aureola di un angelo argenteo in atto di annunziare al popolo la Costituzione, carro, circondato da un pugno simpatico di gentiluomini con ceri accesi, e che clamavano commossi al grande e generoso atto, quali Giambattista Postiglione, Domenicantonio Berardi, Raffaele de Chiara, Federico e Giambattista del Conte. E mentre Michele Ricca, 1′ eloquente avvocato e patriota, saliva, in una di quelle piazze, su di una panca per spiegare alle masse la Costituzione, a teatro Michele Achille Bianchi — un giovane ardente, letterato e poeta, che un dì corse anch’ egli, spronato da Cristina Trivulzio, contessa di Belgioioso, calda partigiana di libertà, a combattere su’campi lombardi contro l’Austria e a redimirsi di gloria (1) — mandava in visibilio il pubblico con una sua Cantata patriottica, rivestita di note dal maestro Giuseppe Romano, nonché con altre sue poesie inspirate e fiammanti, ch’ egli stesso porse, declamando dal palcoscenico, con un entusiasmo, di cui non si vide mai 1′ uguale.
Ebbero fine così il sedici di febbraio le pubbliche dimostrazioni di gioia nella città di Foggia (2), non scarsa, come vedemmo, di uomini dalla schietta fede liberale, di vecchio stampo, cui si aggiunse uno stuolo di giovani baldi e ardimentosi, quali Luigi Ricca, Vincenzo Luigi Bacillo, Francesco de Filippis, Antonio de Maria, Michele Albanese, Salvatore Modula, Giovanni Surdi, i quali, chi più chi meno, diventarono dei popolari tribuni in quei giorni di comune esultanza, per spiegare anch’ essi ai minimi, sulle piazze, i beneflcii incommensurabili dell’ Atto sovrano, che veniva a rialzare i destini delle Due Sicilie. Imitarono essi, in tal modo, l’esempio
(1) Col Bianchi vi andarono altri due giovani foggiani, Francesco de Filippis e Antonio Carelli, quale ultimo conquistava in battaglia il grado di alfiere.
(2) Intorno a questo periodo il signor Luigi Moltedo licenziò per le stampe un opuscolo dal titolo : Relazione storica delle pubbliche feste, celebrate in Foggia nei giorni li, 15 e 16 febbraio 1848 per la Costituzione conceduta ai suoi popoli dal re Ferdinando II°,— Foggia, tip. Fratelli Russo, 1848.
già dato dal canuto avvocato Michele Ricca, sul cui capo eran passate tutte le sventure di un’epoca luttuosa. Le pubbliche dimostrazioni, avvenute ad ogni pie sospinto, gli archi di alloro e di ulivo, sospesi sulle vie come a trionfo, l’entusiasmo spontaneo e non mentito di quella folla che si vide brulicare specialmente il quindici febbraio sulla piazza della chiesa matrice, genuflessa al suolo innanzi alla spera, luminosa come un sole, racchiudente nella sua luce il corpo del Signore e innalzantesi dall’ altare tra le mani del Pastore in segno di benedizione, mostrarono ad oltranza come seppe Foggia salutare il grande benefìcio avuto, come sentì potentemente l’impulso della libertà, scoppiato quasi fuoco etneo, e come ebbe la forza, ad un tempo, di soffocare nella memoria tutto un passato di menzogne, d’inganni, di umiliazioni e di sciagure. Non vi furono sugli occhi di tutti, lo vedemmo pur troppo, che lagrime di tenerezza, non vi furono sui labbri che accenti di laude e di plauso, non spuntarono nel cuore che gioie e speranze. In quelle dimostrazioni si ripercoteva l’eco di un primo grido di riforme civili e politiche, che fin dal 15 giugno 1846 si era già emesso dalle aule del Vaticano, inaugurandosi il pontificato di Pio IX,-grido, per quanto inaspettato, altrettanto spontaneo e generoso, e che fu estimato, in allora e dappoi, quale miracolo, che valse ad iniziare la indipendenza d’Italia.
Che se qualcuno mostrò allora di non far buon viso alla novella forma di governo, ben fu punito e tosto dal furore del popolo. Un di costoro fu il sacerdote Gaetano Maldacea, vicario generale della diocesi di Troia e rettore del seminario foggiano. Uomo intelligente e di soda coltura, ma nemico di ogni progresso civile e attaccato al dispotismo come ostrica alla chiglia, non sapeva egli darsi pace, vedendoselo, ad un volger d’ occhio, scappar di mano. Un retrogrado, dunque, della più beli’ acqua come lui, non poteva certo sottrarsi ali’ attenzione dei liberali ed al loro giusto risentimento. Nella sera del diciassette di febbraio, infatti, a tarda ora, un’ onda di popolo, guidata da Luigi de Noia, dal nomignolo « il terlizzese », perché figlio d’ un guardiano di Terlizzi, uno dei più bollenti di quell’ epoca, assalì la sede del seminario e ingiunse a colui di far fagotto, sotto pena della vita. AH’ improvviso assedio ed alla tassativa intimazione, fattasi da mille gole come ruggito di fiera, il Maldaeea, preso da terrore, cercò uno scampo negli angoli più remoti del palazzo, dove, col viso e con lo sguardo di chi abbia in bocca le tanaglie del cavadenti, cominciò a biasciare rosarii e litanie. Di ciò avvisato sull’ istante l’intendente, questi scaraventò addosso alla folla uno squadrone di lancieri a cavallo, che con una carica rapidissima, la sbaragliò d’ ogni parte, vuotando, in men che noi dica, anche le vie adiacenti. Ed un picchetto di essi rimase tutta la notte a guardia del seminario per tema si volesse dalla folla ritentare l’assalto ; e così ebbe campo il Maldacea di saltarne via per prendere asilo presso il vescovo, suo autorevole protettore. Ciò suscitò un più grave fermento nella cittadinanza, che nell’ atto del Maldacea, coadiuvato dal Monforte, scorse un’ aperta ribellione alla sua volontà, e risolse quindi di metter mano flnanco alle armi, se la cavalleria continuasse a garentire l’insensato ribelle. Per lo che il colonnello Statella si presentò al vescovo Monforte e gli parlò risolutamente, facendogli comprendere che doveva senz’ altro abbandonare al suo destino il Maldacea per evitare così un cruento conflitto tra la folla e la forza pubblica. Ma quegli, che non intendea distaccarsene, né, per la sua dignità, volea dar prova di sottomissione a chicchessia, preferì di minacciare fin di chiusura il seminario e fors’anche di totale abolizione, anzi che disserrare 1′ uscio di casa e metterne fuori il suo protetto. Informato il sindaco di tale inconsulto proposito, si recò egli immantinente dal Monforte con parecchi decurioni per protestare contro la grave minaccia e per fargli comprendere altresì che la città non dovesse aspettarsi un tale sfregio dal suo vescovo, il quale, anzi che aizzare vieppiù la rivolta, doveva invece, in ogni guisa, cercare di sedarla. L’ardito monsignore continuò tuttavia a battersi con la rappresentanza civica senza cedere d’ un passo ; ma, finalmente, vistosi tra muro e muro, non potè non abbandonare i futili pretesti di decoro e di convenienza fin qui accampati, e promise che il dì seguente avrebbe fatto allontanare da Foggia il Maldacea, pel quale richiese una scorta di sicurezza. Infatti, il trentuno di febbraio, a notte fonda, questi, accompagnato dal sindaco, dall’ insigne dottor fisico Bartolomeo Baculo e da un drappello di guardie, partì per Napoli.
Ottenuta così ampia e completa soddisfazione, il popolo foggiano tornò presto alla sua calma abituale, nonché alla gioia dell’ eccezionale e straordinario momento.
II
Uno dei primi pensieri del governo, presieduto dal duca di Serracapriola, fu di provvedere ali’ ordinamento della guardia nazionale, palladio di libertà pei cittadini nelle costituzioni politiche rappresentative. Sicché il dì 11 febbraio ’48 perveniva in Foggia all’ intendente una lettera-circolare del ministro dell’interno, con la quale, a formare una guardia provvisoria , furono date le istruzioni pel modo come in tutti i Comuni della provincia dovesse farsene gli elenchi, riducendosi anche a tale forma gl’istituti delle vecchie guardie urbane, che, in alcuni luoghi, trovavansi tuttavia in esercizio. I Decurionati presero ad occuparsi di tale lavoro col prescegliere all’uopo e proprietarii e professori di arti liberali e capi-operai ed uomini probi di qualunque condizione, tutti considerati ad una stregua, secondo i suggerimenti del governo. E perché gl’intendenti, per la disciplina di detta milizia provvisoria, erano stati altresì autorizzati a nominare un capo e dei sotto-capi, l’intendente Patroni nominava per Foggia a capo-guardia il signor Giuseppe dei marchesi Celentano, e, a sotto-capi, i signori Agnello Iacuzio, Michele Ricca, Francesco Sorge e Gaetano Postiglione. Facoltava egli, intanto, il sindaco di riunire il Decurionato per discutere, col suo intervento, della chiesta organizzazione. Perciò questo, il giorno dodici consecutivo, dopo rapida discussione, procedette, in presenza del Patroni, alla nomina di una Commissione di quattro decurioni, ai quali, sotto la presidenza del sindaco, fu affidato il mandato di compilare la lista di coloro, che, da’ venticinque ai cinquant’anni (limitazione di età, che con posteriore circolare veniva modificata nel suo punto di partenza con estenderla ai diciotto anni) avrebbero dovuto far parte della guardia nazionale provvisoria, riserbandosene l’approvazione finale prima che fosse spedita all’intendente. Il lavoro venne in due sedute totalmente espletato; e, ratificatasi quindi la lista intera, da renderla esecutiva, si aprì per la prima volta il Corpo di guardia di sì fatta milizia in un fondaco sotto il palazzo Celentano alla strada Portareale, e presero ser-vizio, il primo giorno, ben cinquanta scelti cittadini, comandati dal signor Giuseppe Celentano. E già parecchie pattuglie se ne videro quel dì istesso in giro per le vie, avvicendandosi coi lancieri e coi gendarmi pel mantenimento dell’ordine pubblico.
Intanto Ferdinando TI, dopo di avere promulgato lo Statuto, volle, a tranquillare gli animi ancora titubanti dei suoi sudditi, giurare il ventiquattro di febbraio, nella chiesa di s. Francesco di Paola in Napoli, la sua fede sincera alla Costituzione, convinto che il popolo non potesse credergli sulla sua semplice parola, e che il giuramento e non la sua probità gli impedisse di tradire la verità per 1′ avvenire. Quale meravigliosa fiducia in sé stesso !… Quanta onta alla propria onorabilità in quel giuramento !… E ordinò quindi che l’istesso dì, al1′ uscita dal tempio, sull’ ampio piazzale della reggia, le truppe alla loro volta, lui presente, avessero giurato di difenderla. Il che, avvenuto con ogni pompa, dovea ripetersi poi, successivamente, dagl’ impiegati nei loro diversi ufficii, come da tutta la guarnigione del regno.
Fu, perciò, che il ventotto febbraio a Foggia si riunirono, alle ore sette del mattino, al largo di Gesù e Maria, ora piazza Lanza, in tenuta di parata, la guardia nazionale, la gendarmeria reale e le guardie di onore di tutta la Capitanata, e quivi il colonnello Matteo d’ Afflitto, comandante le armi della provincia, dopo aver letto loro ad alta voce il r. decreto del 17 febbraio, in cui era segnata la formola sacramentale dei giuramento, giurò egli pel primo, e quindi invitò a giurare tutti gli altri, i quali, portando la roano destra sull” arma e levandola poi in alto, esclamavano ad alta voce : « viva il re ». Giovanni de Anellis, nel frattempo, entusiasmò la folla, pronunciando un discorso eloquente e patriottico, col quale, senza alcuna riserva, sciolse un inno alla vittoria della rivoluzione sulla potestà regia.
E mentre al largo Gesù e Maria si ponea termine a questa prima funzione, riunivansi, alle undici antimeridiane, al largo del Contapiano le truppe del presidio, i lancieri cioè e l’artiglieria, donde, sfilando bellamente a plotoni, pervennero in sulla spianate della villa. Quivi aspettava, con la guardia d’ onore a cavallo, venuta per fare omaggio all’ esercito, una gran folla di curiosi, assiepata a piedi, in carrozze, entro calessi, char-à-banes e rozzi carretti, su cui si vedevano, in rustiche e sgangherate sedie di paglia, intorno intorno seduti e uomini e donne e fanciulli, siccome usansi tuttavia da quei contadini in occasione di feste popolari e, normalmente, da’ vignaiuoli del luogo, quando la domenica vanno alla città e se ne tornano in sul ve-spero alle vicine campagne. Messasi la cavalleria in linea e di fronte alla città, con l’artiglieria di fianco, il tenente-colonnello Ciocchi, al segnale dell’ attenti, lesse con, enfasi la formula del giuramento, al che le truppe abbassarono armi e bandiere, e cia-scun soldato, sollevando la destra, gridò « viva il re », mentre l’artiglieria sparava a salve ventuno colpi di cannone. Fu notata però con sorpresa 1′ assenza del colonnello cav. Statella, per essere stato il comando delle truppe assunto, in sua vece, dal Ciocchi. E si riuscì a sapere che quegli, con deliberato proposito, avea voluto esimersi dal prestare giuramento quel dì alla Costituzione, perché, qual siciliano, credeva pregiudicarsi rispetto agl’ isolani, suoi compatrioti, i quali sino allora non avevano voluto riconoscerla. Fece atto così di solidarietà apprezzabilissima, ma, come militare in attività di servizio, avrebbe dovuto inchinarsi innanzi alle disposizioni regolamentari, che non eccettuavano alcuno dal giuramento. Sicché dopo due giorni — ed era da aspettarselo — lo Statella, con apposita ministeriale, venne destituito.
L’intendente Domenico Antonio Patroni, intanto, sin dal ventuno di febbraio era stato, con sorpresa della cittadinanza, collocato a riposo, e nominavasi, in sua vece, il cav. Gaetano Coppola dei duchi di Ganzano. La partenza di lui per Napoli, ove andò a prendere dimora stabile con la sua giovane sposa, se spiaeque a parecchi foggiani, essendo il Patroni, come dicemmo, loro stimato concittadino, pure la universalità non ebbe occasione di accorgersi poi molto del mutamento avvenuto al palazzo della dogana, che consideravasi, come ovunque, una specie di san Graal inaccessibile, perché gl’ intendenti dell’ epoca, a differenza dei prefetti di oggidì, preferivano starsene, per sistema, lontani da contatti con famiglie locali, né aprivano mai gli usci dei loro palazzi a pranzi o a balli, credendo di rimanere, altrimenti, sminuiti in autorità e in prestigio. La loro figura quindi era rudemente poliziesca, anzi che amministrativa, essendo essi nelle provincie capi supremi della polizia e rappresentanti del re, con poteri sì assoluti da permettersi financo di compromettere chiunque e di perderlo a loro compiacimento senza dar mai conto dei loro atti a chicchessia, tranne che a lui solo. Per lo che ogni intendente, doveva essere dalle moltitudini temuto…. null’ altro che temuto.
Partitosene il Patroni la notte del ventisei di febbraio, giunse il Coppola il ventotto seguente, alle cinque pomeridiane, incontrato a poche miglie dalla città, in forma ufficiale, dal sindaco, dal comandante le armi della provincia e dai consiglieri dell’ intendenza, i quali, ad invito del primo, fecero del pari onore, nel simposio della sera al nuovo venuto.
Ma mentre festeggiavasi V arrivo del Coppola al palazzo dell’ intendenza, il vescovo Monforte, che non area perdonato ai foggiani F aver voluto strappargli violentemente dal fianco il suo fido vicario, e che cominciava nel contempo a temere anche per sé, si allontanò da Foggia in compagnia del suo medico dottor Vincenzo Raho, nonché del suo segretario can.co Luigi Ciavarella, facendo le viste di aver bisogno di curarsi da una risipola facciale, e partì alla volta di Napoli, riparando a Portici. La curia rimase così completamente acefala, perché il Monforte non credette, pensatamente, di affidarla ad alcuno: che anzi t’acuito i parroci a fare tutto ciò che concernesse le proprie parrocchie, senza più controllo di autorità superiori. S’inaugurava in tal modo in tutta la diocesi, per volere dello stesso Pastore, scompigliato dalla bile e dalla paura, un’ era di anarchia, di cui niuno poi, a dir vero, mostrò mai di preoccuparsi.
Con decreto del 29 febbraio, a norma dell’ art. 62 dello Statuto costituzionale, pubblicavasi la legge elettorale provvisoria, mediante la quale si stabiliva procedersi alle elezioni politiche per distretto. Assegnavasi per ogni quarantacinquemila abitanti un deputato che possedesse una rendita di dugentocinquanta ducati; e, con un concetto perfettamente misero e restrittivo, concede vasi il dritto del voto soltanto a coloro che avessero avuta una rendita di ventiquattro ducati, ai professori dell’ Università e del collegio militare, ai membri ordinarii di tre r. Accademie, ai giudici, ai decurioni ed ai pubblici funzionarii a riposo, già regolarmente pensionati. Con altro decreto, in data dello stesso dì, veniva poi convocato il Parlamento pel primo di maggio.
Sicché a Foggia sin dal quattro di marzo ebbe a riunirsi il Decurionato non solo per la prestazione del rituale giuramento, ma per occuparsi eziandio della nomina dei membri della giunta elettorale, la quale, sotto la presidenza del sindaco, avrebbe dovuto formare le liste secondo la legge. A tale alto e delicato ufficio furono prescelti i signori Francesco Paolo Modula, Vincenzo Celentano, Domenico de Angelis e Giovanni Battista Postiglione, i cui nomi, resisi di ragion pubblica, produssero ottima impressione.
Il nuovo intendente, frattanto, che avea già preso possesso della carica, si recò lo stesso dì, in gran pompa, a prestar giuramento alla Costituzione nella chiesa matrice insieme con tutti gì’ impiegati civili ed amministrativi; funzione solenne, che fin dall’ alba era stata preannunziata alla città intera con petardi e scampanìo, da rompere in malo modo la testa ai dormienti. A causa, pelò, di un inopportuno cattivissimo tempo non potè formarsi un regolare corteo, sicché tutta la festa si circoscrisse nell’ interno del tempio, ove, concorrendo alla solennità 1′ animo di tutt’ i cittadini, forte vibrante il grande inno della commozione patriottica, la guardia nazionale, agli ordini del sotto-capo avv. Michele Ricca, rese gli onori delle armi alle autorità, recatesi colà in eleganti equipaggi, scortati da’ lancieri.
Il Coppola prese posto nel presbiterio innanzi ad un tavolo, ricoperto da elegante tappeto orientale, e su cui trovavasi dischiuso il libro degli evangeli!, rilegato in marocchino rosso con borchie di argento. Rizzatosi poscia in piedi, ei ricevette tutti gl’ impiegati convenuti alla cerimonia, leggendo la formola rituale e invitando ciascuno a poggiare la mano destra sul crocifisso, litografato sulla prima pagina del volume quivi dispiegato, e controsegnando con la propria firma il giuramento prestatosi. Venne quindi cantato il Te Deum, e, dopo la benedizione, impartitasi dall’ altare maggiore, tra un non meno assordante suono di campane, la funzione ebbe fine.
Anche al tribunale di commercio si tenne lo stesso giorno, in udienza, la solennità del giuramento ; ma quivi il giudice Agnello Iacuzio rifiutossi di giurare mercé la formola prescritta, estimandola tisica e insufficiente, per lo che venne sospeso dalle funzioni sin quando ottemperasse, con miglior consiglio, alle disposizioni di legge.
nanco di compromettere chiunque e di perderlo a loro compiacimento senza dar mai conto dei loro atti a chicchessia, tranne che a lui solo. Per lo che ogni intendente, doveva essere dalle moltitudini temuto…. null’ altro che temuto.
Partitosene il Patroni la notte del ventisei di febbraio, giunse il Coppola il ventotto seguente, alle cinque pomeridiane, incontrato a poche miglie dalla città, in forma ufficiale, dal sindaco, dal comandante le armi della provincia e dai consiglieri dell’ intendenza, i quali, ad invito del primo, fecero del pari onore, nel simposio della sera al nuovo venuto.
Ma mentre festeggiavasi V arrivo del Coppola al palazzo dell’ intendenza, il vescovo Monforte, che non area perdonato ai foggiani F aver voluto strappargli violentemente dal fianco il suo fido vicario, e che cominciava nel contempo a temere anche per sé, si allontanò da Foggia in compagnia del suo medico dottor Vincenzo Raho, nonché del suo segretario can.co Luigi Ciavarella, facendo le viste di aver bisogno di curarsi da una risipola facciale, e partì alla volta di Napoli, riparando a Portici. La curia rimase così completamente acefala, perché il Monforte non credette, pensatamente, di affidarla ad alcuno: che anzi t’acuito i parroci a fare tutto ciò che con-cernesse le proprie parrocchie, senza più controllo di autorità superiori. S’inaugurava in tal modo in tutta la diocesi, per volere dello stesso Pastore, scompigliato dalla bile e dalla paura, un’ era di anarchia, di cui niuno poi, a dir vero, mostrò mai di preoccuparsi.
Con decreto del 29 febbraio, a norma dell’ art. 62 dello Statuto costituzionale, pubblicavasi la legge elettorale provvisoria, mediante la quale si stabiliva procedersi alle elezioni politiche per distretto. Assegnavasi per ogni quarantacinquemila abitanti un deputato che possedesse una rendita di dugentocinquanta ducati; e, con un concetto perfettamente misero e restrittivo, concede vasi il dritto del voto soltanto a coloro che avessero avuta una rendita di ventiquattro ducati, ai professori dell’ Università e del collegio militare, ai membri ordinarii di tre r. Accademie, ai giudici, ai decurioni ed ai pubblici funzionarii a riposo, già regolarmente pensionati. Con altro decreto, in data dello stesso dì, veniva poi convocato il Parlamento pel primo di maggio.
Sicché a Foggia sin dal quattro di marzo ebbe a riunirsi il Decurionato non solo per la prestazione del rituale giuramento, ma per occuparsi eziandio della nomina dei membri della giunta elettorale, la quale, sotto la presidenza del sindaco, avrebbe dovuto formare le liste secondo la legge. A tale alto e delicato ufficio furono prescelti i signori Francesco Paolo Modula, Vincenzo Celentano, Domenico de Angelis e Giovanni Battista Postiglione, i cui nomi, resisi di ragion pubblica, produssero ottima impressione.
Il nuovo intendente, frattanto, che avea già preso possesso della carica, si recò lo stesso dì, in gran pompa, a prestar giuramento alla Costituzione nella chiesa matrice insieme con tutti gì’ impiegati civili ed amministrativi; funzione solenne, che fin dall’ alba era stata preannunziata alla città intera con petardi e scampanìo, da rompere in malo modo la testa ai dormienti. A causa, pelò, di un inopportuno cattivissimo tempo non potè formarsi un regolare corteo, sicché tutta la festa si circoscrisse nell’ interno del tempio, ove, concorrendo alla solennità 1′ animo di tutt’ i cittadini, forte vibrante il grande inno della commozione patriottica, la guardia nazionale, agli ordini del sotto-capo avv. Michele Ricca, rese gli onori delle armi alle autorità, recatesi colà in eleganti equipaggi, scortati da’ lancieri.
11 Coppola prese posto nel presbiterio innanzi ad un tavolo, ricoperto da elegante tappeto orientale, e su cui trovavasi dischiuso il libro degli evangeli!, rilegato in marocchino rosso con borchie di argento. Rizzatosi poscia in piedi, ei ricevette tutti gl’ impiegati convenuti alla cerimonia, leggendo la formola rituale e invitando ciascuno a poggiare la mano destra sul crocifisso, litografato sulla prima pagina del volume quivi dispiegato, e controsegnando con la propria firma il giuramento prestatosi. Venne quindi cantato il Te Deum, e, dopo la benedizione, impartitasi dall’ altare maggiore, tra un non meno assordante suono di campane, la funzione ebbe fine.
Anche al tribunale di commercio si tenne lo stesso giorno, in udienza, la solennità del giuramento ; ma quivi il giudice Agnello Iacuzio rifiutossi di giurare mercé la formola prescritta, estimandola tisica e insufficiente, per lo che venne sospeso dalle funzioni sin quando ottemperasse, con miglior consiglio, alle disposizioni di legge.
La sera rimase la città priva di luminarie a causa della pioggia, che non si accorse del brutto mestiere che faceva di guastafeste, e che era divenuta più spessa ed insolente ; invece riuscì brillantissimo lo spettacolo di gala al teatro, dove fu cantato altresì un inno patriottico, scritto da un dilettante-musicista foggiano, a nome Giuseppe Mascia, un’ artistica speranza mancata. La festa finì, però, frastornata da uno spiacevole incidente, provocato da un tal Vincenzo del Conte, giovane foggiano anch’egli e di famiglia eminentemente liberale. Questi, alla fine dello spettacolo, ottenne licenza dall’ intendente di leggere dal palcoscenico un suo scritto, in cui aveva condensate le proprie impressioni sulla Costituzione. E tentò, con grande ardimento, di volere imitare il tribuno napoletano Giuseppe Bardano, il quale sfidò la galera quando, nel Caffè del Progresso alla Pignasecca, qualificava pubblicamente lo Statuto come immorale e vergognosa versione di quello di Francia, chiedendo, invece, 1′ adozione della democraticissima Costituzione di Spagna, promulgata a Napoli nel 1820. Il nostro giovane concittadino, infatti, cominciò a stigmatizzare la legge elettorale come un ulteriore parto infelice del Bozzelli, e la stigmatizzò con parole roventi, dimostrando ch’ essa dovesse venir corretta in senso veramente liberale per quella parte, in ispecie, che designava le diverse categorie degli elettori, pur essendo assai lontana dal concetto odierno, eminentemente razionale e democratico, che il voto cioè debba riuscire, più che altro, di sprone alle classi incolte, per raggiungere la perequazione dei valori e per togliere ogni differenza tra il voto di chi serve e quello di chi comanda. Il pubblico, nel meglio, interruppe il bollente interlocutore e non permise ch’ egli continuasse in tale lettura, quasi redarguendolo della sua giovanile tracotanza con un agghiacciante « basta », contornato di urli e di sibili da rintronarne le orecchie. Sicché tutti abbandonarono il teatro, a torto disgustati, commentando quindi, in vario senso, nei corridoi e per via 1′ accaduto. Lo stesso spettacolo, meno, naturalmente, il discorso di del Conte, fu ripetuto la sera del sei di marzo a beneficio delle orfanelle recluse nei conservatorii della città, e fu sì stragrante la folla degli spettatori che si ottenne un incasso meraviglioso, superiore ai cento ducati.
Partitosi, con dispiacere della cittadinanza, il sette di marzo da Foggia il reggimento de’ lancieri, della locale guarnigione, a causa di un ordine telegrafico con cui veniva chiamato a Napoli , volle installarsi nel Corpo di guardia già occupato da costoro, e precisamente in quello detto della Granguardia sotto il palazzo della dogana, la milizia nazionale foggiana. In conseguenza, il quattordici dello stesso mese, trecento cittadini armati, con la loro bandiera, che fino a quel momento era rimasta presso il capoguardia Giuseppe Celentano, annunziati dal rullio dei tamburi, vennero a prenderne possesso, mentre altro nerbo di essi riunivasi in una caserma improvvisata sul Piano della croce per mantenere così l’ordine pubblico nei quartieri più popolati da lavoratori e da terrazzani. Non potevasi, invero, prevedere ciò che da un istante all’altro avvenisse anche per un nonnulla perchè, la folla è come un campo di biade : si agita al menomo soffio e divampa d’ un baleno per un zolfanello gittatovi entro con malizia o a semplice trastullo. Le notizie che pervenivano dai paesi vicini non eran certo delle belle : ovunque ferveva la rivolta, la quale purtroppo è contagiosa come lo sbadiglio. Infatti la febbre degli altri stuzzicò alla pur fine la febbre nelle masse foggiane, che, ad intervalli, mostrarono di non più serbare 1′ abituale moderazione.
Ed ecco che una sera si forma in piazza mercantile un primo capannello di gente, poi un secondo, un terzo, e finalmente una turba addirittura dilaga da ogni parte, e, gridando « fuori lo straniero » , si corre da tutti, con unico intento, a circondare la chiesa di san Tommaso apostolo. Quivi esercitava da tempo le funzioni di parroco il sacerdote Michele de Girolamo, un buonaccio della vicina Orsara. Tale origine costituiva il suo gran peccato : se Orsara gli avea dati i natali, ad Orsara ei dovea tornare, mentre Foggia doveva essere dei foggiani, di nessun’ altro che dei foggiani. Com’ erano rigidi ed intransigenti i nostri antenati !… Indotti, dunque, dal formidabile unanime grido « fuori lo straniero », invasero in cento le poche camere sovrastanti la sagrestia, donde scovarono l’allampanato don Abbondio, più morto che vivo. A furia di calci, di pugni e di spintoni lo accompagnarono sin fuori l’abitato, ove lo deposero su d’ un calesse come un cencio disfatto, e lo fecero partire. Poscia, senza punto disciogliersi, si trasformarono quasi in Costituente per intendersi intorno alla scelta del successore, e, dopo discorsi infiammati che si pronunziarono d’ogni parte, venne, tra urli e schiamazzi, proclamato qual vicario-curato in san Tommaso apostolo Vincenzo Fania, prete foggiano, della cui nomina si affrettarono di avvisare essi stessi il cancelliere della curia ecclesiastica.
In quei momenti eccezionali, in cui non si avea più la misura nelle manifestazioni popolari, e quando gl’ ignoranti specialmente, come in tutte le rivolte, agivano inconscienti, quali altrettante macchine, nella falsa credenza che, in grazia della Costituzione, potessero far mano bassa di tutti e di tutto, le autorità si mostravano anchilosate, irrigidite, indifferenti a tutto ciò che accadeva. Anzi esse, senza muover ciglio, lasciavano correre la fiumana per la sua china, e tolleravano le pazzie della piazza fino ad estremo limite sì per evitare conflitti pericolosi, sì per non avere alla portata forza numerica bastevole e bene organizzata da mettere sicuramente in freno le masse, sebbene il governo avesse sperato effetti salutari — oh ingenuità asinina ! — dal nuovo battesimo della vecchia gendarmeria in guardie di pubblica sicurezza.
La miseria, intanto, non arrestava la sua marcia vertiginosa. Mentre da due mesi in Foggia non si attendeva più agli affari, e le arti ed i mestieri erano stati messi in non cale, le professioni d” ogni genere languivano pur esse in un torpore indecifrabile. L’ espediente era la vita d’ ogni giorno, e, più che V espediente, il furto. Non si poteva quasi cacciare più il naso fuori la propria abitazione, perché i ladri erano divenuti di un’ audacia fenomenale, e di pieno meriggio assalivano, percuotevano, dispogliavano chiunque, senza aver paura di chicchessia. Alle porte di Foggia sembravano annidati come al posto dei doganieri, per lo che il transito dei traini, specia1 mente, era divenuto difficile, tanto vero che nel dì 16 marzo ’48 uno di questi, che allora allora n’ era uscito sulla via consolare che mena a Napoli, fu, con abile appostamento e con audacia da non si dire, sorpreso sotto lo sfolgorante sole da parecchi malandrini armati insino ai denti, rimanendo derubato di una cassetta, pingue di ben dugento ducati in oro e in argento, e di una tabacchiera di oro cesellato, che il vicerettore del seminario, spediva, chissà come e perché, al famoso Maldacea, ex-vicario generale della diocesi, a Portici, cosa che quei manigoldi non dovevano certo ignorare.
In vista di così spaventevole spostamento economico, che alla povera gente faceva addirittura mancare il tozzo di pane giornaliero, 1′ amministrazione comunale, premurata ed autorizzata dal governo, ideò nuovi lavori a farsi, e cercò così di adibire un gran numero di operai alla riattazione in brecciame di diversi sobborghi e vicoli della città, come al ripulimento dei fossati e alla piantagione di alberi lunghesso i fianchi delle vie esterne.
Un fatto abbastanza increscioso venne ad inasprire un po’ più dell’ usato gli animi dei foggiani, e devesi all’ energia del sindaco se scongiurossi allora una popolare e terribile insurrezione. Il vescovo Monforte, che non avea dimenticato il trattamento fattosi al suo protetto Maldacea, scrisse, fors’ anche stimolato da costui, in compagnia del quale trova vasi a Portici, al sac. Gaetano Zammarano, vice-rettore del seminario, ch’ egli — ma non punto esatte erano le sue affermazioni—si mostrava dolente della inosservanza della disciplina, che avea migrato da quell’ instituto, come del poco profitto negli studii che venivan traendo i giovani ordinati in sacris. Per lo che, non potendo—com’ei diceva—tollerare d’avvantaggio simigliante mal governo, a discapito del buon costume e della istruzione, lasciava completa libertà e a lui, e ai docenti, e ai discepoli di andar via quante volte il volessero, prima che si fosse preso un provvedimento radicale per l’ avvenire, provvedimento che poteva estendersi sino all’ abolizione completa del seminario. La bomba era scoppiata : il Pastore sfidava, a viso scoperto, la sua gregge, credendo così di trame finalmente vendetta allegra.
Luigi de Noia, il quale avea capitanata la folla per l’ostracismo del Maldacea da Foggia, in ciò udire, si rimise all’ opera con i suoi amici, perché l’ azione deleteria di costui venisse ad arrestarsi nel suo inizio, scongiurando gli effetti della grave minaccia fatta dal Molitorie. Al suo richiamo furon presto riunite come per incanto circa trecento persone, decise a garantire fin con la violenza i dritti della città ; ed esse, con a capo il de Noia, si recarono dal sindaco, presentando al1′ uopo solenne protesta. Il de Luca immantinente chiamò sul palazzo civico il vice-rettore del seminario per essere edotto della realità delle cose ; e, convinto quindi che le affermazioni del vescovo fossero destituite d’ ogni base, convocò di urgenza il Decurionato pel venticinque di marzo, quando venne deliberato, ad unanimità di voti, doversi pubblicamente rinsaldare i dritti della città, ricordando pure una volta all’ universale che né il vescovo, né altri potessero farsi donni sovra il seminario, ch’ era di esclusiva pertinenza municipale ; e ciò in forza di uno stipulato, interceduto nell’ anno 1842 tra il Comune e 1′ autorità ecclesiastica. Che da un tal rogito traevasi come il primo fosse concorso con la somma di tremila ducati per 1′ acquisto del locale dall’ antico proprietario duca di Civitella e per le spese di adattamento ad istituto di educazione sacerdotale ; e risultava altresì, per patto espresso, che né il vescovo dell’ epoca (che era lo stesso Monforte), né i suoi successori avessero, in modo assoluto, facoltà di abolire tale istituzione o di mutarne le finalità, dovendosi, in tal caso, come ultima ratto, rimborsare, innanzi tutto, il Comune della somma all’ uopo erogata. Il de Luca rese nota alla cittadinanza, con relativi affìssi, tale deliberazione, che comunicava del pari all’ intendente, perché si spedisse al ministro del culto. Avvisò intanto il vice-rettore che non desse luogo a novità veruna, in attesa dei provvedimenti ministeriali, che non vennero poi mai, lasciando per tal modo al vescovo il tempo di riflettere sull’ imprudente epistola da Ini scritta, e di farne ammenda completa.
Ma, mentre scongiuravasi anche questa volta uno scatto popolare, altre minime cagioni sopravvennero per farlo nuovamente temere. Si seppe, infatti, nelle ultime ore dello stesso venticinque marzo che, fin dalla sera prima, avea preso asilo in Foggia il boia di Palermo, a nome Antonio Musco da Cerisano, scacciato da quella città come orroroso strumento della tirannide, e che era stato invece destinato dal governo a prendere domicilio in Avellino, dove, però, non appena ebbe messo il piede, fu minacciato nella vita e costretto a rifar la via sino a Foggia. A tale inaspettata notizia corse come un brivido nella folla,che ne sentì profondo disgusto, non potendo tollerare tra le proprie mura la presenza di così vile ministro di sangue. Sicché si prese a correre su per gli alberghi e le camere mobiliate, nonché per le così dette taverne, e ovunque, ansanti, si fiutava come bracchi in cerca della preda. E si misero del pari in movimento le autorità tutte per appagare l’unanime voto:
la polizia visitò gli angoli più remoti dell’ abitato, e riuscì infine a scovare il malarrivato, che tubava con una sua Dulcinea in una locandaccia d’infimo grado, ordinando ad entrambi di presto lasciar Foggia per altri lidi. Essi, pur non opponendosi a tale recisa intimazione, dichiararono di non avere in dosso la croce di un quattrino, e richiesero quindi i mezzi indispensabili per riporsi in cammino. Accontentati, presero posto su d’un calesse, e vennero scortati da poliziotti sino al ponte di Bovino, donde proseguirono, chissà per dove, la loro corsa forzata.
E il 28 di marzo ’48, a sera, la messaggiera postale, pervenuta da Napoli, menò a Foggia un Giambattista de Angelis, altro spirito bollente foggiano, dalle forti ed audaci iniziative, il quale, come anello di congiunzione tra comitato e comitato, non si stancava di andare in giro per paesi e paesi, e di tener vivo così nel Mezzogiorno anche lui, fra tanti, il movimento rivoluzionario. Si accompagnava egli a tal Gioacchino Magone, liberale molfettese, col quale, non appena giunto, si recò difilato alla sede del comitato centrale, ov’ erano riuniti, oltre al presidente Agnello Iacuzio, Carmine Durante, Gaetano Tanzi, Luca Pece, Nicola Rosati, Orazio Sorge, Felice Patierno, Michele Ricca, Giovanni de Anellis, Tommaso del Conte, Francesco Paolo Vitale, Giacomo de Maria, Francesco Severo e tanti e tanti altri generosi, di cui vorremmo ad ogni pie sospinto, per nostra intima soddisfazione, ricordare i nomi.
Costoro si erano tutti colà adunati per ricevere appunto il loro carissimo concittadino de Angelis, che veniva a discutere dei comuni interessi politici e dell’ urgente riordinamento, in senso prettamente liberale, da attuarsi nell’amministrazione della cosa pubblica. E fu, per conseguenza, prospettata dal de Angelis la necessità impellente di agire senza riguardi e ritrosie per costringere le autorità con ogni mezzo a spingersi realmente sulla via delle riforme, perché il loro persistente atteggiamento da lumaconi in tutt’ i rami di amministrazione, quando il nuovo soffio avrebbe dovuto in altra guisa ravvivarli, dava ad intendere che la Costituzione fosse per loro una lustra, e che tutto sarebbe dovuto rimanere nello statu quo, come stagno indisturbato. Ciò che poteva contentare i gonzi, i quali non guardano una spanna al di là del proprio naso, riesciva ridevole pur troppo per coloro che possedevano un briciolo di cervello e che non si accontentavano certo né di parvenze né di paroloni, ma che amavano di vedere una buona volta la reale attuazione di qualcosa veramente benefica e salutare, che, mercé l’opera dei pubblici funzionarii, fosse pegno di una vera e leale metamorfosi già avvenuta sostanzialmente nell’ ordine sociale. Tutti del comitato furono di accordo col proponente de Angelis, e stabilirono perciò di andare in commissione dal sindaco, che, come rappresentante legittimo della città, avesse presa l’iniziativa di quel risveglio, assumendo ali’ uopo un’ a-zione risoluta, e, all’ occorrenza, se ve ne fosse stato il bisogno, persino violenta di fronte all’ autorità politica.
Ma quando la Commissione, surta dal loro seno, si presentava al palazzo di città, ed usò col sindaco marchese Luigi de Luca un linguaggio chiaro, esplicito e senza sottintesi, costui videsi impacciato a segno, che non seppe fare alcuna promessa, ma, con frasi vaghe e indeterminate, tentò, eccitando ognuno alla calma, di mitigarne gli ardori e di scongiurarne i bellicosi propositi. A tale inaspettato atteggiamento il de Angelis divenne scarlatto, quasi congestionato, mentre gli occhi gli si enfiavano e il viso gli si contorceva come una foglia nell’ afa che precede la burrasca. Ei non ebbe più la forza di contenersi, e. spogliando quindi il suo dire di ogni vernice di convenienza, fece comprendere al sindaco de Luca che non si aveva il diritto d’indossare la divisa di primo magistrato del capoluogo di un’ importante provincia quando forse, per pusillanimità, non potrebbesi rappresentare neanche un’ umile borgata. Che non era più il momento di tentennare e di tenere a bada chicchessia, ma era d’uopo prendere una posizione netta e recisa. E qui, pittandogli, sulla tavola da scrivere, una rosetta di nastri tricolori, « prendete » gli disse, « strappate dal vostro cappello la coccarda rossa, e abbiate almeno il coraggio di sostituirla con questa, che è il vero simbolo della libertà ». Il de Luca non la raccolse, ma, terrorizzato, cercò ancora di schermirsi alla meglio, per evitare ad ogni costo una compromissione. Però il de Angelis, ch’ era pervenuto ad un grado di parossismo in cui non intendeva più qualsiasi invito alla calma, si rivolse ai compagni e li incitò a seguirlo ; che. se il sindaco nicchiava, l’intendente, invece, sarebbe stato costretto a fare il suo dovere.
Francesco Paolo Vitale, Antonio de Maria e Nicola Mancini vennero tosto con lui al palazzo della dogana, ove furono ricevuti con ogni garbo dal Coppola. Senza molti preamboli il de Angelis aprì il certame con la spigliatezza d’un bersagliere, e, difilato, corse a bollare cruentemente gli alti papaveri delle amministrazioni della provincia, cominciando dal più grosso di essi, che lo ascoltava con sangue freddo e nel massimo stupore, e di cui dimostrò la supina inerzia e partigianeria. Che bisognava metter mano — ei diceva — urgentemente ad una riforma radicale di quell’ ignobile gergo cavalieresco e segretariesco, che suoi chiamarsi burocratico e che, con migliore dizione, fu addimandato birrocratico. Che era tempo ormai di mutare gli antichi sistemi, se non si volesse dare il diritto a chiunque di pensare che ciò derivasse da fermo proposito e da profonda inala fede. Che l’ingerenza del potere ecclesiastico, fra l’altro, e sopra tutto, porro unum necessarium, la ingerenza personale del vescovo Monforte nelle pubbliche amministrazioni locali doveva alla buon’ ora finire, giacché essa riusciva deleteria, sotto ogni aspetto, e direttamente pericolosa per ogni progresso civile. Che il paese — ed era ora di finirla — si aspettava una risposta categorica e decisiva alla intimazione di resa. Il Coppola, innanzi a sì terribile filippica, guardò il de Angelis quasi col sogghigno con cui Omero guardava le gagliardie delle rane e dei topi ; pure preferì di non reagire e di rifondervi fors’ anche un tantino del suo prestigio per non provocare possibili maggiori risentimenti. Con simulata pacatezza assicurò la Commissione ch’ei prendeva impegno di studiare, con largo criterio di giustizia, le riforme possibili ad attuarsi, e che nell’animo suo non vi era che il desiderio di esaudire, in ogni modo, il voto della cittadinanza, sempre quando questo non venisse a cozzare con le esigenze dell’ amministrazione e con le disposizioni di legge.
Il de Angelis e la Commissione, vedendo che uccellavano con le farfalle e che il voler far prendere all’intendente una decisione hinc et nunc era come pestar 1′ acqua nel mortaio, andarono via, nemmanco soddisfatti da promesse sì vaghe e dilatorie. Lasciarono però alla stampa di completare 1′ opera da loro iniziata, giacché da quel momento i giornali locali presero a pubblicare articoli di brace or contro 1′ uno or contro l’ altro dei funzionarii della provincia, inclusi gii stessi magistrati, tacciati di partigianeria nelle loro sentenze. E vennero del pari scudisciati parecchi impiegati privati, che, servendosi del salvacondotto di liberali, cercavano, a loro dire, di sfruttare le pubbliche amministrazioni e di trame un profitto esclusivamente personale. Insomma si aprì tale un periodo di critica e di censura per tutti e su tutto, che la polizia, temendo che allo scandalo tenesse dietro micidiale rivoltura, credette prudente consiglio di allontana e il de Angelis ed il Magone da Foggia, facendoli, di notte tempo, ripartire per Napoli. Furono, intanto, afforzati i posti di guardia ed aumentate le ordinarie pattuglie in città per paura si turbasse l’ordine pubblico ; il che, in verità, non ebbe poi ad avverarsi.
Nella domenica e nel lunedì successivi, 2 e 3 aprile ’48, ebbe luogo innanzi al sindaco ed al Decurionato il sorteggio di dugento componenti la l.a compagnia della guardia nazionale, cui seguì, man mano, quello per altre ventisei compagnie, e allo scopo di scegliere tra essi coloro che dovevano assumere il grado di uffiziali e di sotto-uffiziali. Ma una tale scelta, che, per l’affluenza del pubblico, venne esaurita non prima di tre giorni nella gran sala del palazzo della dogana, provocò delle vive proteste, giacché la sorte avea favorito pochi gentiluomini del paese ; sicché gli esclusi, rosi dalla vanità e dal1′ ambizione, si rizelarono e produssero, a norma di legge, formale ricorso al tribunale civile di Lucera, ricorso, per altro, che non ebbe alcun esito favorevole, e che non sospese, nelle more giudiziarie, le operazioni riflettenti le altre compagnie.
E il giorno quattro di aprile mille e dugento fucili furono intanto mandati da Napoli per armare la guardia nazionale di tutta la Capitanata, ma che i foggiani volevano ritenere soltanto per sé ; e furono divisi per ordine dell’ intendente, che promise farne richiesta di altro buon numero, in proporzione fra tutti, e alla presenza degli uffiziali e del sindaco. Per lo che Foggia ne ottenne cinquecento, Lucera duecento, Sansevero altrettanti, e così, gradualmente, ogni altro paese della provincia.
Sopravvenne il quindici di aprile, e, sulle prime ore del mattino, fu vista giungere una diligenza tutta inzaccherata e con una bandiera tricolore sventolante accosto al cocchiere. Si acuì la curiosità di quanti la scorsero, i quali si accostarono alla così detta taverna di Minichetti, ove quella si era soffermata, per vedere chi ne discendesse. Erano dei signori lucerini, provvenienti da Napoli, che, dopo poche ore ivi di rinfresco, avrebbero ripreso il loro viaggio per Lucera. Ma tra i curiosi si presentò il sergente dei gendarmi a nome Fujano, fedelissimo protetto di Ferdinando II, il quale, urtatosi alla vista del tricolore come un toro dal panno rosso, investì il vetturino, chiedendogli ragione dello sventolare di quel drappo. Il vetturino rispose per le rime, dicendo ch’ egli, issando la bandiera, avea creduto di fare atto di omaggio alla Costituzione. Non avesse mai osato di replicargli, che quel villano, datogli uno spintone da farlo ruzzolare per terra, né strappò a viva forza il tricolore e lo ridusse in brani. La folla, aumentatasi in men che non si dica, ondeggiò d’improvviso, mugghiando come fa il mare assalito da una raffica impetuosa, e tentò di schiacciare il dissennato, che, a difendersi dalla giusta ira popolare, sguainò la sua penzolante durindana. I lucerini, pallidi e tramortiti, chiedevano aiuto e protezione ai più animosi, i quali, vomitando su quella stumia di furfante una valanga di epiteti ingiuriosi, misero fuori anch’essi le armi, e stavano per farne giustizia sommaria. Ma il birro, lavorando di gomiti e di audacia, riuscì a sgaiattolare tra la folla: però, in seguito da un drappello di guardia nazionale, accorsa al tumulto, venne tosto acciuffato e tradotto nel posto di guardia. La folla riaccattò dal suolo i brandelli della bandiera, e, riunitili alla meglio, ricompose il tricolore, che, insieme ai viaggiatori, portarono in trionfo per le vie, gridando: ” viva la Costituzione, viva i lucerini „. La sera costoro, con animo profondamente commosso, partirono per Lucera; ma l’indomani il sindaco di quella città e varii uffiziali della guardia nazionale locale si recarono a bella posta, in diverse carrozze signorili, a Foggia, per ringraziarvi tanti generosi dell’atto compiuto in prò dei loro concittadini. Visitarono, pel primo, il sindaco marchese de Luca, e poi, un per uno, vollero salutare gli uffiziali della nostra guardia nazionale, a tutti professando sentimenti di gratitudine. I foggiani accettarono con compiacimento il fraterno saluto, e fecero loro dintorno molta festa, che ebbe il suo riepilogo al Caffè Nazionale in piazza Saggese, ora del Lago (1), dove convenivano abitualmente i liberali più in voga, e dove, per conseguenza, può dirsi si disfacesse e si rifacesse da mane a sera la carta geografica di tutta Europa. Quivi si raccolsero quel giorno quanti vollero onorare la rappresentanza lucerina, quivi si levò il calice alla fratellanza dei due paesi vicini, che antichi rancori aveano tenuto sempre divisi, quivi quasi consacrossi tra loro, con teneri abbracci, un novello patto d’amore. Il sindaco, i decurioni, gli uffìziali della guardia nazionale accompagnarono, poco dopo, con magnifico corteo di equipaggi, i lucerini sino al limite del territorio foggiano, e poscia si divisero, scambiandosi novellamente frasi di simpatia reciproca e di amicizia.
Il Ministero si era rivolto all’ intendente di Capitanata, come avea fatto del pari con gli altri intendenti, incitandolo a studiare attentamente le cause vere e reali di quello stato di miseria che affliggeva V intera provincia, nonché ad invigilare quanti fossero elementi di disordine, peste perenne di ogni organizzazione sociale. Che se la legislazione — conchiudeva la ministeriale — non può prevenire materialmente la ineguaglianza esistente fra le diverse classi della società, l’obbligo della polizia è di prevenire i mali, che possano scaturire dall’ abuso delle ricchezze e della prepotenza, dalla corruzione della povertà e dalla indolenza oziosa. A tale scopo il Ministero venne altresì nella determinazione di nominare per ciascuna provincia un delegato governativo speciale, che vegliasse tuttodì, fino all’ apertura del Parlamento, su’ magistrati e sugli altri pubblici funzionarii, dandogli facoltà persino di rimuoverli dalla carica nel caso non adempissero scrupolosamente al loro dovere. E con decreto, pervenuto in Foggia il diciassette aprile di queir anno, nominavasi, per la Capitanata, a delegato speciale il signor Francesco Saverio Figliolia.
(1) Questa bottega da caffè era tenuta, a quell’epoca, da un calabrese assai popolare del luogo, e che clùamavasi Rosario Maseia. Tra i liberali, elio abitualmente frequentavano questo locale, erano immancabili ogni sera gì’ impiegati governativi Raffaele Fer-randino, Giovanni Cavaliere, Giuseppe Giannini, Raffaele Palmieri, Giambattista Sorrentino e Carlo Schiraldi, che non temevano di far risuonare in pubblico le forbici delle loro lingue contro l’autorità ecclesiastica, la gendarmeria, le spie, e fin contro i ministri e la stessa persona del re.
Però a molti non piacque una tale scelta, tanto che cominciossi ad impegnare una vera campagna contro di lui e su qualche giornale locale e su fogli volanti anonimi, di cui qualcuno va conservato tuttora tra le mie carte antiche di famiglia, e che, destituito sin del nome della tipografia che lo pubblicava, non ho creduto qui riprodurre, perché mi ha 1* aria di un vero libello diffamatorio. Il Figliolia polemizzò allora coi suoi detrattori, cercando di rintuzzare gli oltraggi e le calunnie, si agitò, minacciò, ma non valse a scongiurare un nuovo decreto, col quale lo si dispensava dall’ incarico affidatogli.
In seguito di tale fulmineo provvedimento, che non permise al Figliolia neanche di prendere possesso del suo ufficio, venne messo in aspettativa l’intendente Coppola, surrogato alla sua volta dall’ intendente del Molise signor Andrea Lombardi, con la nomima, ad un tempo, del segretario generale in persona del signor Girolamo Fuccilo, consigliere dell’ intendenza di Potenza.
Ma, oltre a codesti delegati speciali, il governo stabilì dovervi essere in ogni capoluogo un Consiglio di pubblica sicurezza o Commissione, che dicevano, comunemente, di spirito pubblico, presieduta dall’ intendente e composta del comandante le armi della provincia, del procuratore generale del re e di tre notabili locali, allo scopo di dover curare col semplice ascendente dell’autorità morale sulle moltitudini, la conservazione dell’ ordine pubblico in armonia coi principii statutarii, e garentita. all’ occasione, dalla milizia nazionale e regia. A tale oggetto il ventisette aprile si riunirono al palazzo della dogana il marchese Tommasantonio Celentano, consigliere decano dell’ intendenza, che funzionava allora da intendente per non essere ancora il Lombardi venuto in residenza, il comandante della provincia e il giudice di Corte criminale Francesco Morelli, che funzionava da presidente in Lucera per V assenza del titolare ; e, mentre si era per nominare i tre notabili, fu an-nunziata loro una deputazione del popolo, composta dei signori Tommaso Tonti, Nicola Mancini, Gaetano Tanzi, Saverio Tarantino, Aurelio Mele e Scipione Cafarelli, che chiedeva di essere ricevuta. La si fece introdurre nella sala ov’ erano raccolti, e, non appena venuta in loro presenza, prese la parola il Tonti, che, annunziandosi quale emissario, con gli altri, della volontà sovrana del popolo, diè lettura di un elenco di per- sone da potersi prescegliere a notabili, come meritevoli di stima e di fiducia. I nomi che si proponevano erano quelli di Agnello Iacuzio, Michele Cinquepalmi, Francesco Paolo Vitale, Matteo Nannarone, Michele Postiglione e Antonio Sorrentini. La Commissione si vide turbata nella serenità del suo lavoro, e dette loro affidamento che la scelta sarebbe riuscita di generale soddisfazione, inspirata essa al concetto di doversi affidare un sì delicato incarico a persone che davvero lo meritassero. In ciò udire la deputazione andò via fidente ; dopo di che la scelta, seduta stante, fu fatta nelle persone di Carlo Vincenzo Barone, di Lorenzo Filiasi e di Matteo Nannarone, designandosi a segretario il capo della polizia, tal Francesco Tibi.
I tre nomi non spiacquero alla maggioranza dei foggiani, ma solo quello di quest’ ultimo suonò assai male all’ orecchio di molti, tanto che incominciossi a tumultuare in piazza e a far capannelli qua e là, in segno di protesta. Francesco Petrilli, Gaetano Giampietro e Scipione Cafarelli risolsero di portare la protesta del popolo al sindaco, facendogli notare che, essendo colui un siciliano, non poteva essere non solo accettato qual segretario della Commissione di “” spirito pubblico “”, ma eziandio non più tollerato in un’ amministrazione foggiana. Il sindaco, come uomo di pace, cercò d’infondere anche in loro un centellino di calma, ma non vi riuscì, tanto che il Petrilli, il Giampietro e il Cafarelli, ridiscesi in piazza, incitarono la folla ad imporre con la forza il proprio volere. Infatti, verso le sette della sera, videsi man mano aggruppar gente a gente presso la casa del capo della polizia, e quando un mare di teste, formicolanti per ogni angolo, non lasciarono più posto laggiù ad un granello di miglio, s’iniziarono le grida di « abbasso Tibi, abbasso Tibi ». Costui non era rincasato ancora, e la notizia, sparsasene in un baleno tra la folla, fece sì che i caporioni si muovessero ad incontrarlo. Quand’ ecco ch’egli spunta da un vicolo vicino, e coraggiosamente si avanza; ma, a tale vista, gli ultimi si fanno primi, e, senza dargli tempo a parlare, stavano per accopparlo, quando il Tibi, già mezzo pesto, ebbe agio di sfuggire alle loro mani e di raggiungere la sua abitazione, ove si fortificò, sbarrando il portone e le finestre, e donde riuscì poi a mandare un messaggio agli assedianti, col quale facea loro sapere che l’indomani, di buon mattino, avrebbe lasciata la città.
L’eccitamento per ogni nonnulla, in cui trovavansi da varii giorni gli animi specialmente delle classi meno abbienti, cominciò ad impensierire le autorità e la cittadinanza intera. Un pò di allarme, non e’ era da dissimularlo, aveano suscitate in Foggia le notizie che si ricevevano in tutte le ore da Bovino, da Serracapriola, da Troia e da altri Comuni della provincia, dove turbe intere di contadini avevano invasi i feudi principeschi e ogni altro ricco podere, e con prepotenza aveano quivi preso a dissodare terreni, a tagliare e a svellere alberi, a rimuovere titoli lapidei, a bruciare mete intere di paglia, a demolire case rurali, chi per impossessarsi di tutto e farla da padroni, chi per spirito vandalico di devastazione. Né potevasi dalle autorità agire con energia per metterli a posto e garentire i proprietarii, perché prive, come accennammo, sì dì forza morale che di forza materiale. E mentre la bufera imperversava su per le campagne, le autorità a furia di segnali, mercé le primitive assicelle, assai meschine avole del telegrafo senza fili, implorarono da Napoli almeno un pò di truppa in loro soccorso. Si era dunque, per necessità di cose, in un periodo di semi anarchia con parentesi epilettiche, che facea sul serio tremare le vene e i polsi anche ai più indifferenti e pessimisti. Pure ben da parecchi anni addietro avrebbesi potuto cercare di prevenire il male, perché sin d’allora erano pervenute all’ intendente, da ogni parte della provincia, le unanimi e dolorose proteste a causa della cresciuta popolazione e dei crescenti bisogni, essendo, per conseguenza, risultate insufficienti le terre rimaste a libera coltura. Uno strabocchevole demanio sul Tavoliere erasi concesso ai signorotti di questo o di quel paese, che, mietendone assai pingui tesori, erano stati messi, per tal modo, in condizione privilegiata da poter spendere e spandere in larga misura, mentre, d’ altra parte, uno sciame di contadini,di povera gente,insomma, si lasciava morire spietatamente tra gli spasimi della fame. Questa questione, cotanto grave, non si era voluta risolverla ; e costoro, pur potendo vantare un diritto, non trovaron mai chi glielo riconoscesse appieno. E questo loro diritto rimontava fino ai tempi degli aragonesi, quando ben ventidue difese furono acquistate da quei re, residuo dei remoti campi dell’ erario romano (agri pnblici P. R.), tramandato poi di generazione in generazione a coloro ch’ ebbero il principato di quelle contrade, e residuo del pari dei deserti campi appartenenti alla chiesa e ai monasteri distrutti dalla Corte pontifìcia ; difese, che, aumentate con altri fondi feudali ed erbaggi, Alfonso I estese sino al contado di Molise, come Ferdinando I sino alla Basilicata e alle due Terre di Otranto e di Bari, concedendole al popolo in censuazione. La quale, perpetuatasi in taluni col danno di altri, sollevò gli esclusi, che si rivolsero nei 1792 a Ferdinando IV di Borbone perché avesse reintegrata la primitiva concessione, fattasi per risollevare tutti e non pochi soltanto, togliendo così ogni disparità di trattamento. E Ferdinando IV, che intendeva dare, infatti, ai poveri contadini un pezzo di terra dalle quattro alle dieci versure, commise lo sbaglio di rimettere 1′ esame della domanda ed il relativo giudizio al tribunale della dogana di Foggia, che opinò di non aversi facoltà di togliere le terre, già concesse, agli attuali coloni, per essere il contratto di mera censuazione perpetua, adducendosi, in sostegno, un regio rescritto, dato per eco ad una male interpetrata consulta della Sommaria. Invano il re fece riesaminare lo stesso deliberato da cinque togati, che aveano retta per lo innanzi quella dogana, e che si mostrarono favore voli alla richiesta, giacché, nel momento della esecuzione, lo stesso governatore di detto instituto porse braccio forte agli utenti, e mandò tutto in dileguo, facendo che lo sconcio continuasse anche contro la volontà del sovrano. I nostri contadini, sopitisi novellamente, si ridestarono nell’ anno 1846, quando Ferdinando II ebbe a venire in Capitanata per assistere alle manovre che si tenevano dalle truppe tra Bovino ed Ariano, ospite a Deliceto dei pp. liguorini, e rivolsero a lui, direttamente, le relative suppliche, messe poscia del pari in oblio. Ma la Costituzione aveva creato in loro il convincimento che il tempo della rivendicazione fosse già venuto, e che, all’ ombra di essa, non si potesse finalmente non riconoscere il proprio diritto ; sicché il torrente della rivolta doveva per necessità irrompere e dilagare non appena il 22 aprile ’48 si concesse, con apposita ministeriale, ai Comuni la facoltà di poter fare riacquistare dai privati gli antichi diritti demaniali. Fu allora che da parecchi di essi, anzi che pensare di rivolgersi, per lo scopo, al magistrato, si preferì di esercitare da sé 1′ affermazione di tale diritto, e di procedere alla divisione delle terre con la forza e con la violenza. Gli stessi giudici regi, nei piccoli paesi, spogli, in un momento, di autorità e di prestigio, rimasero, con le mani alla cintola e senza tirar flato, a rimirare lo spettacolo neroniano, col pericolo, altrimenti, di divenir vittime del furore popolare. Che se qualcuno più zelante e ardimentoso, come a Savignano e a Deliceto, volle fare il viso d’ arme, ebbe spiacevolmente ad accagionare, col fatto suo, esplosioni d’ira e danni maggiori.
In così anormali condizioni, in cui trovava»! la nostra provincia di Capitanata, causa la cattiva interpetrazione data alla Costituzione, Foggia a ragione dovea temerne il contraccolpo ; per lo che i pacifici cittadini, ad ogni più lieve moto di piazza, correvano a rinchiudersi nel guscio delle proprie case, tremanti di paura per la vita e per gli averi.
Tibi, dunque, dovè lasciare Foggia ad ogni costo : così il popolo avea voluto, senza che alcuno abbia potuto opporvi resistenza veruna. Ma Tibi non doveva essere il solo, e con lui dovea pure andar via il ricevitore generale del Tavoliere, Achille Smith, parimente inviso alle moltitudini. I signori Giuseppe Carelli e Giambattista Cicella furono delegati ad annunziarglielo, presentandogli un interminabile elenco di cittadini, con le relative firme autografe, che tale ostracismo avevano decretato. E del pari Smith, che vide inutile ogni scampo, chinò obbediente il capo innanzi alla volontà del popolo sovrano e partì.
Era pervenuto, intanto, al comitato di Foggia, in migliaia di esemplari, un proclama a stampa con l’ epigrafe : I Calabresi agli abitanti di Capitanata. Con parole di fuoco si aizzavano le masse contro le autorità tutte, di qualcuna delle quali si abbozzava financo una non bella biografia, e le si dimostrava non solo inette, ma pericolose per l’attuazione completa della Costituzione. E mentre il proclama passava da mano in mano, eccitando le masse alla ribellione, capitò in Foggia dalle stesse Calabrie Francesco Romeo, fratello del noto agitatore Giandomenico Romeo, gentiluomo di S. Stefano, caldo ed animato patriota, come lo chiamavano i liberali dell’ epoca, e che, un anno prima, come ispettore generale delle dogane, aveva percorse, senza dar sospetti, tutte le provincie del Mezzogiorno allo scopo di serrare in un fascio i rivoluzionarii delle due Sicilie e di tentare, all’ occasione, un sollevamento collettivo e simultaneo col concorso della gioventù bollente e dei ricchi proprietarii ; scopo che poi non raggiunse, giacché, a un primo inizio di sedizione nelle sue contrade, ebbe staccato il capo dal busto (1);
(1) Vedi Mariano d’Ayala, Vite degVItaliani benemeriti della libertà e della patria, — Torino 1880.
Da una parte i liberali foggiani si attaccarono a lui come ad un fratello, e presero a secondarne le mire, ch’ eran sempre quelle di stringere ancora più i vincoli di solidarietà tra i rivoluzionarii delle provincie, mentre, dall’altra, vi fu chi venne colto da tale un panico che gittò dappertutto lo scompiglio. E che cosa ci vuole per determinare specialmente l’allarme tra le donnicciuole ? Furon queste che, in sentire buccinare dai loro parenti il nome del Romeo come d’un rivoluzionario, temendo ch’ei fosse un pericolo per tutti, si misero a gracidare come oche, e costrinsero a tapparsi con loro, nelle grotte e negli stambugi, i mariti e i figliuoli, cui più non permisero di cacciare fuori di casa neanche la punta di un dito. Uno sbatacchiar di usci si sentì allora in un baleno d’ogni banda, mentre i più pacifici cittadini fuggivano, fuggivano per le vie senza saperne il perché, e, madidi d’un gelido sudore, raggiungevano le loro abitazioni. Invano parecchi gentiluomini foggiani, venuti in piazza, cercarono di persuadere i timidi che nulla ci fosse da temere, che il Romeo andava in giro per la città per raccogliere, a loro dire, danaro in prò dei poveri perseguitati calabresi, e che tutto quindi il comune allarme fosse ingiustificato. La milizia nazionale dovè correre ad armarsi, tutt’ i posti di guardia dovettero essere afforzati, e le pattuglie, aumentate, cominciarono a perlustrare le vie, evitando su di queste ogni assembramento. Insomma, dopo un giorno il Romeo non si vide più in Foggia:—chissà se la polizia non ebbe a trovar mezzo di fargli prendere il largo a notte alta, ridonando così la calma a quanti, senza base, l’aveano perduta.
III.
La Costituzione, coni’ è noto, stabiliva dovessero esservi due Camere, 1′ una dei Pari, eletta dal sovrano, e l’altra dei deputati, eletta dal popolo. Era d’uopo quindi che Foggia approntasse ormai la elezione della sua rappresentanza politica. Nicola Rosati, uomo di liberi sensi, rivolse, nella occasione, agli elettori foggiani e della provincia un proclama a stampa ove, indicando le norme da seguirsi nello scegliere i proprii rappresentanti alla Camera elettiva, svolse un serio e complesso programma politico, mirante, come ultimo fine, all’ unità e indipendenza italiana. E, in mezzo al comune fervore per la conquista della libertà, fin dal 18 aprile ’48 cominciarono a riunirsi gli elettori del Comune di Foggia nella chiesa di s. Domenico, non essendosi potuto trovare altro locale più adatto sì per contenervi un numero di circa ottocento iscritti, sì per esser quello un sito assai centrale della città. Quivi intervennero il sindaco, marchese Luigi de Luca, qual presidente provvisorio della giunta elettorale, che prese posto dietro a un largo tavolo in fondo alla chiesa, e i signori Vincenzo Celentano, Francesco Paolo Modula, Domenico de Angelis e Giovanni Battista Postiglione, in qualità di segretarii pur provvisorii , dietro a quattro tavolini diversi, mentre altri simiglianti erano regolarmente disposti in giro e in angoli appartati, destinati ad accogliere i votanti. Fattosi l’appello degli elettori, giusta le prescrizioni di legge, fu, innanzi tutto, aperta la votazione pel seggio definitivo, che, a maggioranza di voti, riesci composto dei signori can.co Pasquale Capuano, presidente, Antonio Sorrentini, Giuseppe Serrilli, Tommaso Tonti e Aurelio Mele, segretarii. A completamento del seggio definitivo, furono prescelti, con funzione di scrutatori, i due più anziani presenti nell’ aula, cioè Michele Cinquepalmi e Matteo Nannarone. Le operazioni durarono più giorni, tanto che, mentre nel sabato santo il grande e universale scampanio clamava al Signore risorto, e si vide sventolare per la prima volta il labaro tricolore in cima al campanile della chiesa maggiore, dov’ erano andati testé ad issarlo, tra i battimani della folla in letizia, Francesco Petrilli ed Antonio de Maria, il seggio elettorale continuava tuttavia in s. Domenico ad esercitare le sue funzioni. E dovettero poi partitamente riunirsi in Foggia tutt’ i verbali dei singoli circondarii della provincia, che, per legge, dovevano essere spediti alla Giunta del capoluogo, denominata « distrettuale » ; sicché si pervenne con indefesso lavoro al cinque di maggio, quando potette procedersi allo scrutinio per i deputati assegnati alla provincia di Capitanata ; in seguito di che risultarono eletti, a maggioranza assoluta di voti, Giuseppe Ricciardi e Saverio Barbarisi di Foggia, Luigi Zuppetta di Castelnuovo. Gaetano de Peppo di Lucera, Giuseppe Tortora di Cerignola, Giuseppe Libetta di Viesti, Ferdinando de Luca di Serracapriola e 1′ arcidiacono Nicola Montuoro di Mon-tesantangelo (1). Proclamati costoro, uomini di specchiata probità, di alto intelletto e di provata fede liberale, quali rappresentanti del popolo di Capitanata al primo Parlamento napoletano, comunicossi loro un tal voto col massimo entusiasmo e con le più grandi speranze per V avvenire della sventurata regione.
L’ apertura della Camera elettiva, già fissatasi pel primo di maggio, era stata differita al quindici dello stesso mese, perché i lavori elettorali non si erano potuti espletare per quel-1′ epoca in tutto il regno. Intanto due degli eletti si videro venire allora in Foggia per salutare i proprii elettori ; e questi furono Luigi Zuppetta e Saverio Barbarisi : 1′ uno, giovane avvocato e professore, pieno di vigoria e di ardimento, nato nella vicina Castelnuovo ; l’altro, vecchio venerando e nostro concittadino, ormai non abbastanza ricordato dalla postuma generazione.
Chi era, che cosa avea rappresentato fino a quel momento il Zuppetta ? Lo dica egli stesso con la sua inimitabile frase incisiva e sarcastica:
« La sostanza increata piacquesi di soffiarmi un odio irrefrenabile contro tutto ciò che sente di trasmodamento e d’ingiustizia; onde fra me e la polizia di Napoli spiccava quella corrente di simpatia che passa tra la donna e il serpente. E quando era crimenlese il parlare d’Italia, d’italiani, di gloria d’Italia, io, in fronte alla 2.a edizione della mia Metafìsica della scienza delle leggi penali (Napoli 1843), scrissi questa dedica: — Ai pochissimi italiani, caldi del sacro fuoco della vera sapienza, promotori indefessi del vero bene, custodi gelosi della vera gloria letteraria e politica d’Italia, sono dedicate queste pagine.— Dedica pericolosa in quel tempo e sotto quel governo ; ma la mia tempra adamantina mi autorizzava a sfidare di ogni maniera pericoli. Nella dedica io diceva essere relativamente pochissimi gl’italiani degni di tanto nome; ed era nel vero. Oggidì i liberali pullulano come funghi silvani, tutti si camuffano ad italiani zelantissimi, e menano più scalpore coloro che pel passato erano i più fervidi devoti del dispotismo o marcivano nella ignavia, poiché son cessati i pericoli annessi alla professione di vero italiano.
1) Nel contempo un altro illustre foggiano, Vincenzo Lanza, veniva eletto a Napoli tra’ venti deputati di quella provincia.
Quando essa apriva la via al patibolo, allo ergastolo ed allo esilio pochissimi la vagheggiavano. Ed è esilarante lo spettacolo cui oggi assistiamo ili Italia: una vera pioggia di croci di cavalieri della Corona d’ Italia scende su’ petti di coloro che nulla fecero perché 1″ Italia si facesse, o fecero di tutto perché l’Italia non si facesse, o fanno di tutto perché l’Italia si disfacesse. È uno dei tanti miracoli della corruzione, assunta a sistema di governo ! Onde la mia esultanza quando il solertissimo ed istancabile cospiratore Benedetto Musolino mi comunicò la nomina di affiliato alla Giovane Italia, ed il mandato di Mazzini di cooperare alla propaganda con la pienezza delle mie forze. Una lettera dall’ estero, affidata imprudentemente alla posta, ed aperta dagli agenti di polizia in omaggio al segreto delle lettere, rese edotto il ministro della polizia generale che in Napoli ferveva la propaganda. Senza porre tempo in mezzo, s’iniziò il così detto processo della Giovane Italia. Vi furono implicati e più specialmente scrutati e sorvegliati l’operoso Benedetto Musolino e il degnissimo costui fratello Pasquale. Non si pretermise alcuno artifìcio per indurre i fratelli Musolino a declinare i nomi dei correi. Adescamenti, minaccie, incomprese torture dello spirito, e che so io. Tutto vano. Intanto, come Dio volle, il giudizio ebbe per finale risultato l’assoluzione degli accusati. Quanto ne avesse rammarico il ministro della polizia generale è agevole il divinare. Con la condanna degli accusati egli aspirava alla gloria di aver salvata ancora una volta la monarchia borbonica. Inoltre, egli era convinto delle mene mazziniane, tanto che ogni giorno esclamava: e pure la propaganda si espande’… E smanioso incitava i bracchi a fiutare senza tregua e con maggiore diligenza. Il rannuvolato ed impensierito ministro il giorno TI giugno 1843 udì una parola confortatrice. Il famigerato Nicola Barone, che era la creatura più attiva e benemerita della polizia borbonica, e di cui il popolo fece giustizia sommaria allo apparire della Carta costituzionale del 1848, chiese di a lui parlare. Come fu messo alla ministeriale presenza sì fattamente favellò : — Voi non ignorate che esiste in Napoli il giovane professore privato di giurisprudenza Luigi Zuppetta, idolo dei suoi pur troppo numerosi discepoli, e non punto devoto alla ortodessia monarchica. Or bene io sento la inspirazione che l’arresto di questo demagogo potrebbe dissipare le nubi. E perché voi possiate coonestare l’arresto, io fra tre giorni redigerò e presenterò a voi una larga esposizione di tutte le parole, di tutti gli atti, di tutte le circostanze valevoli ad indurre un ben fondato sospetto della febbrile cooperosità del giovane professore al proseletismo delle dottrine mazziniane. In seguito alla presentazione della mia dettagliata esposizione voi non dovreste indugiare a far mettere in prigione V audace cospiratore. E metto pegno che, appena verrà rinchiuso nelle prigioni di Stato, il costrutto si caverà. — Rispose il ministro : — Presentami la esposizione fra tre giorni, ed io, appoggiandomi ad essa, ordinerò incontanente l’arresto del nemico del trono. — Ma la Provvidenza non permise tanto scempio. La sera dello stesso giorno 27 giugno un agente di polizia, ammesso alle segrete cose del Ministero, mi palesò per filo e per segno il tenore del colloquio tra Nicola Barone e ‘1 ministro. M’inculcò di lasciare Napoli la dimane, servendomi di un passaporto, che mi offriva, purché io condiscendessi a largamente rimunerarlo dell’atto umanitario !… Accettato il partito, alle ore 4 p. m. del giorno 28 giugno 1843, imbarcatomi sopra un piroscafo francese, mossi da Napoli per la terra dello esilio, lasciando nelle mani dell’ eroico e sventurato Giuseppe de Miranda di Ariano di Puglia questa lettera :
Miei diletti discepoli,
« Quando leggerete queste linee il sole sebesio non più risplenderà sopra di me. La mia cattedra sarà una quercia percossa dalla folgore. In Napoli il pugnale dell’ assassino può talvolta evitarsi; ina il pugnale, di cui V empia polizia arma la sua destra contro i filantropi cittadini, non può evitarsi giammai. Rannodate questa frase alla storia dei miei dolori !.. Vi lascio senza stringervi al seno. Ma il porgitore di questa mia ha ricevuto sul fronte il triplice bacio fraterno che era destinato a ciascun di voi. Parto saldo italiano, e saldo italiano mi serberò. Perseguitato, non vinto. Se vinto, non domo !!
Prof. Zuppetta » (1).
Dopo proclamata la Costituzione questo ingegno potente e dalla profonda dottrina, questo patriota dall’ anima candidissima, dal carattere integerrimo, dai costumi spartani, propugnatore costante di libertà e di giustizia, quest’ uomo di Plutarco, come lo chiamò Antonio Tari, tornò a Napoli il 28 aprile 1848 da Malta, ov’ era rimasto tutto quel tempo, traendo la sussistenza giornaliera dalla pubblicazione d’un primo periodico dai titolo Giù la tirannide, e poi di un secondo II vagheggiatore delle scienze e delle lettere. Appena però pervenuto alla capitale, apprendendo le ripetute richieste fatte dal popolo napoletano, specialmente con un’ imponente dimostrazione nella fine di marzo del ’48, diretta ad indurre il re ad abolire la Camera dei Pari o per lo meno a fare esercitare dalla nazione il dritto di nominarli, nonché a stabilire lo Statuto costituzionale sopra basi più larghe, e, sicuro che il re avrebbe sempre nicchiato, fino ad irrompere, in risposta, con la reazione, stabilì, con amici, di riunire cinquantamila provinciali armati sulla montagna di Monteforte e adiacenze, i quali avrebbero dovuto rimanere come in un campo di osservazione, pronti ad accorrere in Napoli nel caso che il re avesse tentato d’invadere la Camera dei deputati coi suoi pretoriani. E, intanto, in .vista dei continuati tumulti del popolo, invitato dal primo ministro Carlo Trova ad avere un colloquio col re per trovarvi un espediente conciliativo, Zuppetta si rifiutò, accettando invece un colloquio col ministro, che infatti ebbe luogo. In quel rincontro, per ovviare alle incoerenze del decreto del cinque aprile, dal quale prendeva forza di legge il programma ministeriale, pubblicato il tre dello stesso mese, e per allontanare un conflitto, scrisse un Progetto di riforma della Costituzione, allo scopo di respingere il paragrafo 5.° del citato programma, così redatto : « Aperto che sarà il Parlamento, le due Camere, di accordo col re, avranno la facoltà di svolgere lo Statuto, massimamente in ciò che riguarda la Camera dei Pari », e proponendo invece che i rappresentanti della nazione, di accordo col re, avessero la facoltà : 1.” Di decidere se convenga o no conservare la Camera dei Pari ; 2.° Nell’ affermativa, di determinare le regole fondamentali per la nomina dei Pari ; 3.° Di fare tutte le modificazioni alla Costituzione, credute necessarie per meglio assicurare la felicità della nazione. Tale progetto venne subito comunicato al re, che non volle accettarlo. E fu allora che il Zuppetta, vedendo prossima la catastrofe, partì la sera del quattro maggio per Foggia, ove ansanti lo aspettavano i suoi elettori.
Ma con lui o forse anche prima di lui vi giunse Saverio Barbarisi, quel generoso che, come dicemmo, nel mattino del ventisette gennaio in Napoli, cinto della fascia tricolore, si era visto a capo della famosa dimostrazione che mise i brividi nelle vene di Ferdinando, e che, precedendo il carro trionfale dei disciolti prigionieri politici, allo apparire delle bandiere rosse sugli spaldi di Castel s. Elmo, gridò al popolo : « ecco il segnale della vittoria, i nostri nemici han paura», — quell’ardente spirito ribelle ad ogni sopruso, che quel di istesso, tra l’agitarsi del vessillo tricolore dalle carrozze e dai balconi in piazza s. Ferdinando, intimò alla folla di sciogliersi, esclamando : « figliuoli, a rivederci liberi domani ! »
- fi) Vedi Pochi articoli e miscellanei, scelti fra i molteplici deìl’avv. Lui<ri Zuppetta, -Napoli, A. Eugenio 1886.
Villani — Cronistoria dì Foggia 4
Di lui scrisse un suo contemporaneo, che preferì, per tema di una rappresaglia da parte del Borbone, nascondere il proprio nome sotto il pseudonimo Un italiano, e che ne porse il preciso profilo col dire:
« Saverio Barbarisi nacque a Foggia addì 30 gennaio 1780 da Giuseppe e Gaetana Verillo. Nei suoi anni del primo vivere ricevè quella educazione letteraria che in un semplice seminario di provincia poteva riceversi in quel tempo. Poscia indirizzò l’ingegno alle rigide discipline amministrative e forensi, e per tal guisa fecesi innanzi per tal via, che nel 1805, quando avea passato appena il quinto lustro, venne adoperato dal governo francese alla formazione di una legge sul Tavoliere di Puglia, e si ebbe in premio la nomina a governatore doganale di Ravello e Scala. Nel 1808 entrò nella magistratura con la nomina di giudice di pace a Barletta : nel nel 1812 fu promosso a giudice di prima istanza a Bari, e finalmente nel 1° di febbraio 1819 assunse la carica di giudice di gran Corte criminale a Lecce. I suoi rapidi progressi, in quei tempi assai diversi dai nostri per la grande moralità che aveva la magistratura, sono indizio della sua imparzialità e solerzia neh” amministrazione della giustizia, ma incontrovertibile argomento ne è la sua esonerazione nel 1821. Quando l’intendente della provincia, il famigerato Guarini, ebbe commesso ogni maniera di soprusi e di nequizie, la Corte criminale (e fra i votanti vi era il Barbarisi) nel 1819 lo sottopose a giudizio. Quando, al cadere della libertà costituzionale del 1820, i peggiori, che son sempre strumento necessario alle reazioni politiche, s’ insignorirono della somma delle cose, il Guarini, non ultimo tra costoro, denun-ziò tutt’ i giudici della gran Corte criminale di Lecce come carbonari, e sollecitò il governo di Ferdinando I a svellere la mala pianta ; e questi, appoggiandosi alla fede incrollabile di quell’ egregio amministratore, depose i giudici dal loro ufficio. Vi è taluno di quei giudici che poscia ha venduta l’anima al governo, ed occupa oggi una delle prime cariche nella magistratura suprema; ma il Barbarisi si mantenne puro ed inviolato, e, recatosi in Napoli, dalla Ruota ove dignitosamente avea seduto, passò alla bigoncia, luogo or non men dignitoso del primo, essendo il santo amore del dritto che informa i pensieri di colui che vi ascende. In tal guisa egli passò moltissimi anni fino al 1848, intento a procacciarsi di che vivere con onesti sudori. Quegli anni si dissero quieti, ma era quiete di sepolcro ; e come nella tomba il cadavere imputridisce, così parimente il nostro sciagurato paese divenne immondissimo lezzo : e rettili, nati a strisciarsi sul suolo, vi germogliarono in gran copia. Ma lo spirito di Dio rinnova ad ogni istante nelle viscere del creato la fiammella vitale, e quando il demone dello sconforto ha convertito in tomba gli esseri della terra, 1′ angelo dei venturi destini evoca da quella tomba gli spiriti, e si genera la via dell’ umana convivenza. E questi spiriti sono evocati, che conservarono nel segreto del loro cuore la santa fiamma del bene, che custodirono nella sua purezza, come un sacro deposito, l’idea dell’ avvenire, e concordi si affaticarono ad erompere da quella tomba per sorgere ad una vita novella. E fra questi spiriti vuoisi noverare Saverio Barbarisi, che caldi affetti nutrì sempre per il miglioramento civile del suo paese, anche quando la tirannide, fatta forte della sua vittoria, insaziabile come la lupa di Dante, addestrandosi negli arcani delle coscienze, forzava gli animi ad esser muti con sé stessi, perché il segreto desiderio non venisse punto trapelato. E quando il soffio della novella vita spirò per le contrade italiane, quando moltitudini, sorgenti nel nome santo di Dio, chiesero libertà, quando questo generoso popolo napoletano il 27 gennaio del 1848, parlando la parola del diritto, chiese inerme al suo principe la garantia giuridica di una Costituzione monarchica rappresentativa, Saverio Barbarisi, il carbonaro del 1821, che aveva alimentato, in una coi suoi compagni, quel santo alito di libertà nei giovani petti, fu tra i primi, benché vecchio e affralito dagli anni, ad inanimire i suoi concittadini, e, col coraggio della giovinezza, levò il grido della libertà costituzionale, salutando l’aurora del nuovo giorno. Ma fin da quando fu data la Costituzione, dal 29 gennaio, la parola che pronunciò il Barbarisi fu quella della moderazione, perocché vide soverchi tripudii, baldanza eccessiva, puerilità senza pari, vide che una moltitudine cieca sforzavasi a far sì che il popolo napoletano rassomigliasse al proprio emblema del cavallo, indocile ad ogni freno. Ma la moderazione di Barbarisi non era simile alla viltà di coloro che, vedendo 1′ uomo annegarsi, non si slanci a difenderlo dall’onda; la moderazione di Barbarisi fu diversa dalla inerte e codarda quiete di molti, cagione unica di ogni nostro travaglio. Egli cercò tutti modi perché si formasse un’ adunanza di pochi cittadini devoti alle novelle instituzioni con poteri pieni ed eccezionali per antivenire ogni turbamento alla pubblica quiete. Quel vecchio bene intendeva che se il movimento popolare è necessario a conquistare la libertà, condizione indispensabile a conservarla è il mantenimento dell’ ordine ; quel vecchio ben comprendeva che nei momenti difficili e pericolosi dello introducimento di un novello sistema, che ha tanti nemici, quanti son coloro che profittarono del passato, non si può far senza di provvedimenti eccezionali e rigidi che preparino 1′ attuazione di un avvenire migliore. Ma il suo pensiero non venne accolto : ed il Ministero di quel tempo, credendolo uno dei molti che chiedevano impiego, lo nominò giudice criminale : ma egli ricusò quel posto come colui che desiderava la libertà, non il potere, il publico bene, non il lucro privato. Alla sua novella richiesta per la nomina di una Commissione suprema di Stato, il ministro Bozzelli credette di appagare il Barbarisi, nominandolo commissario di polizia, quasi che colui, che aveva ricusato 1′ ufficio di giudice, avesse avuto poi vaghezza d’indossare una divisa odiata ed abborrita. Pure il vecchio onorando pensò che potesse essere di giovamento la voce della canizie, che insinuava a tranquillità e moderazione, pensò che la polizia costituzionale avrebbe dovuta divenire una istituzione accetta al paese quando uomini rivestiti della pubblica fiducia la rappresentassero ; pensò che il fango del vecchio sistema non potea giungere a contaminarlo, ed accettò 1′ ufficio di commissario di polizia del quartiere di Montecalvario, ricusandone lo stipendio (1). Ed operosamente si sforzò a mantenere tranquilli gli animi il più che si poteva e, sopra tutto, esortava di continuo a più moderata condotta una mano di giovani studenti che, raccolta nella bottega da caffè sotto il palazzo Buono in via Toledo, e, sollevata da parecchi malvagi, erasi data a politicare, e vagava in dimostrazioni ed animate discussioni, nel che fare affrontò coraggiosamente gì’ impulsi e le minaccie di quella schiera di giovani traviati, ma innocenti (perché la gioventù non può essere maligna) ; e se V onda degli eventi travolgeva i suoi sforzi come il torrente trascina dietro di sé qualunque cosa trovi per via, pure non è a tacere che i suoi sforzi furono commendevoli, perché tutto egli fece quanto era in suo potere per salvare la patria pericolante. Nella sua provincia pervenne intanto la fama della sua devozione agi’ instituti popolari, onde nella medesima ed in quella di Bari, ov’ era stato magistrato, il suffragio elettorale lo prescelse a deputato del Parlamento. Ed egli alla voce del paese, che affìdavagli il santo mandato di rappresentare i suoi diritti, ricusò F ufficio di commissario di polizia. Ma Carlo Troya, capo del Ministero in quel tempo, veniva di continuo ragguagliato di disordini che molestavano la Paglia, e sospettava perciò che ivi si alimentassero sentimenti di repubblica e di comunismo. Pensò egli allora d’inviarvi un uomo, che, godendo la fiducia del popolo, potesse raddrizzare le opinioni, insinuare la legalità negli animi, e sviare ogni pensiero di repubblica e di comunismo. E a tal’ uopo elesse il Barbarisi come quegli che godeasi la fiducia della Puglia ed erasi in Napoli mostrato, con fatti inoppugnabili, l’uomo delle istituzioni costituzionali. Il Barbarisi accettò quel difficile carico, diffìcilissimo per la condizione dei tempi, dopo molte istanze del Troya, e lo adempì scrupolosamente ecc. ».
(1) II Barbarisi. in quella occasione, volle rendere pubblico ringraziamento al sovrano per una tale nomina, il 16 marzo 1848, con un folio a stampa pei tipi all’insegna del Digione, e sotto il titolo : Parole dell’ aevocato Saverio Barbarisi per la sua nomina a commissario di polizia di prima classe, ringraziamento che terminava con queste parole ben gravi: «Quando l’inquisizione attuale degli avvenimenti, clip lianno avuto luogo da lunedì passato in poi, sarà livellata ai fatti, vedrà V. M. se la gioventù o la tristezza di taluni agenti segreti, immorali, nemici di Dio e della nazione, abbia i disordini promossi. Prudenza è prevenire gli avvenimenti; e chi non si mette nel caso di regolare la rivoluzione, sarà dalla rivoluzione trascinato o il voglia o non lo voglia. Se i veri bisogni dei popoli, se i loro desiderii si fossero valutati e secondati, disordini non vi sarebbero stati, le tante disgrazie non si sarebbero vedute, e ‘! tanto sangue cristiano non si sarebbe sparso ».
E, dopo questa duplice presentazione, eccoli tra i comuni elettori di Foggia Luigi Zuppetta e Saverio Barbarisi, due schietti liberali entrambi, ma, com” è chiaro, di gradazione affatto diversa: 1’uno, potrebbe dirsi, rappresentava l’elemento impulsivo rivoluzionario senz’ alcun limite, la sbuffante locomotiva a tutto vapore, l’altro il freno moderatore.
Accolto nella nostra città dal delirio di un popolo, come non mai alcuno venne per lo innanzi accolto, Luigi Zuppetta, da Foggia, ove sarebbe presto ritornato, continuò per Lucera e per la sua Castelnuovo, ove volle riabbracciare i congiunti dopo tanti anni di esilio, rimanendo colà appena tre ore.
Saverio Barbarisi, per contrario, era in Foggia da qualche giorno, avendo preso stanza dapprima nell’ albergo Apicella, sulla piazza del teatro, e poi passando in casa del suo amico Bartolomeo Iacuzio, consigliere della gran Corte civile, casa che, a quell’ epoca, trovavasi affatto vuota per l’assenza di costui. Egli avea già visti i maggiorenti della città e del partito liberale, che gli avevano fatto intorno grande festa, ed aveva cementato ancora più nei loro animi, mercé la sua figura serena e la sua parola limpida e calda, l’antico, profondo affetto. E parlò ai suoi elettori la parola franca e sincera del convinto liberale, eccitandoli ad attaccarsi ferreamente alle libere istituzioni monarchiche rappresentative come all’unico faro di salute per l’avvenire della patria comune.
E là, nella casa di Agnello Iacuzio, ove Gaetana Facci-longo, la sua degna compagna, aveva accolti nei giorni delle sette e delle sventure, come accoglieva tuttora, gli amici di suo marito quali fratelli, scaldando la sua anima gentile di donna alle idee più ardenti e bellicose senza impaurirsi di possibili compromissioni, e imitando così le più grandi eroine del nostro risorgimento, che non temettero la bipenne del carnefice, pur di pronunziare il santo nome di libertà e di patria,— nella casa di Agnello Iacuzio, dicevo, Luigi Zuppetta rivolse la prima volta, al ritorno da Castelnuovo, la sua parola tribunizia agli elettori foggiani. Quivi egli volle aprirne le menti, spiegando, fra l’altro, che cosa dovesse per davvero suonare la frase svolgere lo Statuto, ch’era una facoltà già ottenutasi dal programma ministeriale del tre aprile, e che significava ‘modificare, riformare ed anche rifare da capo a fondo. E in uno dei punti del suo magnifico discorso, a più facilmente essere compreso dagl’intelletti poco elevati, cacciò di tasca una pezzuola, e, sogghignando, disse : « Svolgere lo Statuto non significa certamente lo stesso che svolgere questa pezzuola, ma aggiungervi altresì larghe franchigie, che dal Parlamento si crederanno opportune. E le migliori franchigie sono allora possibili quando la mo-narchia sia non più ereditaria, ma elettiva, o si formi presso di noi lo stato popolare ». A tale scatto impreveduto e inaspettato l’uditorio come un sol’uomo, tra frenetici applausi, giurò di sostenere, all’occasione, anche con le armi le proposte che avrebbero fatte alla Camera i deputati, cervello e cuore del Paese. Tra i liberali foggiani, ivi presenti, si notavano, in prima linea, Agnello Iacuzio, Francesco Paolo Vitale, Giovanni de Anellis, Michele Ricca, Carmine Durante, Felice Patierno, Luigi de Noia, Michele Achille Bianchi, Vincenzo Luigi Baculo, Nicola Sanna, Scipione Cafarelli, Vincenzo Barbarisi, GaetanoTan-zi, Raffaele Mirasole, Domenicantonio Berardi, Vincenzo Russo, Orazio Sorge, Luca Pece, Vincenzo Petrilli, Nicola Mancini, Pietro de Piato e Gabriele Cicella, — 1′ ardimentoso scolopio, che non si era sgomentato, giorni prima, di accendere, dal pulpito della chiesa di s. Gaetano, i fedeli a liberi sensi, e di spiegar loro, con vividi colori, le finalità vere della Costituzione ; quel Gabriele Cicella, che, dall’ arringo passato ali’ azione, avea di già affa-sciati tra loro tutt’ i parroci della città e fondata con essi una setta politico-religiosa sotto il nome di san Giovanni Battista. Si stabilì allora di fornire di buone armi e di munizioni non solo la guardia nazionale, ma anche i privati, perché tutti, indistintamente, dovevano essere, in casi estremi, paladini di libertà.
Della esecuzione di questo deliberato ebbe incarico speciale 1′ avvocato Michele Ricca, come colui che affidava per attività ed energia veramente singolari.
Queste idee avanzate si sparsero per la provincia intera con la celerilà di un torrente in piena, anche perché correva già per le mani di tutti, da più giorni, un opuscolo incendioso dello stesso Zuppetta dal titolo Le sette contraddizioni capitali della Costituzione data da Ferdinando, e che ne avea già scombussolate le menti. Non ci fu paesello, allora, già stremato dalla miseria, dalla fame, dai balzelli e dai soprusi di ogni genere, che non avesse nell’idea di una libertà sconfinata, che taluni confusero, senza fors’ anche volerlo o saperlo, con la repubblica, non dico imitato, ma anche preceduto il capo-luogo, e non fosse già pronto a levarsi in arme aneli’ esso per propugnarne, ad un dato momento, il trionfo. Agnello lacuzio, d’altra parte, il supremo animatore del comitato, era in continuo e febbrile contatto coi rivoluzionarii delle altre provincie, ed aveva all’uopo già presi opportuni accordi per un’azione comune e decisiva. Tanto è ciò vero, che il tredici maggio ’48, quando venne arrestato, in San Lupo, Antonio Romano Mozzicone, l’energico settario, già condannato ai ferri dalla Corte criminale di Campobasso, furono trovate nelle tasche di costui tre lettere scritte e sottoscritte da uno dei più solerti cospiratori, Raffaele Crispino, cancelliere del giudicato regio di Colle, posteriormente punito nel capo dalla Corte speciale di Napoli, una delle quali era diretta appunto ad Agnello facuzio, cui non potè essere ricapitata. In questa gli si accludeva un proclama a stampa, edito da Giuseppe Bardano, capo di un comitato segreto partenopeo e presidente il circolo del Progresso, sito in Napoli alla salita Magnocavallo, che, già affisso altrove, spronava i deputati, in nome del popolo e della nazione napoletana, a riformare democraticamente la Carta costituzionale, e finiva con 1′ avvisare che se il potere esecutivo non facesse senno, e, se nel mettere in atto la nuova Costituzione, usasse le solite infamie di governo, il popolo sarebbe andato più innanzi ancora, ricordandosi che desso è sovrano. E la lettera di accompagnamento al lacuzio, per non destar sospetti, in caso di scoperta, era concepita anfibologicamente così :
Carissimo amico D. Agnello,
Di replica alla vostra risposta, comunicatami per mezzo del comune amico D. Gaetano de Peppo, vi prego caldamente di preparare tutto l’occorrente per dar compimento alla stipula finale del nostro istrumento. Vi prego per amor di Dio a non trascurare cosa alcuna per non perdere la preziosa occasione di rialzare energicamente i nostri interessi. Il giorno della stipula vi sarà designato da me o dal signor D. Antonio To-ricelli. Vi raccomando il latore della presente Giuseppe Lepre di Benevento, il quale si reca costà per guadagnare un carlino. Resto abbracciandovi con tutti gli amici e sono
Napoli, 3 maggio 1848.
- Crispino.
Corrispondenza, che la Corte speciale di Napoli, occupandosi, nel processo pei fatti del quindici maggio, della sorte del Crispino, chiamò « rea », appunto perché piena di frasi metaforiche, che disvelavano, in confronto di un folio di norma emesso dal circolo del Progresso, una perfetta coincidenza, rivelatrice delle mene della cospirazione, di cui compartecipe veniva estimato il nostro Agnello lacuzio (1). Invano il giornale delle Due Sicilie si affaticava a ripubblicare e a rendere universali le saporifere circolari dei sotto-intendenti, sperando così di calmare le nevrotiche masse, che il bromuro, gittato anche a quintali tra le schiere dei rivoluzionarii, non avrebbe potuto più produrre l’effetto che le autorità si proponevano. La notte del 9 maggio ’48 Saverio Barbarisi lasciò Foggia e partì alla volta di Bari, mentre Luigi Zuppetta, che contemporaneamente avea fatta, il mattino, una corsa a Lucera, tornò la sera a Foggia, ove volle novellamente parlare agli elettori nella casa del notaio Michele Rispoli. E parlò da par suo intorno alle finalità vere della Costituzione, esaminata nella sua più ampia essenza ; e dischiuse loro, tutto il suo pensiero, manifestando persino di avere prove ineluttabili che il re di Napoli cospirasse con l’ambasciata austriaca, frattanto che i più ferventi liberali fidavano, sicuri, nelle promesse di lui.
(1) Vedi nelle due Decisioni della Corte speciale di Napoli dell’ 8 ottobre 1852 e del 20 agosto 1853, pubblicate dalla stamperia del Fibreno.
Ei quasi profetizzava che se non si fosse curato di opporvi in tempo un riparo qualsiasi, da un istante all’ altro i liberali si sarebbero trovati miseramente in catene. Qui si tacque. Ma a coloro che mostrarono di voler sapere quale argine potesse difenderli dalla marea incalzante e micidiale, ei si limitò a rispondere : « Ancora due giorni e vi aprirò la mente », risposta che rimase sempre un enigma pei foggiani, i quali ignoravano il suo progetto dei cinquantamila armati su Monteforte, progetto che poi non riuscì ad attuarsi per il mancato consenso degli uomini influenti delle provincie meridionali.
E mentre la parola calda e scultoria di questo cavaliere senza macchia e senza paura eccitava, quasi tutte le sere, gli animi dei foggiani, pervenne in quella città, da Cerignola, il novello segretario generale dell’ intendenza di Capitanata, Girolamo Fuccilo, già consigliere d’intendenza di Basilicata. Egli, in assenza del nuovo intendente, il quale non ancora si era fatto vivo, trovossi ad assumere le funzioni di capo della provincia ; e, in mezzo a tanto fermento, che aumentava ad ogni passo e che facea prevedere brutti giorni di lotte, egli, ignaro del luogo, si vide in serio imbarazzo dal primo dì, e non seppe trovar modo di stringere i freni con qualche garbo per evitare un pubblica disastro. Ma il dodici di maggio, già partito per Napoli il Zuppetta, scampato per un miracolo da un massacro in Grottaminarda ad opera di fanatici ignoranti, cui si fece credere per lo meno ch’ egli avesse bandito in Foggia il comunismo, tornò in questa città Saverio Barbarisi, dopo di essere stato a Lecce, a Bari, a Barletta, a Trani, a Giovinazzo, a Cerignola, ove aveva tutti entusiasmati con l’inneggiare alla conquistata libertà, inoculando ad un tempo in ognuno la fede illimitata nelle istituzioni rappresentative monarchiche per l’avvenire salutare della patria, e tornò per trattenersi coi suoi elettori anche un altro giorno solo, dopo di che avrebbe anch’ egli continuato il viaggio per Napoli a causa dell’ imminente apertura del Parlamento, il Fuccilo, in vista degli animi concitati di buona parte della provincia e del panico che aveva invasi i timidi, sbarrati nelle loro case con i conigli in corpo, tentò di serrare il pugno ad oltranza, convocando ali’ uopo, per gli urgenti provvedimenti, il Consiglio di pubblica sicurezza, da poco instituito, ed anche già in parte modificato nei suoi membri dopo i clamori per Tibi. Oltre che il Fuccilo fece mostra di un apparato di forze, da far credere che si fosse davvero alla vigilia delle barricate. Il Barbarisi, non appena riveduti i suoi amici, apprese da loro la paura che aveva invaso il Fuccilo, nonché i suoi preparativi di difesa o di violenze ; e, fedele al suo antico giudizio che F autorità avrebbe dovuto nelle presenti congiunture, ad evitare disordini, non inasprire vie più gli animi, ma saggiamente carezzarli e secondarli in certo modo per poter riescire a reprimerli con sicura efficacia, sorrise del sistema adottato da quel funzionario, come delle apprensioni di lui, e volle andare perciò di persona a vederlo nella sede dell’ intendenza.
Di parecchi tristi, intanto, chi avea sobillato ad arte che il Barbarisi fosse addirittura una spia del re e che desiderasse una strepitosa reazione di palazzo, chi avea fatto credere invece allo stesso Fuccilo, spaventato al novello apparire di lui come di uomo tornato dall’ antro di Trofonio, eh’ egli andasse invece sollevando le Puglie, corrompendo fmanco il carattere degli stessi uomini pubblici con gl’identici propositi del Zuppetta, ratificati da lui medesimo, coram populo, anche in Foggia a note ben chiare e scevre di sottintesi. Di modo che in quei momenti di grossolane precauzioni poliziesche, senza essersi provato quale granito fosse stato liquefatto da lui, quale Margherita sedotta con monili di gemme o qual Fausto persuaso a scrivere col sangue il patto di vendersi 1′ anima, lo si mise quasi al pericolo di subire delle sopraffazioni. Ma, ad onta di ciò, ripeto, il Barbarisi si presentò al Fuccilo, e, spoglio d’infingimenti o d’ipocrisie, ma con baldanza che scaturiva gigante dalle sue profonde convinzioni, gli disse che ormai la rivoluzione, per un maggiore miglioramento delle istituzioni liberali, non poteva più evitarsi, e che il secondarla sarebbe stato un dovere da parte dell’ autorità politica, se non si fosse voluto, col soffocarla, un inutile spargimento di sangue. Solo così il regime costituzionale avrebbe ottenuta la sua vera fisonomia, altrimenti ogni altra idea sovversiva sarebbe stata alimentata dalle stesse intemperanze di chi pretendeva sopprimerla. Ei domandava, perciò, al custode dell’ ordine pubblico, ali’ intendente di Foggia ogni suo concorso, sia pur negativo, per non veder manomesse senza scopo la libertà e la vita dei cittadini. E in ciò dire la sua voce atteggiossi ora a suono di preghiera, ora a quello di minaccia. Il Fuccilo, traendo coraggio dal pericolo, tenne duro, e non si allontanò d’un passo dal suo programma ; che anzi invitò il Barbarisi a partir presto per Napoli, ove appunto avrebbe potuto nella Camera, meglio che in altro luogo, esplicare in vantaggio delle masse ogni idea di perfezionamento della Costituzione.
Il Barbarisi la sera stessa lasciò Foggia, che non riprese, perciò, l’antica calma, ma che continuò ad agitarsi, ora palesemente, ora latentemente, secondo che le repressioni più o meno violenti dell’ autorità politica glielo permettevano, autorità che non lasciò mai di credere, e con lui moltissimi altri, che si fosse potuto in Foggia, prima del quindici maggio, verificare un serio scoppio rivoluzionario, tendente alla proclamazione della repubblica.
IV.
La Capitanata, a consiglio dei più saggi, aspettò fidente, ma con 1′ arma al piede, il risultato dell’ opera dei suoi deputati, i quali, fin dal primo istante di loro esplicazione, si mostrarono all’ altezza del mandato ricevuto, e non furono perciò da meno dei loro colleghi per valore, per disinteresse, per energia. Fin dal 12 maggio ’48, infatti, 1′ on. Ferdinando de Luca di Serracapriola si era agitato non poco tra coloro che intervennero in Napoli a casa dell’ illustre medico foggiano e noto liberale anch’ egli, che sfidava imperterrito la ghigliottina, Vincenzo Lanza, quando, cedutasi a costui la presidenza del1′ adunanza dall’ ottuagenario arcidiacono Luca Samuele Cagnazzi, si prese a discutere vivacemente intorno alla voce corsa che si volesse dal re imporre alle Camere giuramento di osservanza puro e semplice allo Statuto del 10 febbraio, sopprimendo il già concesso svolgimento. Il de Luca si scagliò con gli altri e forse più degli altri contro la possibilità d’ un tal fatto, che dimostrava la poca lealtà del re e un primo accenno a un colpo di Stato ; e venne incaricato coi deputati Mancini, Cacace ed Orlale di presentarsi al Consiglio dei ministri per ottenere che il programma, destinato a pubblicarsi, fosse dispogliato di ogni pretesto di dissidii, e che la prestazione del giuramento fosse rinviata ad un tempo posteriore alla verifica dei poteri. Ma fu tratto in inganno anch’ egli, il nostro de Luca, con tutta la rappresentanza nazionale, perché com’ è noto, mentre il ministro, dalla doppia faccia come le stoffe inglesi, avea fatte le viste di trovar giusta la proposta, richiamando all’ uopo dalla tipografia gli stamponi del programma per correggerli in tal senso, la mattina del quattordici maggio esso fu trovato integralmente immutato, per la qual cosa si acuì in ognuno il sospetto già surto d’ un colpo di Stato. E in quella stessa malaugurata sera, allorché un’ immensa calca di popolo si raccolse davanti al palazzo di Monteoliveto e gridò reiterate volte : « Deputati, il re tradisce la nazione, il re v’ insidia ; ma non temete ; coraggio, coraggio ! noi siamo qui per la vostra difesa », il deputato Luigi Zuppetta si fece tosto ad uno di quei balconi, e rivolse al popolo le seguenti parole, che i posteri ricorderanno con venerazione per chi le pronunziava : « Cittadini, tranquillatevi intorno al contegno dei deputati. I rappresentanti della nazione, o almeno quelli che sono degni di tal nome, non hanno bisogno di essere incoraggiati per lo adempimento dei proprii doveri. Essi diventeranno cadaveri prima di cedere alle pretese del re ». E la notte del quattordici, nell” aula medesima di Monteoliveto, quando dopo infinite discussioni intorno alla formola del giuramento da prestarsi dalle Camere, e dopo un via vai di messaggi, scambiatisi inutilmente tra i deputati e il re, per adottarsi formole diverse, Ferdinando di Borbone strappavasi la maschera dal viso, ordinando ai suoi croati di uscire dai quartieri, al che il popolo, indignato, improvvisò la prima barricata in quelle vicinanze per difendere la rappresentanza nazionale, fu Saverio Barbarisi destinato col Lanza, col Romeo, col Capocci, col Galletti e con Spaventa a parlare al popolo. Egli, più che altri, esercitava su di questo la più grande ascendenza, e lo avrebbe indotto senz’ altro a disfare la prima barricata e le altre susseguenti per non compromettere le sorti della Costituzione, essendosi allora allora ottenuto, mercé la loro fermezza, che si aprisse il Parlamento col solo discorso della Corona e senza il giuramento, se il La Cecilia ed altri repubblicani non avessero soffiato sul fuoco. Ma era già troppo tardi in opporsi al divampare dell’ incendio. Per lo che fu allora che Luigi Zupetta, quell’ animo fiero ed inflessibile, volendo profittare dell’ entusiasmo popolare del momento, presentava, invece, alla Camera questa proposta ardimentosa, contenente l’ implicita e necessaria decadenza della dinastia :
« Onorevoli deputati ! A vista degli avvenimenti incalzanti, io v’ invito a prendere la seguente deliberazione. — La Camera dei deputati della nazione, veduta la formola di giuramento inviata dalla Camera al Ministero ad effetto di provocarne l’adesione del re ; — veduta la formola di giuramento inviata dal re alla Camera , formola diametralmente opposta a quella reclamata dallo Statuto costituzionale, dall’ unanime consenso dei deputati e dal voto di tutta quanta la nazione;—considerando che niun’altra formola di giuramento possa essere razionalmente sostituita a quella proposta dalla Camera dei deputati ; — che le capziosità del re tendano a precipitare la nazione nell’ anarchia e nel sangue ; — che il rifiuto del re all’ adesione ad un atto in perfetta armonia coi principii dello Statuto costituzionale obblighi la Camera alla pratica di doveri analoghi alla urgenza della situazione ed alla salvezza della patria; delibera: 1.° non potersi per niun conto accettare la formola del giuramento inviata dal re alla Camera;— 2.° tenersi il rifiuto dei re all’adesione alla formola del giuramento proposta dalla Camera come una flagrante infrazione allo Statuto costituzionale ; — 3.° voler neutralizzare le mene insidiose del re col tenersi riunito il Parlamento in virtù del solo mandato della nazione, fonte e principio di ogni sorta di potere ». Quale proposta, respinta a grandissima maggioranza dai deputati, in grazia, coni’ egli stesso ebbe a riferire in un suo scritto, degli sforzi riuniti dei così detti moderati, di cui uno lo apostrofò financo, chiamando quella sua proposta un degno parto del Robespierre redivivo. Ma, in seguito a tale rigetto, il Zuppetta non si arrese, e a notte alta compilò altra proposta più audace, che fu questa :
« Onorevoli deputati ! V invito a deliberare : — Prima del1’alba i deputati delle provincie usciranno, uno dopo l’altro, da questa sala ; e, prese le debite cautele, ciascuno si recherà nella rispettiva provincia e chiamerà sotto le armi le milizie civiche ». Naturalmente anche questa proposta non si vide coronata da successo.
E il quindici maggio, quando il cannone già batteva in breccia le barricate sulle vie di Napoli, e gli svizzeri, strumenti di viltà e di vendetta, scannavano centinaia d’innocenti, che non commisero altra colpa se non quella di voler vedere garentita la data Costituzione, tra cui non sarà mai troppo ricordare un Luigi La Vista, un Angelo Santilli, un Gustavo Morbillo, rimasero tutti impassibili e fermi al posto, che il dovere e l’onore loro prescrivevano, i deputati di Capitanata, al pari degli altri colleghi, nell’ aula di Monteoliveto, presieduti dall’ ottuagenario arciprete Cagnazzi, attendendo, come i vecchi senatori romani ai tempi remoti di Brenno, che si compisse anche contro di loro 1′ opera nefanda di sangue, felici di esporsi al martirio per la patria, che veramente, e non per posa, adoravano. Che anzi Luigi Zuppetta. scorgendo su di un tavolo due palle di cannone, raccolte presso il palazzo di Monteoliveto, e, memore degli sforzi fatti dai moderati, la sera precedente, nel combattere le sue proposte, ne afferrò una con convulsivo furore, anzi levandola in alto : « ecco — esclamò — in qual guisa re Ferdinando risponde alle promesse fatte al popolo ed alle proposte dei rappresentanti della nazione !.. Deputati moderati, ecco il frutto della moderazione spiegata verso il leale vostro re !» E in quell’ora solenne, in cui consumavasi il più alto tradimento da parte del Borbone, che fu perciò additato quale pubblico nemico, fu lanciata virilmente da un altro nostro deputato, Giuseppe Ricciardi, e votata la mozione di eleggersi un comitato di sicurezza pubblica con pieni poteri, composto del marchese Topputi, presidente, e di Vincenzo Lanza, Gaetano Giardini, Gennaro Bellelli e Ferdinando Petruccelli, i quali, mentre spedirono parlamentarii al generale comandante la piazza, nonché ai ministri per scongiurare un’atrocità senza precedenti, delegarono il nostro Ricciardi a condursi dall’ ammiraglio Baudin, comandante la flotta della repubblica francese, ancorata nel porto, per incitarlo a difendere e salvare Napoli dalla guerra civile. E tutti, senza eccezione e senza tentennamenti, i nostri deputati di Capitanata apposero la loro firma, tra le sessantasei, alla celebre protesta dettata da Pasquale Stanislao Mancini, di fronte alla nazione, all’ Italia intera, all’ Europa, quando, circondato il palazzo di Monteoliveto da truppe e da cannoni, un ufficiale venne ad intimare all’ assemblea di sciogliersi, — protesta fieramente consegnata a costui, in vista del sicuro trionfo della reazione, dal vegliardo presidente di codesto pugno di eroi. Tutti tutti sfidarono così il Borbone, che av’ea voluto compiere la più atroce delle vendette contro quanti avevano osato di porre una mano sacrilega sulla Carta statutaria, che avea biblicamente e ciecamente chiamata, con frase bozzelliana, l’arca santa dei diritti del popolo e della Corona.
1 liberali foggiani, che aspettavano di apprendere il risultato dei primi attacchi da parte dei deputati alla Camera intorno allo svolgimento dello Statuto, parvero si smagassero un poco, quando, verso il tramonto, mercé un telegramma avutosi da Napoli, seppesi seccamente che l’apertura della Camera era stata aggiornata. Che cosa era avvenuto ? Quale ragione avea potuto indurre un tale provvedimento ? Essi nulla seppero affatto indovinare ; e vissero parecchio nell’ ignoranza, nell’ incertezza e nel mistero, non essendo, per giunta, arrivata quel dì la messaggiera postale, pel cui tramite sarebbero potuto pervenire notizie esaurienti e sicure. Poco dopo si annunzio che il telegrafo ad asta non funzionava più lungo la via ; e sospettossi che il guasto fosse causato dalla mano de’ reazionarii. Ed ecco, per conseguenza, uno spunto di panico nella cittadinanza, di cui vollero profittare i più audaci per intorbidare le acque e mettere le autorità in iscompiglio. Insomma vi fu un pandemonio tale che il ff. intendente Fuccilo stava per dare il capo nel muro, non sapendo come frenare e disperdere sobillazioni e preoccupazioni. Pensò egli inconsideratamente, preso da vero sgomento, di chiamare sotto le armi la guardia nazionale e di trattenere in città un battaglione di fanteria che era diretto a Bari; — dico inconsideratamente, perché bastava un nonnulla per dar valore alle notizie di una possibile reazione, che andavansi buccinando; e il subitaneo apparato di forze, infatti, accrebbe in tutti 1′ allarme. Alla intendenza chiunque si propose di andare a chiedere informazioni sullo stato reale delle cose non trovò chi non gli facesse spallucce; e così il sospetto di gravi avvenimenti, che si volessero tener celati ad ogni costo, pigliava in ognuno maggior forza e consistenza. E per due giorni interi, due lunghissimi giorni, si rimase in fitta tenebra, perché nulla di nulla venne mai a sapersi da chicchessia. Si giunse così al diciassette di maggio, quando si cominciarono ad avere i primi vaghi accenni delle turpitudini compiutesi per le vie di Napoli. Infatti il corriere postale, che dovea giungere a Foggia la sera innanzi e che, invece, venne la mattina a tarda ora, recò la meschinità di sole tre lettere, e fece parola, evasivamente, di un fatto d’ arme consumatosi tra la guardia nazionale e la truppa, nonché d’un fuoco ben nudrito, durato per ventiquattr’ ore, anche per parte del popolo, durante le quali vi erano state molte vittime, ma senza accennarne le cause. Soggiungeva che la messaggiera, oltre di essere partita il mattino avanti, anzi che la sera secondo il solito, avea dovuto passare sopra mucchi di cadaveri pesti e nudi, perché i lazzari, quasi mossi da subitanea furia di cannibalismo, ne aveano fatto triste governo, portandone via anche le vesti. Una tale notizia mentre funestò tutti, non mise alcuno in condizione di sapersi dar ragione di sì grossa carneficina. Né all’ intendenza, né al municipio si era in grado di darne un centello di più per ammorzarne la grande e giusta sete di curiosità, tanto che Fuccilo avea spedita ali’ uopo una staffetta sino ad Ariano, e si vide costretto di fare affiggere un avviso a stampa, col quale, invitando tutti a mostrarsi tranquilli, prometteva di comunicare senza riserve alla cittadinanza le prime ed ulteriori notizie che avrebbe ricevute. Ma ogni minimo particolare si potette apprendere la sera appresso, quando col parteciparsi ufficialmente il decreto di nomina del nuovo Ministero Cariati, in cui tornava ministro per lo interno il Bozzelli, nonché quelli di liquidazione e di disarmo della guardia nazionale, e del discioglimento della stessa Camera dei deputati, pervennero molte lettere di parenti e di amici a private famiglie, come del pari giunsero parecchi viaggiatori, testimoni oculari della strage, che il recente gabinetto, con la pubblicazione del suo programma di governo, cinicamente deplorava, comunicando all’uopo il dolore del re (!).
Non puossi immaginare quale cordoglio, misto ad indignazione, ebbe a provare Foggia intera, in tutte le sue gradazioni sociali, tanto che una moltitudine non mai vista si assembrò, rapidamente, col viso d’arme sotto il palazzo dell’ intendenza, quasi minacciando anch’ essa le barricate. Ma il ff. intendente Fuccilo, il maggiore del 7.° battaglione dei cacciatori, giunto allora allora pel buon’ ordine, i consiglieri d’intendenza e alquanti notabili della città, tra’ quali primeggiava, pei suoi modi cortesi e persuasivi, il signor Giuseppe Libetta, si adoperarono in ogni guisa a calmare gli animi di tutti, pur troppo frementi, per evitare una rivolta sanguinosa. Lo stesso Fuccilo, con un manifesto a stampa, mentre rendeva noti, secondo avea promesso, i fatti dolorosi svoltisi il quindici di maggio alla capitale, raccomandava al buon popolo foggiano di non turbare l’ordine pubblico, e di mostrarsi ossequiente, come sempre, alle leggi. Chiedeva in quest’ opera di pace il concorso dei buoni e di quanti si dichiaravano liberali e ligi alla Costituzione, potendo essere tutti fiduciosi nelle buone disposizioni del re verso il paese.
Il comitato liberale si riuniva, intanto, la sera del diciannove maggio in una sala del padiglione di s. Domenico. Quivi si tenne una vivace discussione sul da farsi, in vista della gravezza del momento, e si stabilì di nominare un sotto-comitato, composto da Giuseppe Libetta, presidente, che, in una seconda riunione, fu sostituito, dopo miglior consiglio, da Agnello Iacuzio, e, quali vicepresidenti, dal marchese Luigi de Luca e da Lorenzo Trabucco, nonché da Vincenzo Celentano, da Pietro de Piato e da Vincenzo Barbarisi, segretarii, per tentare la proclamazione di un governo provvisorio, e, contemporaneamente, di sguinzagliare messaggi a Napoli e nelle altre provincie per un’ azione concorde, riunendo all’uopo, tra i presenti, la somma di ducati trecento, che fu depositata, a quanto vuoisi, presso quel ricevitore Carmine de Martino. I fautori più accaniti per la proclamazione del governo provvisorio si mostravano Gaetano Tanzi, Giuseppe Garofalo e Giuseppe Giannini ; ma né essi, né il sotto-comitato, all’ uopo nominato, potettero smuovere la maggioranza dei cittadini, che non si decisero mai e poi mai a prendere una sì grave risoluzione, pur dandosi ad intendere che a Cosenza tale proclamazione fosse già un fatto compiuto, e che ad Ariano la rivolta stesse per trionfare, essendosi quivi fìnanco riesciti a distruggere il telegrafo, a impadronirsi dei cannoni della truppa regia, e a togliere al procaccio, per evitare che fosse andato a Napoli danaro, ben ventimila ducati, depositati poi presso il vescovo di quella diocesi. L’ avvocato Michele Ricca soffiava con tutta la forza dei suoi polmoni sul fuoco crepitante: si disse che altro fatto di sangue fosse avvenuto su per le vie di Napoli; che la guardia nazionale con i calabresi, radunati nella capitale per correre in Lombardia a combattere contro gli austriaci, avessero fatto vendetta degli svizzeri, e che in ogni parte della Capitanata si riunissero armati per dar braccio forte alla città di Foggia. Ma invano, ripeto, si tentò anche questa volta di sollevare il popolo, invano lo si tentò anche quel dì in cui si sorpresero in giro per le vie tre venditori ambulanti napoletani con un baule ricolmo di calzoni di tela, sì bianchi che grigi, tolti a Napoli il quindici maggio ai cadaveri dei soldati, e che cercavano di esitare a mite prezzo. Francesco Paolo Vitale, in qualità di vice-presidente del comitato, fece trascinare i tre ignoti innanzi al ff. giudice Antonio Sorrentini, e, seguito da centinaia di schiamazzatori, venne a pretendere egli stesso da quel funzionario che tutta la roba sequestrata fosse data alla folla per accenderne un rogo. Ma il giudice si denegò, e, fatto suggellare quel baule, mantenne in arresto i macabri spacciatori, evitando così una ridda infernale.
I liberali, però, che non aveano potuto ottenere, per ogni verso, la sperata sommossa in Foggia, si danno, di qui, con tutte le loro forze, ad alimentarla nei paesi della provincia. Ed ecco Carmine Durante, Scipione Cafarelli e Vincenzo Barbarisi, che si moltiplicano per far proseliti alla santa causa, or parlando a dritta ed a manca, or scrivendo lettere infuocate ai maggiorenti dei diversi paesi ; ecco Luigi de Noia che parte per Potenza allo scopo di prendere accordi con quei liberali ; ecco Orazio Sorge che fa alleanza con la Setta dei sette fratelli di Chieti ; ecco Agnello lacuzio che organizza la Bella Italia e stringe relazioni solidissime coi più ferventi rivoluzionarii di Savignano. E ciò non è tutto ancora ; che, avendo il comitato urgente bisogno di danaro, da mandato a Francesco Paolo Vitale di correre ad Ariano per intendersi con Vito Purcaro, che avea già sollevata quella cittadinanza, e che fu uno dei triumviri di quel governo provvisorio, condannato in seguito, prima a morte, e poi alla galera perpetua. Per lo che — quasi noi si crederebbe — ei riesce a sorprendere con altri la messaggiera postale e a toglierle di valigia ben seicento ducati. Ma qui non si arresta costui, che, ritornando su i suoi passi verso Foggia in compagnia di giovani ardimentosi, fa sosta al santuario dell’ Incoronata, e ottiene da quel rettore altra somma abbastanza rilevante. E di qui, passato a Cerignola, si armonizza perfettamente con quei capiparte e con la guardia nazionale. E da Foggia ei passa, senza prender respiro, nalla provincia di Bari allo scopo di collegarsi coi rivoltosi di Basilicata e di Calabria ; e da qui in quel di Lecce con l’intento di eccitare le popolazioni e indurle all’atto estremo di farli marciare per Avellino su Napoli. E per ragione di tali energici e bollenti emissarii, si accendono focolari pericolosissimi nella stessa provincia di Capitanata. Quindi a Bovino si formano nuclei di armati ; a Roseto, di pieno accordo con Iacuzio e Purcaro, si stabilisce che chi mostri di possedere un fucile vada rimunerato con quattro carlini al giorno ; — e vi fu gente che, con grossi sacriflcii di borsa, riuscì a munirsi, ignorasi come e da chi, financo di tre cannoni. A Cerignola la guardia nazionale si addimostra ardimentosa a segno da giungere a disarmare le guardie di pubblica sicurezza, venute colà per serbare 1′ ordine, e, impossessatisi dei loro fucili, spogliano dei valori la messaggiera postale, mentre ai soldati della riserva, di nuovo richiamati, vietano di partire. Così a Manfredonia, a Deliceto, a Lucera, a Sansevero, a Rodi, a Viesti uno solo è il motto d’ordine : « Alle armi per salvare la Costituzione ». La dieta di Potenza, cui avevano preso parte anche i rappresentanti della provincia di Foggia, pubblicava, il 25 giugno ’48, il suo atto famoso, che venne chiamato col nome di Memorandum delle provincie confederate di Basilicata, Terra d’ Otranto, Bari, Capitanata e Molise, e inondò di esso, con migliaia di esemplari, ogni angolo del regno. Ma anche dopo la pubblicazione di questo Memorandum, con la relativa inondazione, anche dopo quel ribollimento infernale che il comitato centrale di Foggia era riuscito a suscitare fin nelle più meschine borgate, non si potette quivi raggiungere, come dissi, la finalità della proclamazione di un governo provvisorio.
Se Foggia, però, rimaneva immutabile ed immutata rispetto all’ ordine pubblico, uno dei suoi figli, Giuseppe Ricciardi, corse a sollevare le Calabrie. E questa pagina gloriosa del nostro concittadino, che onora la città che gli dava i natali, è bene accennarla di volo per chi l’ abbia per avventura ad ignorarla.
Giuseppe Ricciardi, dunque, rifugiatosi dopo il quindici di maggio con Giovanni La Cecilia, il promotore delle barricate napoletane, nonché con i più accesi su d’ una nave francese, e sbarcato a Malta, compì l’ audace disegno di attuare la protesta firmata dai deputati innanzi di abbandonare l’aula di Monteoliveto, di congregarsi cioè in un luogo sicuro, donde far valere i dritti della nazione, sì miseramente conculcati. Sul Giglio delle onde piombò a Messina, ove prese accordi col Piraino; scese, poco dopo, a Villa S. Giovanni, e con Mileto, Romeo. De Riso, Plutino e Torricelli rivoluziono le Calabrie; quindi firmò a Cosenza il famoso manifesto, col quale, proclamando di essersi spezzato ogni vincolo fra principe e popolo, chiamava i cittadini alle armi. Novello Fabrizio Ruffo, inalberando, in nome della libertà, il labaro tricolore, come quegli nel novantanove, in nome del dispotismo, aveva innalzato il vessillo della Santafede, reggimento un pugno di uomini, e, ingrossandolo per via, intendeva rovesciare su Napoli una valanga di armati alla riscossa. E per lui pervenne la spedizione dei siciliani in Calabria sotto il comando del Ribotti, di quel generale che, in verità, come bene osservavasi, se avesse avuto il genio ed il fascino di Giuseppe Garibaldi, avrebbe senz’altro, dodici anni prima, detronizzato il Borbone. Che se la rivoluzione delle Calabrie non trascinò ciecamente le moltitudini per mancanza di duci. si dovette però riconoscere che il Ricciardi, « liberale entusiasta, facile a far discorsi ed a favoleggiare imprese, non poteva rendere alla libertà, com’egli credeva, il servizio che il cardinale Fabrizio Ruffo avea reso alla Santafede, perché a lui mancava la potenza dell’uomo fattivo e l’autorità che sulle turbe ignoranti aveva un porporato di Santa Chiesa (1) ».
Giuseppe Ricciardi, perciò, accolto a Cosenza e a Catanzaro con musiche e bandiere, a mò di un salvatore, nel dì del1′ osanna, con la stessa facilità venne rinnegato peggio che un demagogo nel dì del crucifige.
V.
Prorogatasi la riapertura del Parlamento al primo di luglio, s’indissero dal Ministero, con decreto del ventiquattro maggio, le nuove elezioni pel quindici di giugno. Il ministro Bozzelli, il quale era divenuto, come avea già profetizzato lo stesso Ferdinando II, docile ed efficace strumento di scellerata reazione, o, secondo altri disse, « apostata e traditore », mandò una circolare riservata agl’intendenti, raccomandando loro di usare abilmente ogni mezzo affinchè fossero prescelti uomini ligi al Borbone, di rancido stampo e fin di poca levatura intellettuale. Ecco un brano di questa circolare: « A tal riguardo io non metto norma veruna alle possibili operazioni di Lei, anzi tanto più liberamente le do questa gelosa missione, quanto maggiormente Ella ne sarà responsabile del risultamento innanzi alla sua coscienza ed innanzi al governo. Solo bramerei che si usassero, per quanto è possibile, i mezzi indiretti ossia non ufficiali, come ad esempio appellarsene alla religiosità dei vescovi e delle parrocchie, alle intenzioni conservatrici dei più retti ed influenti cittadini, a far valere col vivo della sua voce la forza dei ragionamenti ».
(1) Niccola Niseo, Ferdinando II ed il suo regno, — Napoli, A. Morano. 1884.
Questa circolare inconsulta del Bozzelli provocò una fiera protesta, come una scudisciata, da Marìano d’Ayala, intendente di Aquila, protesta che io ebbi, fra pochi privilegiati, la insperata ventura di leggere in un foglio volante tra altri documenti storici del Risorgimento, e che, come primizia, voglio in parte qui riprodurre:
« Non è nuovo tra noi questo linguaggio — esclamava l’onesto ed intrepido funzionario. — Noi ben riconosciamo di esso l’autore di una politica che fu la cagion prima dei nostri mali, perocché essa servì a ingenerare nell’ animo dei buoni il sospetto che lo Statuto non fosse una spiattellata menzogna, le nostre franchigie una falsità, la nostra rigenerazione una fantasmagoria politica. Il fatto in contraddizione del pensiero, il pensiero in contraddizione dei fatti: ecco il programma di un governo che, non potendo essere né razionale, né morale, né forte, fu sempre ipocrita e corruttore. A quali conseguenze non fummo noi tratti ? E quanti mali non avemmo da piangere “? Per troppo amore di libertà noi strozzammo con le nostre mani medesime la conquista del sangue nostro; e chi ebbe provocato il misfatto si beffò della nostra innocenza. Egli si credè per poco padrone del campo, signore della vittoria , ma non consultò bene la sua coscienza. Se ciò avesse fatto, avrebbe compreso che il trionfo della forza sopra quello dell’opinione è passaggiero, e che nel consentimento dei popoli sta la sicurezza dei governi costituzionali. Or che viene egli a susurrarci all’orecchio il Ministero?! ». Quindi, dopo un periodo quasi illegibile a causa della carta, rosa da una tignuola, e dove si accennava ai già eletti deputati, difensori e veri rappresentanti di coloro che spargevano lagrime su’ loro dritti conculcati, il d’Ayala continuava: « Sono questi, questi sono i faziosi che entrarono nella Camera, e questi stessi faranno parte delle altre mille legislature, se altrettante ne vorrà il capriccio e l’arbitrio di chi comanda. Or dunque faccia senno una volta il Ministero, e men che all’indole passionata degli uomini, guardi alla natura dei suoi atti. Sta in lui calmare gli animi, rimuovere i sospetti, allontanare dal nostro suolo altre scene di sangue, e, per far ciò, è necessario dimenticare il passato. Allontani da sé questa politica subdola e vacillante, allontani la minaccia; la forza delle opinioni è ormai troppo prepotente perché possa essere superata da quella delle armi. Così facendo, potrà un amministratore far fecondare quei germi che sono più acconci allo sviluppo delle nostre franchigie, diversamente ei non sarà mai, né io certo con altri, il carnefice delle nostre istituzioni ».
A Foggia, però, questa seconda elezione, che i liberali chiamarono illegale, perché i fatti del quindici maggio non autorizzavano a sciogliere la Camera, non potette aver luogo, sebbene il nuovo intendente Andrea Lombardi, natura oh quanto diversa dal d’Ayala, e fedele, quindi,fino allo scrupolo,alle istruzioni ricevute dal Bozzelli, avesse fatto sin dal trentuno maggio, quando insediavasi al palazzo della dogana, il totum posse perché ciò andasse scongiurato. Ma il comitato centrale avea lavorato ovunque con accanimento febbrile affinchè gli elettori fossero stati assenti dai comizii nel giorno prefìsso, dovendo la loro assenza suonare solenne censura agli attuali metodi di governo. Coloro che percorsero per lungo e per largo la provincia intera a tale scopo, sfidando il furore dell’ intendente, furono Ferdinando Cipri e Francesco Paolo Vitale, alla cui opera si aggiunse, da lontano, l’influenza di Luigi Zuppetta, il quale, con la sua parola scritta, riaccese vie più negli animi l’odio profondo contro il tiranno. Un proclama, infatti, assai tagliente fu rivolto agli elettori di tutta la Capitanata per indurre la maggioranza ad astenersi dal voto ; quale proclama, pubblicatosi la prima volta il tredici giugno a Castelnuovo, patria del Zuppetta, si vide, con la rapidità d’un baleno, riprodotto consecutivamente in tutt ‘i paesi e nelle più umili borgate. Il proclama era questo: « Cittadini, la causa dell’indipendenza e dalla libertà nazionale è caduta sotto i colpi della calunnia e delle baionette. Gli atti del governo del quindici del decorso mese improntano il marchio dell’ aristocrazia e della diffidenza, che cerca spargersi anche tra voi. Sorgete pure dal letargo ! Non vi ha Costituzione ove non havvi guarentigia; e lo Statuto del dieci febbraio niuna ne concede. Astenetevi dal procedere a nuova elezione di deputati, e mostratevi armati d’un coraggio civile, che spaventa gli stessi oppressori. Or se debbasi procedervi, non vi allontanate dalle primiere elezioni, poiché, se il governo è impegnato a distruggerle, è vostro interesse di consolidarle. Cittadini, siate uniti; ma la pruenza non sia timore, sibbene armatevi di quello che assicuri il governo, l’Italia, l’Europa, che siate pronti a versare il vostro sangue, piuttosto che veder lesi i sacri dritti, che con tanto danno vorrebbonsi conculcare ».
E, in seguito ad esso, come il razzo più forte nell’immenso crepitare di un fuoco pirotecnico,scoppiò la protesta che Saverio Barbarisi volle rivolgere, il quattordici di giugno, ai suoi elettori delle provincie di Capitanata e di Bari, e che, data la moderazione dei principii politici di lui, produsse tale un’impressione sulle moltitudini votanti da deciderle ad astenersi dal voto. Jn essa si leggeva fra l’altro: « Fece sorpresa il decreto del diciassette maggio, dopo che il giorno antecedente si era parlato di riunire le Camere. Se queste dovevano riunirsi il giorno quindici, e se i deputati il giorno quattordici si erano riuniti per le operazioni preparatorie, ed il giorno quindici erano pronti per l’apertura delle Camere, che non si aprirono per la nota vicenda (senza entrare nell’esame della mano che la produsse), come il diciassette il Ministero Cariati, sulla proposta del ministro dell’ interno, potè dire che la Camera dei deputati si era costituita, e perciò si scioglieva ? Il re ha la prerogativa di sciogliere la Camera dei deputati; ma la Camera dev’essere costituita per poter essere sciolta. E se nel quattordici e quindici maggio le Camere non erano costituite, e non si costituirono perché il re non ne fece l’apertura, come si sciolse una Camera non Camera ? Le Camere costituite sono nel fatto della legalità; e sciogliere una Camera non esistente manifesta una illegalità tale da non potere imporre neppure ai più attaccati al sistema assolutista. Si è voluto così annullare le elezioni e non sciogliere ciò che non era neppure ligato. Si sarebbe potuto soffrire un abuso così dispiacevole, così con tro il senso logico ? Ma è orroroso poi e fecondo di tristi conseguenze il decreto del ventiquattro maggio. Chi potea distruggere il programma del tre aprile ed il decreto del cinque detto mese ? Se, sulle premure nazionali per lo progresso, il Ministero Troya ci diede il programma del tre aprile firmato dal re, e poi il decreto del cinque detto mese, poteva il Ministero Cariati togliere alla nazione napoletana l’ottenuto decreto elettorale ? No, perché i governi sono per le nazioni ; e quando una nazione ha voluto un bene, e, se le è dato, toglierlo è lo stesso che dire che il governo può a piacere dare ciò che vuole, togliere ciò che non gli piace dopo averlo dato. Ciò importa, nei tempi attuali, diffidenza immensa tra il potere e il popolo; ciò importa, Ministero Cariati, che la sola forza regola noi del regno di Napoli, o il principio di un solo, che, per sostenere l’opera sua, calpesta tutte le regole sociali e il benessere del regno di Napoli ! 11 Ministero Cariati ha dato prova di tanti errori e di tanta soperchieria che si ricorderà della sua esistenza, come si terrà presente 1′ orrore che in tutti è per 1′ avvenuto del quindici maggio ecc. Come cittadino del regno di Napoli io solennemente protesto, come protesto, qual deputato eletto dalle provincie di Capitanata e di Terra di Otranto, contro lo stato di assedio, che abbiamo sofferto dal sedici maggio al quattordici giugno; contro i decreti del diciassette e ventiquattro maggio e dell’ otto giugno; contro le elezioni, che si fanno ; contro i decreti anticostituzionali, che sono nulli e improduttivi di effetti legali; e contro il Ministero, responsabile a suo tempo e luogo, e a carico del quale saranno prodotte le accuse che si convengono ecc. Non sono fuggito da Napoli, perché mi sono creduto e mi credo ancora deputato, e i deputati sono inviolabili ».
Convocati a Foggia i comizii nella sala del così detto padiglione di s. Domenico, cioè nell’antico refettorio monastico, ivi si condusse, il quindici di giugno, il sindaco marchese Luigi de Luca, qual presidente provvisorio, ed i decurioni, segretarii anch’essi provvisorii, signori Vincenzo Celentano. Francesco Paolo Modula. Domenico de Angelis, rimanendo assente il solo Giovanni Battista Postiglione, e s insediarono di buon’ora per procedere alla votazione. Di settecento elettori non si presentarono che appena centoventi, i quali si rifiutarono di votare, ma altamente protestarono contro l’illegale procedimento, non essendo il caso di nominare altra Giunta definitiva, né di eleggere nuovi deputati, perché quelli che vi erano non potevano considerarsi destituiti del mandato, mercé un atto di vigliacca sopraffazione. Fatta tale protesta, tutti si ritirarono; sicché il seggio, naturalmente, dopo un verbale negativo, si sciolse. E le notizie, che man mano giungevano dagli altri Comuni, rinsaldavano altresì le previsioni, cioè che la maggioranza dell’intera nostra provincia, come delle altre, non volesse sapere di nuove elezioni, e che queste fossero avvenute in pochi, pochissimi circondarii. Sicché quando il primo di luglio si riapriva in Napoli il Parlamento in una sala del r. Museo di antichità e di belle arti, non si videro dei deputati per la Capitanata che i soli Ferdinando de Luca, Giuseppe Libetta e Sa-verio Barbarisi, anche rappresentante di Bari, assistere, con la conscienza del proprio diritto, al famoso discorso della Corona, impappolato d’i pocrisia dal Bozzelli e letto dal duca di Serracapriola, all’uopo delegato ; discorso in cui, con impudenza unica anzi che rara, chiamavasi Iddio a giudice della purità delle intenzioni del re, e, a testimoni, il popolo e la storia.
Furono indette, quindi, per la Capitanata le elezioni suppletorie-completive ; e mentre, dati gli sforzi disperati dell’intendente e del sotto intendente, riuscirono eletti, pel distretto di Bovino, Domenico Varo di Troia e Antonio Paolella di Castelluccio Valmaggiore, due ricchi e pacifici proprietarii locali, dei quali il primo si ebbe dappoi, sotto il governo italiano, 1′ onore del laticlavio, a Foggia, con un combattimento titanico contro le malefiche arti poliziesche e reazionarie, si volle dare, come sfida al governo, un nuovo attestato di stima e di affetto a Luigi Zuppetta. Il suo completo trionfo fece mordere pur troppo le mani ai soccuinbenti, che trovarono oh quanto magro conforto in palinodie senza sugo, osandosi di scrivere fra l’altro, su fogliacci da pizzicagnolo, queste testuali parole : « Sempre più vedesi apertamente come 1′ opera degli onesti liberali si frange nelle opere subdole dei maligni, tanto che si abbia una sproporzione numerica tra quelli e questi, per la ragione che 1′ uomo dabbene vuoi A’ivere tranquillo e non compromettersi in faccia agli ardimentosi proletarii, che niente arrischiano ».
Anche questa volta la Camera andò in dileguo : per lo che, in seguito, sparì del pari ogni promessa, ogni illusione ed ogni speranza di liberi instituti, addirittura seppellendosi nel nulla
la Costituzione. E la pippionata bozzelliana, fattasi recitare dal re nel primo di luglio per bocca del Donnorso, potrebbe costituire da sé il testamento politico di colui che si compiacque farla da becchino, e che i suoi contemporanei ben bollarono a sangue, chiamandolo un dottrinario senza principii e senza fede.
A Foggia l’intendente, rianimatosi in vista della più sfacciata reazione, trionfante nella capitale, nonché di molta truppa che tornava dalla Lombardia, tra cui cinquecento lancieri e cinquecento dragoni, che popolarono diversi quartieri della città, tentò di metter mano anch’ egli alle tanaglie, cominciando ad iniziare dappertutto una lenta e progressiva repressione. E premette il pugno dapprima su coloro che soltanto per timore erano stati attratti nell’ orbita rivoluzionaria e li riattaccò fedeli alla Casa Borbone ; poscia cercò fare il viso arcigno contro quelli che, non per convinzione, ma per facile adattamento al nuovo ordine di cose lo avevano accettato, e li mise in una condizione che chiameremo di glaciale indifferentismo. Solo restò vigile a tener d’ occhio i liberali convinti, che non disertarono dal loro posto di combattimento, e aspettava l’ occasione propizia per dar loro addosso e sconvolgerli per sempre.
Ma se le intimidazioni locali, da una parte, e le notizie di repressione, dall’ altra, fino in quelle terre dove la rivoluzione pareva avesse dovuto assurgere alle più grandi proporzioni, come nelle Calabrie, incominciarono a disgregare le organizzazioni esistenti in Capitanata e a rendere deserti i sottocomitati di tutta la provincia, pure il comitato centrale foggiano, con tenacia lodevolissima, si riunì di nuovo e deliberò doversi dar luogo, con l’intervento dei deputati, ad una dieta in Foggia, di cui nominava a presidente Tommaso Tonti. Eppure, oltre ai componenti il comitato, si contavano tuttora nella nostra città uomini, che certo non rinunziavano per paura alle loro idee ed ai loro convincimenti, uomini che, disdegnando ogni bavaglio, usavano, come prima, della libertà di parola, e non si ritraevano dal rischiare persino delle serie compromissioni. Non ebbero quindi un momento di trepidazione e Francesco Paolo Tarantino e Ferdinando Cipri e Luigi de Noia, quando, centuplicandosi, andarono in giro per riunire soccorsi in prò dei Cosentini, di cui un’ultima e pallida schiera si dibatteva ancora in una specie di agonia, contrastando al tiranno il diritto di riconquistarli come sua preda. Rischiando essi le manette, riuscirono a riunire grosse somme per porrre in grado coloro, che consideravano come fratelli, di resistere tuttavia alle armi regie e di possibilmente vincerle. Né a loro si mostrò secondo per coraggio, chiamato, invece, dalle anime tapine, audacia e temerità, quel p. Borsari delle scuole pie, il quale, il giorno venti di agosto, dal pergamo della chiesa cattedrale, anziché inneggiare alle glorie di Maria, in onore di cui volle la guardia nazionale celebrare una festa, scivolò con arte a parlare della Costituzione, della libertà, della indipendenza italiana , facendo un quadro vivissimo e doloroso delle attuali condizioni del regno. Il popolo, che ne rimase sorpreso e insieme allettato,cominciò a mettersi in fermento; ma il Fuccilo, che di nuovo fungeva da intendente, perché il Lombardi era stato messo a riposo, e, con lui, il comandante della provincia, colonnello d’ Afflitto, entrambi presenti in chiesa, profittando di un intervallo, in cui quegli sostava per riposarsi, ordinarono che continuasse la messa; al che il celebrante can.co Capuano, come un navilio distrigato da una secca, riprese l’interrotto cammino a gonfie vele, intuonando a voce alta il Credo, cui tenne dietro 1′ orchestra con le sue note clamorose. Così il Borsari fu necessariamente costretto a lasciare il pergamo, e la sera… a lasciar Foggia.
Né tacquero i liberali foggiani, quando, con sfacciatezza temeraria e folle, sfidandosi la pubblica opinione, si fece tornare a Foggia quel Tibì, che n’era stato pocanzi scacciato per volere di popolo. Venne perciò affìsso un proclama, col quale lo si minacciò di contrastargli ad ogni costo il passo sulle scale dell’ intendenza quante volte ei si fosse colà presentato per risalirle. E allorché, il diciotto di luglio, con 1″ arrivo di altri cinquecento uomini del 1° reggimento de” dragoni, Foggia sembrava una vera piazza d’armi, e il Tibi ripigliò il suo posto in barba ai protestanti, ridotti al silenzio, un traino, carico di fuochi pirotecnici, destinato a Troia per l’occasione della festa di quei santi protettori, passando pel largo Portareale, venne incendiato, e, all’esplosione improvvisa, che si avvertì fin nei lontani sobborghi, uno spavento indicibile invase la cittadinanza, la quale, non sapendo che cosa fosse avvenuto, andò tremante a rifugiarsi tra le pareti domestiche. La guardia nazionale e la truppa furono sossopra, mentre la polizia procedette a parecchi arresti, sospettando “che l’incendio fosse stato doloso e prodotto con mozziconi di sigari accesi, gittati sul traino per provocare un allarme.
E quando il governo, per disarmare i cittadini, cominciò a a disciogliere man mano le milizie nazionali del regno, a Foggia non si restò impassibili innanzi a un fatto sì grave, che, mentre toglieva al popolo ogni suprema garentia dei suoi diritti, oltraggiava la guardia nazionale locale, la quale avea resi, fino allora, segnalati servigi all’ ordine pubblico. Nella generale esasperazione, come consueta valvola di sfogo, fu affìsso a Portareale, sull’angolo del palazzo Filiasi, questo novello proclama, che per la sua forma assai pedestre,non seppe indovinarsi da chi dettato: « A voi cittadini del medio e basso ceto, che sino al dì di oggi siete stati calpestati dai probi del paese, un’altra trama questi hanno ad operare a danno vostro, ed è il disarmo della guardia nazionale. Ma voi tutti, buoni cittadini, ora tutto dovete soffrire, ma non il disarmamento, perché la vostra guardia nazionale non ha accusa alcuna ; e, se ciò verrà ordinato per le tante denuncie dei vostri galantuomini, allora mi vedrete il primo, armato come s. Giorgio, farne vendetta qui in mezzo; e credo che rinverrò subito dei veri amici, promettendovi che non combatterò contro la forza qui residente, ma contro i tiranni ed oppressori cittadini, che distrugger vogliono la libertà individuale e ritornare al dispotismo, nonché opprimere tutti noi. Risolvetevi perciò ; siate uniti e forti. Io sono l’amico di tutt’ i veri amici ». E fu allora che Ferdinando Cipri, vedendo nell’ abolizione della milizia nazionale e del ripristino di quella urbana un volere ridurre all’ impotenza i cittadini, s’arrischiò, con raro coraggio, di togliere le armi alla truppa per darle al popolo; il che gli fruttò perquisizioni domiciliari, vessazioni implacabili, ostinate, e, più tardi, fin la carcere.
Ma erano codesti gli ultimi sprazzi e gli estremi bagliori di una fiamma condannata a spegnersi, che l’intendente, con un’ ipocrisia autorizzata dal governo, preparava anche in Foggia, senza violenze palesi, 1′ ora della più completa reazione. E il dì, in cui, con l’avvento di Gaetano Peccheneda, di Orazio Mazza e di Raffaele Longobardi, s’iniziò in Napoli l’era dello spionaggio più esoso e delle persecuzioni più infeste e tiranniche, che scossero dalle fondamenta il reame delle due Sicilie, potendosi così storicamente affermare che il 7 settembre 1848, data di quell’avvento, abbia generato il 7 settembre 1860, l’intendente di Capitanata potè avere il vanto anch’egli di mostrarsi degno di quella triade ignominiosa che veniva ad inaugurare il governo del terrore, essendo riuscito in Foggia a sgominare le schiere dei liberali e a ricondurre la provincia intera in uno stato dì obbedienza passiva alla volontà del Borbone. In una relazione, infatti, mandata al Ministero intorno alle condizioni della provincia, egli asserì con soddisfazione che la Costituzione, concessa per un momento dal re, era stata ivi nei primi istanti accolta con compiacimento, ma avea però suscitate pretensioni immense ed abusi senza limiti, mercé mene occulte di stranieri, in gente dissennata e senza cuore, che, sotto mendaci parvenze di liberalismo e di patriottismo, avea tentato di minare le istituzioni monarchiche, sperando di trarre partito per sé dal disordine pubblico. Che codesti male intenzionati erano di già tutti ben conosciuti da lui, non rimasto certo tra’ dormienti, e che non cessava d’invigilare per poterli, all’occasione, assicurare alla giustizia punitrice, come avea fatto per taluni, la cui compromissione potea dirsi già un fatto reale e completo.
Così bassamente, dunque, il ff. intendente Fuccilo accreditava la sua livrea presso i nuovi padroni.
VI.
Siamo in pieno periodo di reazione. Foggia, come tutte le altre città del reame, è condannata a soffrire pur essa in malo modo le influenze del nuovo metodo di governo. In un primo momento, in cui la reazione, organizzata nelle tenebre del comitato di palazzo reale e delle sagrestie, prendeva ad appalesarsi in tutto il suo vigore, Foggia ne raccoglie trepidante le notizie e ne resta commossa ed atterrita. Essa sembra confusa nella schiera di quegli spettatori che assistono passivamente allo spettacolo teatrale, or palpitando per la sventura degli onesti, or fremendo per la iniquità trionfante sulla giustizia. Lo spettacolo dolorosissimo di Napoli, — dove con 1′ opera malefica degli antichi gufi e provetti sanfedisti, che dopo
il quindici di maggio aveano rialzata la cresta e ridomandata la riammissione nei prischi uffìcii, specialmente della polizia, serravansi nelle manette i polsi dei migliori, caduti in demanio delle spie e dei calunniatori, nonché del primo mascalzone che volesse, con cervellotica denunzia, disfogare le sue ire ed i suoi rancori personali, — questo spettacolo, dicevo, non potea non far tremar le vene fìnanco agl’ impeccabili, i quali a ragione prevedevano dilagasse tale sistema nelle provincie, ove tutti, senza eccezione, sentivansi ingarentiti e indifesi. Che se a Napoli un Palmieri, in mezzo ad una feccia di sbirraglia, munita di grossi bastoni e di stocco, scorazzava da mane a sera per via Toledo, tronfio e pettoruto, provocando e minacciando quanti incontrava, per la semplice voluttà di riempire le prigioni di lamenti e di lagrime, nonché dì creare processi ad terrorem (e non vi era in Napoli nelle alte sfere uno solo che potesse o che volesse salvare chicchessia da simigliante manigoldo), come non doveasi temere a Foggia che un Fujano qualsiasi o un qualche altro tipo da galera, come colui, non sorgesse a isfogare antichi o nuovi livori anche in persona di pacifici cittadini ? E chi non temette per sé quando seppe della sorte miseranda toccata, appunto in Napoli, al concittadino Saverio Altamura, sol perché fu trovato scritto a pie di una delle sue tele « Dio lo vuole «, che fu il motto degli antichi crociati ed era anche quello dell’ Italia nuova ? La polizia avea creduto ravvisare in questa frase una sfida al Borbone, e lo fece perciò dannare all’ esilio. E quale strazio, in conseguenza, fu per tutti 1′ apprendere il dolore e la disperazione della madre sua nelle ore supreme del distacco. Non era rimasta a costei cha una reliquia sola del suo adorato figliuolo, una madonna, che il pittore avea dipinta per lei ; eppure questa effigie, che avea serbata tuttodì gelosamente come 1′ amuleto più caro che possedesse, ella volle, in quei momenti di profondo cordoglio, offrire alla madre del Peccheneda, dicendole : « Gradite questo tenue dono, e fate che vostro figlio, che tutto può, mi distacchi il più tardi possibile dal figlio mio!.. » Dono riuscito vano del tutto, che Saverio Altamura dovè subito partire per la Toscana ; donde, posteriormente, la notizia della condanna di lui in contumacia alla pena capitale, con Francesco de Blasiis, per i moti di Abruzzo, trasse in breve alla fossa la povera martire.
E se gli stessi magistrati erano divenuti ciechi esecutori di vendette politiche, perché mancipii di quel Niccola Gigli, loro ministro, sì ligio al Longobardi e al Peccheneda, la giustizia era pur essa divenuta esecrato strumento di esecrata polizia: e l’esempio di un Angelillo e di un Navarra, che avevano adottato nella capitale, come divisa, il motto « Sia dovere del magistrato pulire il paese di tutte le male erbe », e si erano perciò resi familiari con la forca e col capestro, non poteva non trovare facilmente nelle provincie seguaci ed imitatori.
Il contagio, infatti, non tardò a propagarsi, che tra le mura di Foggia cominciò del pari a spuntare l’alba orrorosa dello spionaggio, della calunnia e delle vendette, alba che fu foriera di giorni ben tristi per la cara città. Essa fu crocifissa sul suo calvario da un miserabile plebeiume d’ogni ceto, inclamidato in cenci di passioni ora livide, ora risibilmente goffe, con gli stessi tormenti e con le stesse torture che la bella Partenope già stava sopportando: in una stretta di mano si nascondeva un agguato, nel saluto una compromissione, nell’ atto più innocente un pericolo: la libertà di ognuno, insomma, era in balia d’imputriditi furfanti. Costoro, già padroni del campo, scelsero a bersaglio, in preferenza, i più probi e rispettabili cittadini. Gli arresti, dì e notte, si avvicendavano quindi senza posa con gli esilii e le destituzioni, dandosi così ad ogni legittima manifestazione di sentimento di libertà l’impronta della colpa più esecrahile e più esecrata. Ed era colpa l’aver gioito all’annunzio della Costituzione; era colpa l’aver fatto parte della guardia nazionale; era colpa il possedere un dito d’ingegno o l’avere una coltura letteraria e santifica; era colpa il tenere tra mano libri che sul frontespizio portassero stampata la parola politica ovvero i nomi di certi benedetti autori, come Botta, Machiavelli, Colletta, Giannone, Leopardi. Massari* Giusti, Berchet, Mazzini e di molti altri, messi all’indice dai pretoriani del Borbone, perché aprivano le nienti a nuovi orizzonti di civil vivere. Oh quanti volumi del gran pensatore torinese, Vincenzo Gioberti, —uno dei più efficaci cooperatori della nostra indipendenza, e che sognò possibile ima confederazione italiana, appellato, perciò, dal famigerato Angelillo, nella requisitoria pei fatti del 15 maggio ’48, « uomo ammirevole per ingegno, ma pernicioso pur troppo all’Italia a cagione degli esagerati principii di politiche utopie» (1) — , quanti volumi dicevo, per timore di perquisizioni e di arresti, ormai divenuti frequentissimi, furono in quei dì a Foggia, nel segreto del domestico focolare, miseramente dannati al rogo!… Ecco le accuse, ecco i reati, ecco i processi…, ecco i giudizii degli assoldati di un governo divenuto quasi settario, sospettoso e metodico nei mezzi di repressione, di un governo barcollante sulla seggiola delle sue contraddizioni.
Seguiamo, intanto, il filo cronologico degli avvenimenti.
Fin dal 18 di agosto ’48, a diciannove ore, erano stati arrestati Francesco Paolo Vitale e Agnello lacuzio sotto pretesto di avere avuta corrispondenza col Cozzoli ed altri liberali del comitato rivoluzionario di Moffetta. La casa del primo fu visitata dal giudice regio, dal capitano della gendarmeria e dal commissario di polizia, seguiti da uno sciame di gendarmi, che ne perquisirono ogni angolo in cerca di carte e di corrispondenze compromettenti; mentre quella del secondo si rinvenne vuota per essere andato il Iacuzio sin dal mattino in campagna, dove la gendarmeria si recò a sorprenderlo, costringendo il giovine Grazio Sorge, suo familiare, a colà guidarla. E del pari si andò allora sulle peste di Cannine Durante, destinato anch’esso alla prigione, ma non lo si trovò in casa; e invano si cercò d’indagare, di spiare, di fiutare in ogni sito per averlo tra mano. La sera stessa, intanto, si fecero partire i due arrestati per Barletta, dove vuoisi sieno stati reclamati dal generale Marcantonio Colonna, comandante le truppe della provincia di Bari. Ma dal castello di Barletta, ov’ erano rimasti a disposizione di quest’ultimo, Francesco Paolo Vitale e Agnello Iacuzio vennero poscia trasportati e rinchiusi nel carcere di s. Francesco a Lucera, per essere giudicati da quella Corte criminale. Passarono entrambi per Foggia il dì venticinque settembre, ammanettati peggio che due manigoldi, in una carrozza ermeticamente chiusa, circondata da circa trenta dragoni a cavallo con le pistole in pugno, e senza permettersi che anima viva potesse avvicinarli per scambiarvisi un abbraccio, un saluto, un addio. Comparvero costoro a giudizio nel venti novembre di quell’anno malaugurato, per rispondere di cospirazione,diretta a cambiare la forma del governo, di associazione illecita con vincolo di segreto, di appropriazione indebita di pubblico danaro e di furto qualificato. L’accusa, come vedesi, era gravissima, ma talmente destituita di ogni base giuridica, che dovette quasi torcersi la parola della legge in mandarli a dibattimento; e ciò per far cosa grata ai mille inquisitori, i quali avevano assunta, col sic volo, sic iubeo, una figura assolutamente tirannica, losca ed esosa. Le pressioni che, d’altra parte si esercitarono sui giudicanti per vedere entrambi immolati alle furie ultrici non ebbero limite alcuno. Ma se la magistratura, nella sua maggioranza, potea dirsi schiava venduta al volere dei ministri, pure, ad onore e vanto dell’umanità, come oasi nel deserto, brillavano ancora per indipendenza, per coscienza, per rettitudine di giudizio poche, pochissime anime elette, le quali sfuggivano ad ogni specie di subornazione, e innanzi a cui bisognava per forza inchinarsi.
Una di queste anime elette fu Giovanili Rossi, il cui nome è sacrosanto dovere di additare al rispetto delle postume generazioni. Egli, profondo giurista e scrittore, nonché insigne avvocato del foro nobilissimo di Trani, fu per la sua dottrina assunto, 1′ anno innanzi, a giudice di Corte criminale e destinato a Lucera, ove si assise, tra i primi del collegio, con l’aureola di magistrato modello. Sicché lo si nominava sempre relatore nelle cause più gravi e difficoltose; ed era quindi naturale che un processo delicato, come quello imbastìto contro Iacuzio e Vitale, si affidasse a lui. E questa volta fu pari a sé stesso; tanto che l’aspettazione di coloro che avrebbero voluto veder consumato l’incruento sacrifizio dei due liberali foggiani sull’ara di Temi venne meno. Giovanni Rossi, nella integrità della sua coscienza, non vide chiara l’accusa, ma, convinto invece che si fosse voluto dar corpo alle ombre e che i pretesi reati non avessero altro fondamento se non 1′ odio e la vendetta partigiana, prese il coraggio a due mani, e, sfidando la impopolarità nonché l’ira degl’ interessati, dimostrò pure una volta che la verità e la giustizia debbano rimanersi al disopra delle rivoluzioni, come il cielo stellato sulle tempeste; e conchiuse la sua lunga, circostanziata e dotta relazione col chiedere di entrambi l’ assoluzione. Apriti terra !… Il procuratore generale sbarrò gli occhi dallo stupore, e, quasi gridando allo scandalo, saturo di bile fors’ anche più contro il relatore che contro gli accusati, pronunziò una velenosa requisitoria, mentre la difesa rilevò, dal canto suo, l’alto sentimento di giustizia, cui la relazione era informata. E la Corte, a maggioranza di tre voti su cinque votanti, adottando perfettamente le conclusioni del relatore, assolse Iacuzio e Vitale da qualsiasi imputazione e li rimise in libertà.
Ma non passò tempo e la mano del tiranno pesò inesorabilmente sul capo dell’onesto magistrato, che, con decreto del 26 luglio 1849, Giovanni Rossi venne destituito. I reazionarii esultarono di gran lunga, ne esultarono i meandri più luridi del pantano poliziesco, ma non ne esultò Astrea, che velavasi in segno di lutto per vedersi cosi privata di uno dei suoi più degni e venerabili sacerdoti. « Tanto durerà la repubblica, — fu detto un dì al Doge di Venezia — quanto durerà il costume di far giustizia»; e se Casa Borbone osava calpestarla, facendo del tempio a lei sacro una bisca, vuol dire che dibattevasi di già negli ultimi aneliti di vita !…
Fuccilo morse anche lui il freno per l’assoluzione dei due, e dovette in cuor suo godere, per conseguenza, della sorte toccata al Rossi: ma, se non trovò proseliti contro di loro, ben sperava di averne in prosieguo contro altri, e continuò nella sua via vessando, opprimendo, strozzando, per ogni minima cosa, il libero esplicarsi di ogni cittadino, destinato a divenire in sua mano una vera mummia da museo e a portare le catene come monili da eunuchi. In prova di ciò, basta ricordare che taluni giovani di bello spirito, a fare niente altro che uno scherzo, sia pure di cattivo genere, affissero, il 15 gennaio ’49, degli avvisi a stampa, mercé i quali si invitavano, indi innanzi, i fumatori a usar la pipa e non già i sigari, per non procacciare ulteriori lucri al governo, che avea volontariamente rinunnziato a quello della polvere da sparo, non permettendone, per paura, più vendita ai privati. Venuti essi in parecchi, la susseguente sera del diciassette, a fumare con le pipe sulla piazza Portareale, l’intendente Fuccilo non volle che neanche ciò durasse per ventiquattr’ ore sole, perché vi scorse tra le linee chissà quale pericolo immaginario; sicché il dì appresso, quasi senza aspettare lo spuntar del sole, fece bandire, a rulli di tamburo . che niuno dovesse più asportare la pipa fuori di casa, sotto pena di arresto, considerando ciò — vedi genialità di escogitazione — una beffa al buon ordine della cosa pubblica, E siffatti metodi di repressione, che rasentavano or la ferocia, ora il ridicolo, furono sì bene accetti al Ministero, che questo volle premiarlo ; e, con decreto del marzo ’49, alle semplici funzioni d’intendente, che il Fuccilo aveva, fece seguire e grado ed emolumento.
Le sagrestie, d’altra parte, aveano ripreso tutto intero l’antico potere, e fu allora che il vescovo Monforte, il quale fin dal 19 giugno 1848, dopo la catastrofe del quindici maggio, avea fatto sapere di volersi restituire in residenza, ma che, con apposito messaggio, le monache chiariste ne lo avevano dissuaso a causa di pochi scapestrati — a loro dire — , i quali minacciavano di fargli offesa, tornò in Foggia dopo più di un anno di assenza, e, con lui, quel Maldacea, che n’ era stato scacciato a furore di popolo, e che riprendeva, trionfante, il posto di vicario e di rettore del seminario. Il giorno 5 novembre ’49 il Monforte, infatti, dopo essersi soffermato per poco a Lucera, fece la sua solenne entrata in Foggia nella carrozza del ricevitore generale Carmine De Martino, il quale, con altre venti carrozze, era andato ivi a rilevarlo, in compagnia di molti gentiluomini della città, dei rappresentanti il Capitolo e di quel furbesco vicario, che avea di qualche giorno anticipato il suo arrivo come quasi staffetta del vescovo.
E, mentre il cinque di novembre si ricostituiva la potestà ecclesiastica nella sua intierezza, la notte del sette dello stesso mese, come contraccolpo, vennero arrestati nelle loro case Scipione Cafarelli, Grazio Sorge, Nicola Sanna, Giuseppe lannantuoni. Paolo Annecchino, Nicola De Leo, Saverio Mucelli, e, per la seconda volta, Agnello Iacuzio, i quali, però, dopo di essere stati ristretti in carcere per parecchi giorni sotto diversi insulsi pretesti, furono messi alla spicciolata in libertà. Che abbia sospettato il Fuccilo di voler costoro fare insulto al Monforte, reduce alla sua diocesi dopo si lunga assenza? Indovinala grillo !…
E in quel torno di tempo fu arrestato del pari Vincenzo Luigi Baculo, il noto avvocato foggiano, che avea combattuto in Napoli il quindici maggio sulla barricata accanto al palazzo Gravina, e che, per sottrarsi ai segugi del satellizio borbonico, avea preso asilo dapprima colà nel convento di S. Pasquale a S.a Lucia al Monte e poi era venuto a rifugiarsi in Foggia, dove la polizia, mercé abili spie, seppe scovarlo presso suo padre, il dottor Bartolomeo.
Ed eccoci finalmente giunti al don della reazione con la nomina di Raffaele Guerra a intendente di Foggia, quel Raffaele Guerra, che da segretario generale in Lecce, fu destinato a serrare in un pugno di ferro la nostra provincia. Dal primo giorno ch’egli prese possesso della carica, e che fu il 17 novembre ’49, ei non pensò che a guardarsi le spalle. Senza nemmeno entrare nel suo gabinetto, senza toccare neppure la soglia degli ufficii, in compagnia del conte Gaetani, tenente degli usseri, e del colonnello De Tommaso, coi quali era venuto da Napoli la sera innanzi, preferì sin dalle ore mattutine mettersi in giro d’ispezione per le caserme e per le scuderie. E visitò quindi il quartiere di s. Antonio, destinato ad accogliere un intero reggimento di dragoni, che sarebbe venuto a Foggia di guarnigione, e visitò del pari, allo stesso scopo, parecchie scuderie private della città. Egli voleva, a dir vero, iniziare la sua dittatura con un ingente apparato di forze, segno di potere e d’imperio. Ma se, da una parte, il Guerra ebbe cura dal primo giorno di ottenere una buona messa in iscena e di affermare in tal modo la sua potestà suprema, cominciò, dall’alt a, ad iniziare nel suo governo lo stesso sistema loiolesco adottato dai predecessori, ma più forte, più intenso, più saturo di malizia e di cattiveria, celando sotto mentita larva di esagerata bonarietà una coscienza cristofle, un animo a dirittura felino. E, colpendo sempre alle spalle, riesci a incutere di sé nei suoi amministrati terrore da non si dire, e che ben poteva assimigliarsi a quello che ivan spargendo per le terre di Bari, di Lecce, di Chieti, di Avallino, di Cosenza e di Teramo un Aiossa, un Sozi Garafa, un Mandarini, un Mirabelli, un Mazza ed un Roberti. Ei fu visto dedicato, perciò, con un’ accentuazione speciale e con studiata pompa, a pratiche religiose e ad esercizii spirituali, di cui, ad ogni pie sospinto, si compiaceva dare degli straordinarii pubblici saggi, desiderando nascondere così all’occhio indagatore la sua vera essenza. Eccolo, dunque, a fianco di vescovi e di prelati, eccolo indivisibile col vecchio Monforte, cui, come un agnellino, mostrava di rivolgersi a consiglio in ogni occasione, tenendoci a far credere ch’ei non muovesse alcun passo senza inspirarsi al volere dei divini ministri; eccolo quasi installato nella chiesa matrice, ch’era divenuta, senza l’ombra d’iperbole, la succursale del palazzo dell’intendenza, e dove ogni festa civile solennizzavasi col tormentare le povere canne di un organo e con lo sciupare incensi dai turiboli. La religione era diventata quasi sfacciata mezzana tra l’autorità e le masse, sempre col riposto scopo di menare codeste pel naso, come i buoi, a duro e cieco servilismo. Ma la religione che è, per sé stessa, sapienza palingenesiaca e sentimento, benefìzio di amore e massima efficienza di civiltà, essa che fu sempre reputata superiore in virtù allo affetto di patria, di famiglia e di libertà, e che mira, per conseguenza, a fini assai più alti ed imperscrutabili, oh come doveva arrossire di simiglianti sacerdoti !… Raffaele Guerra fu però vero interpetre del concetto di governo del suo re, che volle il clero ministro e sostegno del regno, non essendosi peritato fin dal famoso concilio dei vescovi, tenutosi a Gaserta, di ricacciare novellamente, con forme solenni, la società napoletana nel medio evo, e di rinunziare, al dire di un patriota, alle conquiste dell’ elemento civile sul clericato, — conquiste che formavano non solo gloria di colui che sul trono di Ruggero insediò la dinastia borbonica, ma altresì il titolo nazionale della sovranità ottenuta per le arti di Elisabetta Farnese e confermata dalla vittorie sul Lobkowitz, condottiero degli alemanni in quella stessa Velletri, ove, novantatre anni dopo lui, Ferdinando II disonorava con la fuga l’esercito napoletano.
E la festa pel giorno natalizio del re, ch’era la prima a solennizzarsi in Foggia sotto gli auspici del Guerra, il 12 gennaio ’49 assunse, perciò, proporzioni ecclesiasticamente più grandiose, stabilendone quegli medesimo il relativo programma col vescovo Monforte e col generale Carlo Colonna, comandante il reggimento dei dragoni, — festa che si ripetette integralmente il sedici di gennaio pel genetliaco del duca di Calabria, principe ereditario. E, mentre il Guerra tra i canti liturgici astraeva, da un lato, le moltitudini dalle gare terrestri, trasportandole, in aere più puro, alle contemplazioni ascetiche, la polizia, dall’altra, lavorava giorno e notte senza posa per addentare ogni antico fautore di libertà e perderlo nell’ abisso delle vendette. E quelle identiche moltitudini, che aveano gridato « viva la Costituzione », trovavansi sotto l’azione del veronal, che loro si somministrava con ogni arte, e rimanevano, per conseguenza,indifferenti ed impassibili all’ orrendo e vergognoso spettacolo che davano di sé stesse. Che anzi codeste, dirò meglio, ad imitazione di Selika nell’ Africana di Meyerbeer, la quale, a infrangere la sua ‘esistenza, come avea visto infrangere il suo amore, veniva all’ ombra dell’albero fatale per respirare il mortifero profumo dei suoi fiori, erano state trascinate dall’ astuto funzionario a completamente chiudere gli occhi sotto il mansanillo. Sicché quando il 31 di gennaio 1850 un furgone, tutto chiuso e circondato da uno sciame di dragoni con le armi in resta, transitò, quasi funebre corteo, per le vie di Foggia, trasportando da Cerignola a Lucera un gruppo di patrioti per essere giudicati da quella Corte criminale, non vi fu persona che abbia emesso un grido o sollevato un dito in segno di protesta. Oh com’ era nefasto quell uomo per Foggia !..
Ei non dimenticò nel febbraio dello stesso anno che il marchese Preda, Pietro de Luca e Domenicantonio Siniscalco, tre gentiluomini foggiani, erano stati, i due primi, capitani, e l’ultimo, tenente della guardia nazionale. Questo, che per lui era enorme peccato, li rendeva indegni di appartenere al Consiglio di beneficenza, di cui facevano parte da circa un triennio; sicché credette di compiere un atto di suprema giustizia, provocandone la esonerazione dall’ onorifico ufficio, in cui li fece surrogare da Antonio Sorrentini da Giuseppe Serrilli e dal lucerino Giambattista Nocelli.
Aveva, in oltre, completato da sé un rigoroso scrutinio di tutti i suoi amministrati, nonché del personale da lui dipendente ; e, avendo quindi assodato che molti di questi ultimi non erano rimasti indifferenti all’ annunzio del regime rappresentativo, decretò punirli ad ogni costo di questo loro legittimo entusiasmo. E primo tra essi vi capitò Scipione Cafarelli, sotto capo del 4.° ufficio, colui, che, fregiato del tricolore, aveva, con vero sentimento patriottico, oh quante volte eccitata la folla a plaudire alla Costituzione, quel Cafarelli che seppe, fra l’ altro, tener fronte il 1848 al suo intendente, quando chiedeva, con raro coraggio, che tutt’i falsi documenti esistenti nell’archivio della polizia, foggiati a danno dei suoi concittadini per opera di venali e vigliacche spie, fossero dannati al rogo, ma che, trattenuto a forza dai gendarmi, si contentava dappoi d’inventariarli e contrassegnarli. Il 20 febbraio 1850 Scipione Cafarelli, senza nessun preavviso, colpito fulmineamente alle spalle come Sigfrido, venne, con draconiana ministeriale, destituito.
Né potea piacere del pari allo stesso intendente che Agnello lacuzio e Francesco Paolo Vitale fossero sfuggiti al rigore della legge. Questi erano stati assoluti, è vero, dalla Corte criminale per opera di un relatore abbastanza zelante e scrupoloso, ma ciò non induceva che dovessero essere dimenticati dalla, polizia « lasciati per conseguenza tranquilli, senza più alcuna molestia. -Erano le teste più riscaldate della città, a suo dire; sicché anche per impressionare le masse li si doveva prendere pel colletto novellamente, e, con essi, molti altri che loro aveano tenuto bordone, e che fino a quel momento non erano stati ancora toc ahi da chicchessia. Nella notte, dunque, del 28 febbraio 185.0 furono inretati parecchi liberali mentre pacificamente dormivano nelle loro case, non sospettando punto che si tramasse nell’ombra contro di loro. E, con un impressionante apparato di forze, furono trascinati al carcere Agnello Iacuzio; Carmine Durante, Giovanni Battista Postiglione, Saverio Tarantino, Grazio Sorge, il dentista Battista De Toma ed il sarto Raffaele Perugino. Si andò a casa di Francesco Paolo Vitale e non si rinvenne; ma, saputosi ch’egli erasi recato da più giorni ad Ascoli in quel palazzo ducale per curare gl’interessi del duca Rinoccini, gli si corse dietro colà dai gendarmi e lo si menò del pari nelle prigioni di Foggia. Ferdinando Cipri l’indomani, reduce dalla campagna, apprese che anche la sua casa era stata visitata la notte dal commissario di polizia , e, senza scomporsi, sicuro di sé, abbracciò i suoi cari, dando loro coraggio, e andò a costituirsi al commissario, che non si era dimenticato dì riserbare per lui un altro paio di salde manette. Di che, insomma, si accusava ?… L’ arresto era proceduto senza un regolare mandato da parte dell’autorità competente, in assenza di qual-siasi flagranza, e non se ne seppe perciò la rubrica. Ma questi non furono soli, che il dì appresso i fratelli Luigi e Francesco Apicella ne divisero le sorti. Però contro di costoro si era elevato almeno il sospetto che fossero stati autori di uno sfregio ai dragoni della guarnigione per avere divelti di notte tempo gli anelli di ferro infissi nel muro della loro casa in via del teatro, adibita ad albergo, e che servir dovevano invece ad attaccarvi i cavalli della vicina scuderia di uno degli squadroni, pel loro governo. Ligati, quindi, come due volgari malfattori furono condotti alle prigioni, mentre il generale Colonna ordinava, per suo conto e per sua personale soddisfazione, che s’infiggessero loro, sulla stessa piazza del teatro, cento legnate a dorso nudo. Il brutale ordine commosse oltremodo parecchi gentiluomini, i quali, spontaneamente e per ragione di pura umanità, si presentarono e al Guerra e al Colonna, pregandoli a risparmiare la città da tale spettacolo selvaggio, anche perché nessuna prova sicura di reità vi fosse contro gli Apicella, i quali erano vittime di vigliacchi delatori. Le legnate così non ebbero più luogo, ma i cancelli del carcere non si riaprirono per loro, che rimasero, come gli altri, uccelli di gabbia e in aspettazione di ulteriori provvedimenti.
Il numero però dei designati non era ancora al completo: ormai gli arresti potevano assimigliarsi ai fiori ed ai frutti del giardino di Armida, di cui lo spuntar dell’ uno era immeiato alla maturità dell’altro. Infatti il mattino del primo di marzo i gendarmi invasero la casa del negoziante Gaetano Potiglione e lo invitarono a seguirli. Questi, già si sapeva, avrebe dovuto subire, contemporaneamente ai primi, sì fatta violenza, ma, per essere stato in servizio, il dì innanzi, qual capoposto della guardia urbana, vide, con freddo animo, differirsi perciò il gran colpo della polizia. E venne pure il dì del redde rationem per quel Luigi De Noia, che noi notammo nel ’48 tra i più accaniti agitatori di piazza, per lo che il dieci di marzo ei fu tratto in arresto e rinchiuso nelle prigioni, che non parevano ancora abbastanza ricolme, perché il Guerra aveva una stessa natura con la lupa dantesca,
Che mai non empie la bramosa voglia, E dopo ‘I pasto ha più fame che pria.
Sguinzagliati, poscia, i gracchi alla ricerca di un Francesco Accettulli, cocchiere, e di un Vincenzo Mucelli, pescivendolo, come di altri, i cui nomi si tenevano celati, non riuscirono essi, per quanto avessero raffinato il fiuto, a scovarli, avendo entrambi già preso il largo. Non isfuggirono, per contrario, la notte del due aprile, allo arresto Ferdinando e Nicola Rosati, Francesco Paolo De Chiara, Michele Russo, Francesco Paolo Giampietro. il maniscalco Paolo Annecchino, il barbitonsore Carlo Lagonigro e Felice Patierno, sostituto cancelliere di quella regia giudicatura, come altresì, la notte del nove aprile, non evitò lo stesso fato un modesto ed innocuo negoziante del luogo, tal Michele Del Nero.
Passarono giorni lunghissimi e nessuno riuscì mai e poi mai a sapere gli sciocchi pretesti di quelle catture. Chi avrebbe avuto il coraggio di squarciare il nebbione, che ascondeva lo scempio vigliacco della libertà individuale ? Pareva, intanto, che la polizia operasse né più né meno che di sua iniziativa, perché il Guerra, come dissi, continuava sempre a far lo gnorri per non essere molestato da chicchessia nell’esecuzione intera del suo programma di nequizie. E mentre ostentava di non avere di tali iniziative poliziesche la menoma colpa, quasi assomigliandosi così agli assistenti dei sacrifizii di Giove, dei quali 1′ uno discaricava sull’ altro il fallo del bue scannato, di modo che la pena restava, in fine, al coltello, che, affatto innocente, pagava per tutti, imprese egli, con una semplicità preadamitica e senza preoccupazione di sorta, in mezzo al lutto ed alla costernazione di tante oneste famiglie, ad organizzare e menare ad effetto nel suo oratorio privato, il sei marzo di quell’ anno, gli esercizi spirituali sì per gl’impiegati di tutte le amministrazioni locali, che per i cittadini del ceto aristocratico in ispecie, invitando, all’ uopo, il quaresimalista p. Novelli dell’ ordine dei minori. Come del pari avea fatto iniziare, sin dalla sera prima, nella chiesa di s. Domenico consimili esercizii per tutti i militari della guarnigione, per la gendarmeria e per le guardie di onore con i rispettivi ufflziali, ed avea permesso che l’inviso Maldacea si avvicendasse quivi con l’ex-gesuita Contini per i relativi sermoni.
E, con lo stesso costante sistema di spudorata contraddizione, continuava ad avvenire, come per lo innanzi, che, mentre nell’ oratorio predicavasi la santa parola di perdono e di pace, vendette su vendette si consumavano tuttavia in città a danno di persone rispettabilissime. Infatti una ministeriale, provocata dal Guerra e giunta, allora allora col procaccio dello stesso giorno sei di marzo, faceva ordine al generale comandante la divisione territoriale, Marcantonio Colonna, di espellere dal Corpo delle guardie di onore, come indegni di appatenervi, Pietro De Piato, Giuseppe De Nisi e Luigi Grieco, uomini di schietta fede liberale, nonché Giuseppe Tortora di Cerignola (1) e Francesco d’ Errico di Montesantangelo. Deturpata la loro candida veste da così putrida manata di fango» dovettero costoro chinare silenti il capo di fronte all’ atto vigliacco ; che anzi, senza perdita di tempo, vollero sull’ istante deporre le armi nelle mani del capo-squadrone Gaetano Della Rocca, prendendo, a fronte alta, commiato da lui. Ed ecco il succedersi ancora dei micidiali effetti provvenienti dal clandestino scrutinio, di sopra enunciato, e che fu l’opera più nefanda e insidiosa di questo Oloferne in sembianze di anacoreta. Per esso, con decreto del ventiquattro aprile, venivano destituiti da componenti il tribunale di commercio Agnello lacuzio, Giovan Battista Postiglione e Vincenzo Cutino, nonché il cancelliere Giuseppe Santagata. Per esso il dodici di agosto furono del pari destituiti i capi di uffizio dell’ intendenza Gabriele Contini e Carlo Bianchi con suo figlio Giuseppe, nonché gli uffiziali della stessa, Giovan Giuseppe De Salvi e Giovanni Surdi, mentre subirono un traslocamento ad horas altri tre uffiziali : Luigi Giampietro e i bravi fratelli Achille e Luigi Moltedo. Per esso il quattro di ottobre, veniva rimosso dalla carica di controllore Federico Del Conte, figliuolo del direttore delle contribuzioni dirette della provincia, il quale restò anch’ egli, per riverbero, schiacciato dall’enorme peso di tanta rovina; — e per esso, da ultimo, vittima anch’egli delle ire codarde e delle stolte paure », si vide strappare di dosso la veste d’uffiziale della intendenza Nicola Capozzi, il quale fu, per giunta, arrestato e costretto in seguito, per trarre innanzi onestamente la esistenza, ad aprire una scuola e a fare da sapiente guida ai fanciulli, riuscendo così — e lo diciamo a suo onore — ad educare i teneri cuori di un’ intera generazione al culto delle virtù più sante, base granitica di ogni buon vivere civile.
Una miriade d’innocenti, insomma, fu dannata a languire tra le angarie, le persecuzioni, la miseria e le segrete, palpitando ad ogni ora sempre più pel loro destino avvenire ; e Guerra, l’autore di sì grande scempio insisteva a non darsene mai pensioni e, da comediante instancabile, mentiva le sue cure in perfezionare lo spìrito dei suoi amministrati.
Per ben otto giorni durarono, quindi, i cennati esercizii spirituali; ma dopo i primi tre, che furono tenuti nell’oratorio privato dell’intendenza, si passò nel vicino tempio parrocchiale di s. Francesco Saverio, ove potevasi rimpinzare maggior numero di veri o di falsi devoti. E qui la sera del tredici marzo l’improvvisato gran patrono, in mezzo ai più alti papaveri cittadini, con a fianco il comandante della provincia, colonnello d’Afflitto, e gli uffiziali della guarnigione, tra una marcia e una sinfonia, suonate dalla fanfara dei dragoni, fece impartire la benedizione papale dallo stesso quaresimalista Novelli, e intuonò, con gli altri, l’inno ambrosiano, chiudendo così il ciclo delle manovre religiose di quell’anno.
Il pubblico grosso non vedeva del suo intendente svolgersi alla luce del giorno, con un crescendo sbalorditivo, che la semplice e sola attività in ogni opera di carattere pio e devoto: le altre, velenose e mortifere, si consumavano sempre nell’ombra e nel mistero. L’iprocrisia avea così raggiunte le più alte vette della perfezione.
Monsignor Monforte fa costruire in Foggia, a sua iniziativa, il conservatorio denominato dell’Addolorata per rinchiudervi le orfane dell’ultimo colera, e il dì otto di settembre, all’inagurazione di esso, il Guerra, naturalmente, non manca, anzi è uno dei primi ad intervenirvi, e pronunzia pure, per l’occasione, un leccato discorso. I pp. minori osservanti ripigliano, nel quindici di settembre, il possesso della loro chiesa sotto il nome di Gesù e Maria, che loro venne tolta col convento per doversi edificare in quel posto 1′ orfanotrofio provinciale, e Guerra anche allora lo si vede pompeggiare in sedia curule entro al presbiterio, donde assiste alla sacra funzione. Anzi, nell’atto di accomiatarsi da’ frati, promette loro di volere andare in giro personalmente per ottenere, con apposito obolo da ciascun cittadino, i mezzi per riedificare il convento dappresso alla chiesa. Ed ecco che lo si vede correre il due di novembre a Biccari, ove trovavasi a dimorare pel momento il vescovo Monforte, e quivi resta tre giorni per confabulare con lui e mettersi di accordo su diversi casi, non certo di coscienza, ma di pubblica amministrazione. La mitra e l’aspersorio finirono così col conquistarlo tutto, da capo a piedi; ed ei giunse al punto di non sentirsi più affatto in grado di poter dominare senza di essi le moltitudini, specialmente quando ebbe a perdere, fin dal ventotto maggio di quell’anno, l’ausilio della guardia urbana, essendosi questa disciolta, perché richiamato in vigore un r. decreto del 1827, prescrivente non dovesse esservene mai nei capoluoghi delle provincie e dei distretti.
Con tal metodo di governo però — è d’uopo riconoscerlo1— l’intendente Guerra era davvero riescito in poco tempo a rifar le file dei borbonici e a ricondurli ai piedi del trono; che anzi otteneva perfino una manifestazione solenne di fede novella alla Casa regnante da parte del Decurionato foggiano, il quale, nella tornata del 4 luglio 1850, redigeva un indirizzo al re, assicurandolo della devozione sincera della cittadinanza, devozione non venuta mai meno anche nelle passate evenienze politiche, e che sarebbe rimasta intatta ed intangibile per l’avvenire, giacché Foggia — al dire di quell’ indirizzo — avrebbe sempre ciecamente obbedito a qualsiasi legge o decreto, che nell’alta sapienza regale si volesse dettare pel bene dei sudditi. E tale magro documento di umiliante servilismo volle il Guerra si presentasse a Ferdinando da apposita Commissione, lasciando allo stesso Decurionato il dritto di nominarla. E infatti vennero prescelti all’uopo il marchese Lorenzo Filiasi, il marchese Tommasantonio Celentano, il cav. Carlo Vincenzo Barorne e Gaetano della Rocca, i quali, avendone declinato l’incarico col pretesto d’impegni in campagna pel ricolto dei cereali, furono surrogati da Antonio Sorrentini e da Giuseppe Serrilli, entrambi a quel tempo consiglieri di beneficenza, e che partirono immantinente per Napoli. Simili ridevoli attestati di devozione furono fatti del pari dalle autorità ecclesiastiche; sicché si riunirono in quel torno a Foggia, presso il Guerra, monsignor Saivernini, arcivescovo di Manfredonia, monsignor lannuzzi, vescovo di Lucera, monsignor Cosenza, vescovo di Andria e monsignor vicario Gaetano Maldacea, rappresentante il Monforte infermo; e, dopo essersi intesi sul tenore delle dichiarazioni a fare, partirono anch’ essi per la capitale.
Ferdinando II ricevette le due Commissioni nel palazzo di Caserta, e gradì moltissimo l’attestato di fedeltà che gli veniva specialmente dalla rappresentanza di Foggia, città ch’egli diceva di prediligere tra tutte le altre del regno, e che, alla prima occasione, sarebbe venuto a visitare. In ciò apprendere il Guerra e la sua coorte se ne andarono in brodo di giuggiole, e vi attinsero maggior lena per continuare, secondo essi, a ripulire l’ambiente dagli elementi putrididi cui dovevano disperdere addirittura fin gli ultimi avanzi.
Eccoli, quindi, alle calcagna di un altro liberale, di Vincenzo De Ninno, il quale, preavvisato in tempo, potè prendere asilo presso suo fratello Antonio, un sacerdote menzionarlo della basilica foggiana. Ma Domenico Pontillo, famoso commissario di polizia, riuscì presto a scovarvelo, e fece anzi doppia preda, arrestando entrambi i fratelli, perché pretese di avere rinvenuti, in seguito ad operata perquisizione, documenti assai compromettenti. Il Monforte, all’annunzio dell’arresto del suo dipendente, ne rimase sorpreso oltremodo, e, pur non volendo sottrarlo al suo destino, chiese che gli si usasse riguardo per la veste talare che indossava; ed ottenne perciò dal Guerra che dal carcere centrale comune fosse condotto da tre canonici al convento dei pp. alcanterini, ove sarebbe rimasto in istato di arresto. Ed ecco, inoltre, destituiti Liborio, Francesco e Giambattista Del Conte, altri tre bollenti figliuoli di quel Tommasantonio, direttore delle contribuzioni dirette, presso la quale direzione erano essi stessi impiegati;—ecco destituiti Francesco Paolo Modula e Carlo Schiraldi, ufficiali della direzione del Tavoliere, e Raffaele Ferrandino, ufficiale della ricevitoria del registro e bollo. Ecco usarsi ogni mezzo perché le istruzioni delle processure contro i principali ultimi arrestati riescissero a compiersi in modo che eglino non potessero sfuggire ad una qualsivoglia condanna ; e non vi fu allora manigoldo locale che non fosse stato assunto come testimone contro di loro. E quando il nappo parve saturo di fiele li si fece partire per Lucera, ove dovevano essere giudicati. Agnello lacuzio, infatti, Francesco Paolo Vitale, Carmine Durante, Grazio Sorge, Saverio Tarantino, Luigi De Noia, Paolo Annecchino, Raffaele Perugino, Ferdinand o Rosati, Carlo Lagonigro e Nicola Capozzi, il mattino del 17 gennaio 1851, sotto buona scorta, lasciarono il carcere di Foggia, mentre gli altri vi restarono ancora, perché forse non espletata del tutto per loro la compilazione degli atti istruttorii. Il solo Gaetano Postiglione, dopo tre mesi e ventitre giorni di prigionia, con apposita ministeriale, fin dal 23 giugno 1850 era stato liberato chissà in grazia di quale santo protettore.
Un apposito rescritto, intanto, in data 30 maggio 1851, venne partecipato al procuratore generale Antonio Pepe, della Corte criminale di Lucera,rescritto, mercé il quale re Ferdinando,in occasione del suo nome, aboliva 1′ azione penale per tutti coloro che con ogni mezzo avevano sparso un malcontento contro il governo. E fu allora che la maggior parte degli arrestati foggiani dovette essere prosciolta, perché appunto cosi rubricata; in conseguenza di che si videro ritornare in seno alle proprie famiglie, cotanto provate dalla sventura, Ferdinando Cipri, Grazio Sorge, Nicola Capozzi, Saverio Tarantino, Paolo Annecchino, Battista De Toma, Raffaele Perugino, Carlo Lagonigro, Michele Russo e Luigi De Noia. Non potettero usuruire dell’ amnistia Agnello Iacuzio, Francesco Paolo Vitale, e Carmine Durante, perché essi, a differenza dei primi, dovevano rispondere dello stesso reato con l’aggravante di essere stati capi e direttori di associazioni illecite; — e, essendone devoluta la competenza al giudice regio, ottennero tutti tre, nel successivo undici di giugno, la libertà provvisoria con cauzione di ducati trecento, somma che venne sborsata da Nicola Rosati, oltre all’ obbligo di consegna assunto in cancelleria dal marchese Saverio di Rose per Iacuzio, da Giuseppe De Nisi per Vitale e da Giovanni De Anellis per Durante. La polizia avea trattenuti tuttavia in detenzione, chissà forse per cattiva interpetrazione della rubrica loro assegnata, Nicola e Ferdinando Rosati, Francesco Paolo de Chiara, Felice Patierno, Francesco Paolo Giampietro, Giovan Battista Postiglione e qualche altro ; ma anche costoro il 21 luglio 1851, con apposita disposizione del ministro di polizia, ottennero pari proscioglimento. E, con ulteriore ministeriale, furono, il primo di agosto dello stesso anno, rimessi in libertà il sacerdote Gabriele Cicella, l’abate Antonio De Ninno e suo fratello Vincenzo, esiliandosi però il Cicella a S. Martino del Molise e Vincenzo De Ninno a Potenza.
In quell’anno 1851 fu prescelto a sindaco di Foggia Alessio Barone, in sostituzione dello zio Gaetano, che non volle accettare l’onorifico incarico, e prestò il giuramento, con ogni pompa, insieme con tre assessori, nuovi eletti, il dì 11 aprile 1851 in presenza dell’intendente Guerra. Contemporaneamente si riaprì allora, per la prima volta, il Consiglio provinciale, dopo che venne chiuso nel 1847 ; e, nella seduta inaugurale del 20 maggio 1851, sotto la presidenza del principe di Ardore, l’intendente Guerra lesse un discorso di occasione, sorvolando diplomaticamente sulle dolorose vicende del ’48, e facendo voti che, per l’avvenire, l’amministrazione fosse proceduta senza più interruzione di sorta e pel massimo benessere della provincia, per ogni verso sì stremata di forze.
Siamo così pervenuti ali’ agosto del 1851, all’ epoca dolorosa in cui il terremoto devastò la Basilicata, e più specialmente i vicini paesi di Melfi, Rapolla, Rionero e Barile, seminando ovunque la desolazione e la morte. A Foggia si avvertì la scossa a diciannove ore italiane, mentre solennizzavasi la principale festa ecclesiastica della città, ma non ebbe a risentirsene alcun danno, al pari degli altri paesi della provincia, tranne che ad Ascoli, rimasta mezzo demolita. Il sentimento di pietà pei luoghi colpiti dalla sventura surse unanime in tutti i foggiani, e furono subitamente creati comitati e sottocomitati per soccorrere i proprii fratelli e sollevarne le miserie. L’intendente Guerra, intanto corse sollecitamente ad Ascoli con due ingegneri, ove constatò de visu la caduta di circa un terzo dei fabbricati, mentre gli altri due terzi erano rimasti lesionati in guisa da doverli demolire per rimetterli poi in piedi. E il dì appresso partirono da Foggia per Ascoli ben quindici traini, carichi di legname, provvedendosi così, sotto la valida direzione del nostro ingegnere municipale Luigi Mongelli, alla costruzione delle prime baracche, urgenti per la gran gente che non era più rientrata nelle case e che si era sparsa per le campagne. E a Melfi, a Rapolla, a Rionero, a Barile, che furono poi i paesi veramente flagellati, si mandarono soccorsi di ogni genere, come a dire operai, legname, coperte, vesti, frumento, faldelle e fasce pe’ feriti, nonché somme di danaro, raccolte in ogni classe. Insomma una nobile gara di carità ebbe a verificarsi tra autorità e cittadini in tale dolorosa occasione; e Foggia mostrò così pure una volta di essere madre di generosi, pronti flnanco al sacrificio, pur di lenire l’altrui miseria.
Giunse quindi notizia che Ferdinando II si era mosso da Napoli per visitare i paesi danneggiati ; per lo che le autorità foggiane improvvisarono una Commissione, composta del sindaco Alessio Barone, del 3.° eletto Giuseppe della Rocca, del marchese Lorenzo Filiasi, del vicario Maldacea e dei canonici Domenico Potignone e Angelo Rotundo, nonché del consigliere d’intendenza Antonio Cortese, per muovere alla volta di Ascoli e fare omaggio al re, come altresì a invitarlo di discendere a Foggia, ove faceasi credere lo si aspettasse anelante;—mentre Guerra già ne partiva il quattordici settembre per Savignano, confine della provincia, ond’ essere il primo a salutare il suo signore e mettersi al seguito di lui, che da Avellino, ove già era arrivato la sera innanzi con una colonna mobile di dodicimila uomini, passava a Bisaccia e quindi a Melfi come agli altri paesi della Basilicata, e finalmente ad Ascoli. Gaetano della Rocca, dopo aver riunite in Foggia tutte le guardie di onore della provincia, in tenuta di gala, verso le ore quattro, partì con loro per Ascoli, lasciando in gran moto di aspettazione la città, ove andava febbrilmente approntandosi l’appartamento al primo piano del palazzo della dogana per ospitare il sovrano. E la Commissione cittadina, fremendo di compiere il mandato affidatole, preferì, anziché ad Ascoli, di recarsi a Melfi, ove Ferdinando, compiaciuto dell’atto cortese, l’accolse con deferenza e promise, possibilmente al suo ritorno, una rapida visita a Foggia. Venuto, però, dopo pochi giorni ad Ascoli, dovè rompere la promessa, e mosse invece per Candela, donde accomiatò l’intendente e le guardie di onore, che lo avevano sin là accompagnato, rinnovellando in tutti la speranza che avrebbe resa a Foggia una visita in altra prossima occasione.
VII.
Eccoci ormai al processo pei fatti del 15 maggio ’48, che era destinato a chiudere, come bensì si disse, il gran dramma giudiziario della Corte speciale di Napoli, e in cui furono travolti due patrioti delle nostre contrade, eletti a rappresentare, con altri, la Capitanata al Parlamento napoletano, vo’ dire Luigi Zuppetta e Saverio Barbarisi.
Luigi Zuppetta, dopo la catastrofe del quindici maggio, si era già allontanato da Napoli, prendendo volontariamente la via dell’ esilio. Egli riparò a Roma ; ma, caduta nel 1849 la repubblica romana, riuscì a rifugiarsi, privo di mezzi, in cima ad un monte tra Marsiglia e Tolone, ove l’acqua, chiara,spillante dai fianchi, — secondo ei soleva dire — era il suo nettare, come le erbe selvatiche e le acerbe frutte silvestri la sua ambrosia. Ma dopo poco sentì la necessità di ritornare in seno al sociale consorzio, e si rivolse al ministro Pinelli, suo vecchio conoscente, a Torino, esprimendogli il desiderio di voler prendere dimora nel Piemonte. Ma il rude ministro gli rispose che la parte, presa da lui negli affari della penisola, era troppo eminente per lasciare la sua persona inosservata ; che sperava, perciò, gli avesse lo stato del paese, di qui a non molto, dato campo a poter seguire più liberamente il desiderio di prestar conforto a quanti soffersero per la causa della libertà italiana. In ciò apprendere Luigi Zuppetta non potea rispondere altrimenti che con alterigia e disprezzo, cosa che fece, in modo inarrivabile, con questa lettera :
Marsiglia, 12 agosto 1849.
Ill.mo Signore,
Se la parte troppo eminente, cui presi negli affari della pe¬nisola, è di ostacolo perette io possa ricevere ospitalità in Piemonte, il governo stibalpino mi punisce di non avere parteg-giato per I’ Austria e di essere stato troppo molesto al Borione, o di non avere imitato quei sedicenti liberali, le cui opere sono in antitesi con la professione di fede. La frase adoperata, signor ministro, mi rivela il principio di condotta del Ministero attuale, e mi fa presagire che qualsivoglia combinazione ministeriale successiva metterà a base della sua politica la contraddizione e la menzogna. Vero è che la S. V. Ill.ma fa balenare un raggio di futuro conforto a quelli che patirono per la causa della libertà, ma io antiveggo che non sarò nel novero dei confortati, né mi cale di esserlo. I beniamini del governo subalpino saranno scelti fra gli apostati, i liberali d’ industria, i vili adulatori, gli’ ipocriti e quelli che da Dante sarebbero intitolati :
Ruffìan, baratti e simile lordura .
Né io invidierò cotanta felicità !… La corruzione e la immoralità verranno elevate a sistema di governo. E mi dico ecc. ecc.
Professore Zuppetta.
Dopo avere egli, com è chiaro, profetizzato in colai modo, mercé pochi tratti di penna, un periodo storico intero, dovette aspettare il 1° di gennaio 1850, ministro il conte di S. Martino, per poter finalmente prendere stanza a Torino. Quivi — secondo egli stesso diceva, scudisciando a sangue senza riserve, — constatò da vicino la corruzione e la immoralità elevate a sistema di governo, e conobbe quel genio benefico e genio malefico — son proprio le sue parole – del conte di Cavour, intento a creare quella consorteria, che in breve volger di tempo convertì l’Italia in sepolcro imbiancato, e, per la quale, amor di patria era l’ambizione, merito la goffagine, scienza il ciarlatanismo, pietà la ipocrisia, politica la furfanteria, giustizia la vendetta (1).
Saverio Barbarisi, per contrario,che dopo il quindici maggio era rimasto in Napoli e che, come vedemmo, aveva arditamente levata una voce di protesta il quattordici giugno contro la illegalità del governo, fu fatto segno, nell’ora della reazione, alla più aspra vendetta, cui non potè sfuggire. Incarcerato il 17 giugno 1849, alle cinque pomeridiane, mentre dormiva saporitamente nella sua casa in via Minutoli a S.a M.a degli Angeli alle Croci, fu menato a Castelcapuano, donde, il ventinove consecutivo, fu trasportato a S.a M.a Apparente, ove rimase ad aspettare la risoluzione del suo destino, sperando, sopra tutto in un’ amnistia pei fatti del quindici maggio, secondo le reiterate promesse del ministro Longobardi’. Ma il diciannove ottobre dello stesso anno fu, con altri compagni di sventura, marchese Dragonetti, Pietro Leopardi e Giuseppe Pica, condotto da una folla di armati a castel s. Elmo. « Per più ore — è lo stesso Barbarisi che parla — fummo costretti di rimanere all’aria aperta sulle porte di quel castello, e quell’ umido e quel freddo mi rappigliarono in modo, ch’io fui presso a morire. Introdotti nel castello, fummo ricevuti in mezzo ad una fila di soldati, regolati da diversi ufficiali. Io non poteva camminare, ed a stenti, poggiato e trascinato dai signori Pica e Leopardi, potetti giungere alla spianata del castello. Ci condussero poi in un sot-terraneo; quindi fummo perquisiti scrupolosamente: ci tolsero quanto avevamo in danaro, gli orologi ed anche i libri, e, a me, pure gli occhiali. Era forse formalità ciò che si faceva, ma ci produsse un senso straordinario. Dopo, io e il marchese Dragonetti fummo chiusi in un criminale, che avea piccola apertura nel grosso di un muro, ed i signori Pica e Leopardi in un altro criminale che un’ apertura aveva sulla porta sporgente nel sotterraneo. Ci lasciarono un lume di creta a terra e, dopo circa due ore, le porte dei due criminali si aprirono, ed i soldati svizzeri ci portarono dei paglioni da soldato ed un cato di acqua. Niuna parola ci si disse, e fummo nuovamente chiusi. Chi ha un’ anima cristiana, un sentimento umanitario può immaginare quale nottata dovemmo passare. E, per colmo, gl’insetti ed i sorci ci mantennero vieppiù inquieti. Quel trattamento così strano, così feroce ci portava a credere che mire funeste vi erano su noi. Perché tanto rigore ? Perché tanta oppressione ? dicevamo. Che abbiamo fatto ? Qual’ è la nostra colpa? La mattina del venti ottobre, sul tardi, furono aperte le porte del sotterraneo e quelle dei criminali per farvi la polizia, lo e gli altri, come larve, reclamammo 1′ appoggio delle leggi per la nostra innocenza, ed a stenti potemmo ottenere di rimanere tutti quattro nel sotterraneo, che altra luce non aveva che uno spiraglio su nell’ alto del muro del castello. In quel sotterraneo rimanemmo quindici giorni; niuna comunicazione potemmo avere coi nostri, e tutto si passava con l’opera del comandante, dei suoi ufficiali e dei sergenti custodi. Era proibito di parlarci, né potevamo fare domanda ad alcuno pei nostri bisogni, se non all’uffiziale di guardia. Il comandante pensò al nostro trattamento, ma coi nostri danari; e, dopo i quindici giorni, da quel sotterraneo fummo trasportati in una stanza al piano del castello, ove rimanemmo : Pica fino al giorno 10 novembre 1849, Dragonetti e Leopardi sino al 24 giugno 1850, ed io sino al 14 luglio dello stesso anno ; ed intanto ci fecero scendere a s. Francesco, perché Dragonetti e Leopardi erano gravemente malati, ed io quasi moribondo. In tutto il tempo che noi fummo a s. Elmo ogni comunicazione coi nostri ci fu impedita, ed io una volta sola, dopo otto mesi, potetti per mezz’ ora circa vedere mia moglie. Noi eravamo guardati a vista da diverse sentinelle ; niuno dei nostri custodi poteva dirigerci una parola; le biancherie e tutt’altro ci occorreva venivano per mezzo del comandante e si giunse pure alla barbarie di dettarci le lettere, che dovevamo ai nostri scrivere. Così, e non altrimenti. A dare vie più un’idea di quello stato di oppressione è uopo far sapere che due volte la settimana veniva a raderci la barba un barbiere, che serviva il maggiore del castello. Quando costui veniva, le porte si aprivano, e l’uffiziale di guardia si sedeva nella stanza senza dirigerci neppure la parola : due sergenti custodi si mettevano sulla porta con la sentinella, che vi era sempre, ed un sergente svizzero si piazzava a fronte del barbiere. E questa vigilanza era sì triste, che, temendo di compromettere il barbiere e noi stessi, ci facevamo la barba con gli occhi chiusi. Dopo qualche tempo ci si permise di respirare in qualche ora del giorno l’aria aperta, e ci fu designato uno spazio, in cui potevamo passeggiare ; oltre le due sentinelle, che avevamo sempre alla porta ed alla finestra della nostra stanza con cancelli di ferro, se ne mettevano altre sette lungo il luogo designato : s’impediva ogni contatto, e niuno poteva passare ove noi passeggiavamo. Qual rigore! e perché !.. S. Elmo è un luogo umidissimo, e la stanza, in cui eravamo, dava un puzzo oltremodo nocivo. L’inverno dell’ anno 1849, come la primavera del 1850, fu oltremodo rigido, ed io, più degli altri, soffrii. Ho perduto quasi l’udito, e i pochi denti, che mi rimanevano, mi sono caduti. All’ età di anni 70, la mia detenzione illegale a s. Elmo dovea farmi morire ; ma la mia fede in Dio mi mantiene ancora in vita. Un processo voluminoso, intanto, erasi ammannito contro il Barbarisi dal Vesperia, procuratore generale del re alla Corte criminale di Lucera, coadiuvato dal noto Fuccilo, sotto l’influsso malefico del ministro Longobardi, relativamente ai fatti avvenuti durante il viaggio di lui nelle Puglie ; e lo si unì al Zuppetta, dalle cui idee un abisso lo divideva, raccogliendosi come quinto evangelio le dichiarazioni rese in mala fede da un marchese Letizia o da qualche altro essere consimile, che della menzogna e della calunnia avea fatto ormai, per compiacenza o per malizia, l’abituale propria divisa. E il dì, in cui venne dissepolto dalle orrorose segrete di s. Elmo, un giudizio capitale già lo aspettava. Ei, facendo allora uno sforzo sovrumano, riunì tutte quante le sue energie e scrisse 1′ esauriente Costituto, del quale abbiamo riprodotto or ora un brano, e che può dirsi sia davvero uno splendido documento di coraggio civile e di critica spieiata contro il governo del tempo.
Entrambi, dunque, Luigi Zuppetta e Saverio Barbarisi furono rovesciati senza misericordia dall’infame marea ; entrambi il procurator generale Filippo Angelillo volle aggredire, con una ferocia senza limiti, nel suo atto di accusa, monumento di nequizia e di servilismo che la storia bollava del più schiacciante disprezzo.
« Destinato il quindici maggio a giorno di ribellione, — ecco la parte dell’ atto di accusa che riguarda i due — agitatori politici venivano nelle provincie spediti, affinchè propagate anche meglio le triste massime, a riunir forze di armi e a preparare il conflitto intendessero. Destri operatori di siffatte macchinazioni Luigi Zuppetta e Saverio Barbarisi, tra i primi, in sul nascere del maggio 1848, muovevano per la provincia di Capitanata ; e scopo ai maligni loro artifizii facevano, innanzi ogni altra, la città di Foggia, sicuri forse che lo esempio della popolosa città le altre terre della provincia avrebbero in breve imitato. Giungeva invero il Zuppetta la sera del 1.° maggio nella sua terra, di Castelnuovo, e tosto intorno a sé raccolti quanti potè di quei naturali, parlava ad essi pubblicamente della necessità delle politiche riforme, che da lui già diceva essersi proposte, intorno all’ abolizione della Paria, e della centralizzazione di ogni potere governativo nella Camera dei deputati da elevarsi per 1′ oggetto a Camera Costituente ; e soggiungeva, che ove mai a queste concessioni il re non fosse per aderire, la forza delle armi nel giorno quindici maggio avrebbe il tutto deciso. Né mezzi furono da lui trascurati perché nella sua opinione gli stupefatti uditori concorressero ; che anzi, volendo alle allettatrici ed artifiziose parole accoppiare il prestigio del potere, con nuova impudenza spacciava averlo il re invitato ad amichevole conferenza per istabilire 1′ occorrente a praticarsi, e che egli, disdegnosamente rigettando il regale invito, erasi pronunciato con le più sdegnose parole : Nulla potervi essere di comune fra un re assoluto ed un rappresentante della Nazione. Celere intanto per la intera provincia la fama della sua missione divulgavasi, ed egli, da scaltro che era, della insorta agitazione approfittando, dopo alquanti giorni ricercava con gli stessi disegni la città di Foggia, ove dal Barbarisi raggiunto, grande numero e dei più influenti cittadini nella casa di una Gaetana Faccilongo riuniva. Arringò loro nella stessa sediziosa maniera, come per lo innanzi aveva nella terra di Castelnuovo operato, e al loro giudizio sottoponendo con le più raffinate arti il mentovato progetto delle sovvertitrici riforme, ad impugnar le armi, per sostenerle, li spinse, facendo nel contempo circolare nel bel mezzo della moltitudine più esemplari di un proclama intitolato — LE SETTE CONTRADDIZIONI CAPITALI — nel cui articolo quinto era detto che dimostrazioni meramente verbali dei popoli, e determinazione dei re ad operare il bene della nazione, eran cose che star non potevano insieme.
Secondo, allora, nella sediziosa arringa, al Zuppetta succedeva il Barbarisi, il quale a scrutare le intenzioni di quella moltitudine inteso, ed a misurare 1′ effetto delle ricevute impressioni, sotto il mentito colore del sociale miglioramento, la esortava a dichiararsi senza più per la necessità delle proposte riforme, perché, nel bisogno, il soccorso armato di quella provincia mancato non fosse. E bene è a credersi che a queste soltanto non si sarebbero arrestate le macchinazioni del Zuppetta ; ma le sue trame ad un tratto bruscamente rompea un messaggio, che portatore di segreto foglio, in questa dominante senza indugio il richiamava. Il qual foglio a non meno gravi cospirazioni accennar doveva, perciocché il Zuppetta, senza ritardar di un’ ora, noleggiata come meglio potè una vettura, tosto da quella provincia in compagnia dell’ espresso dipartivasi.
Uomo di principii non meno esaltati, e non meno di sedizione ingordo rimaneva colà per poco tuttavia il Barbarisi, ed indi, per la partenza del Zuppetta, tolto a sé solo l’ incarico della malaugurata missione, ad altra circostante provincia i suoi passi volgeva. Conciosiachè nel giorno dieci maggio , raggiunta Bari , sua terra di predilezione , ivi nella sala del Comune raccoglieva con invito quei cittadini, e, ad essi intendendo con ogni maniera a dimostrare non ensere nelle facoltà dei principi lo stabilire le normali forme governative, ma avere anzi i popoli il dritto a costituirsi quello che meglio utile credessero, conchiudea che, avendo riguardo alla necessità dei tempi, e facendo uso di tale diritto, avessero consentilo a scrivere pubblica solenne dichiarazione, per la quale, riunito ogni potere nella Camera dei deputati, a questa il diritto si accordasse di moderar la forma del governo, secondochè meglio a sua talento credesse. E perché a consigliar così tristi fatti la valevole spinta dell’ altrui esempio non fosse mancata, simiglianti dichiarazioni diceva essersi già fatte da molte altre città del reame, e tra esse dalle convicine di Trani, Barletta, Bisceglie, Molfetta e Giovinazzo. Le quali assicurazioni, se troppo bugiarde, da una banda, in quanto ai principii esternati dalle riferite città, che sempre al sovrano eransi dichiarate devote, dall’ altra, sventuratamente, non eran che troppo vere in quanto alle trame quivi puranco ordite dal Barbarisi, dove egli quelle pratiche istesse aveva già con ogni mezzo nei precedenti giorni adoperate, quelli identici atti di ribellione provocando.
E marcabile, sopra ogni altro, si rende come il Barbarisi, nel bisogno, all’ audacia non mancasse di unire 1′ astuzia, giacché, trovata maggior resistenza nelle pacifiche e riconoscenti città di Trani e di Giovinazzo, impudentemente spacciava in Trani come pel sedizioso movimento parteggiassero sin le onorate milizie dal grado di capitano in sotto, ed il più detestabile inganno alla città di Giovinazzo tendeva ; perciocché, intraveduti i leali principii di quella, bugiardamente asserendo non essere scopo della sua missione se non di ottenere dai popoli umil petizione al sovrano diretta, perché la durata della Camera dei Pari a quella dei deputati agguagliar si benignasse, la esortava onde tal voto avesse in iscritto manifestato. Ed intanto un già disteso abozzo di così fatta petizione a quei cittadini presentava ricoperto da foglio netto di ogni altra scritta, affinchè su questo le soscrizioni apponessero, mentre sul primo, che ben poteva a sua voglia essere da altro sostituito, la sola formola della petizione si comprendeva. Ma sia pel sentire dei popoli, sia che del tutto inosservata non andasse la fraudo, rigettati erano in ogni senso i suoi proponimenti. Fu tale però la impressione sinistra da tali fatti nelle accennate provincie di Capitanata e di Bari destata, che nel giorno dodici maggio, essendosi di bel nuovo il Barbarisi recato in Foggia, onde scrutare qual si fosse il frutto delle tessute insidie, una grave concitazione generatasi alla sola nuova del suo arrivo, ebbe mestieri che il Consiglio di pubblica sicurezza impetrasse dal maresciallo di campo conte Gaetani un presidio di truppa. da mettersi a disposizione di quell’intendente onde ovviare ai possibili danni del prodotto tumulto eco. ecc. ».
Per lo che entrambi Luigi Zuppetta e Saverio Barbarisi, insieme ad una miriade di patrioti, chiamati massa di sediziosi, vennero accusati di cospirazione contro la sicurezza interna dello Stato, nel fine di mutare il governo ed eccitare i sudditi e gli abitanti del regno ad armarsi contro 1′ autorità reale, e di avere con efficacia eccitati 1′ attentato e la guerra civile, nonché di aver provocato, con discorsi in adunanze pubbliche, il reato anzidetto, senza però che tale provocazione, nei luoghi dove fu consumata, abbia prodotto il suo effetto.
Saverio Barbarisi il 30 giugno 1851 presentò alla Corte criminale il suo Costituto in forma di Memoria ai sensi dell’art. 143 della procedura penale; e con esso, oltre ad avere eccepita, in via pregiudiziale, la incompetenza per ragione di materia e il difetto di giurisdizione in forza di recenti regi rescritti, chiamava calunniosa l’ accusa elevatagli contro a base di un processo, che potea dirsi la più sfacciata montatura della polizia, fautrice financo delle barricate del quindici maggio, sol per provocare così la reazione e quindi il seppellimento dell’instituto rappresentativo, nonché la più aspra vendetta compiutasi da quel Bozzelli, che non seppe essere né buon ministro dell’interno, né buon cittadino del regno costituzionale delle due Sicilie, unico responsabile dell’ attuale stato delle cose, e contro il cui mal governo si era sempre scagliato e scagliavasi tuttora. E proclamava, intanto, innanzi a Dio ed agli uomini la sua innocenza, rifacendo, con una semplicità veramente sorprendente, la storia dei fatti svoltisi durante il suo viaggio nelle Puglie, che ad arte dai suoi nemici erano stati mistificati e travolti. « Una circolare del Ministero dell’ interno — egli scriveva -su’ demanii comunali aveva destata l’inquietudine negli occupatori, il desiderio nelle masse di volersi far giustizia con le proprie mani. Malintesi ci furono, e nei paesi albanesi, sulle vette degli Appennini in Capitanata, dirimpetto Bovino, si trasportarono un poco di più e qualche omicidio si commise. Il duca di Bovino gridò al comunismo, e la reazione non mancò di spargere le menzogne più dispiacevoli. Si voleva far credere che il comunismo avesse occupato gli animi di tutti i pugliesi, e che la repubblica si proclamasse a Foggia. Invano io dimostrava il contrario con le lettere che aveva; invano diceva che le notizie si spargevano per portare allarmi e inquietudini. Il Ministero domandò forza per spedirla in Puglia, e gli fu negata. Quando queste cose succedevano pervenne in Napoli dall’estero Luigi Zuppetta, nativo di un piccolo paese di Capitanata, ed eletto deputato di quella provincia. Il presidente del collegio elettorale di Foggia mi aveva scritto di prender conto di lui per fargli conoscere che all’ ufficio della posta vi era un plico, direttogli col processo verbale, che la sua nomina a deputato conteneva. In vita mia non aveva mai sentito parlare che esistesse un Luigi Zuppetta, e domandai a più persone di lui. Infine lo rinvenni alla locanda dei Fiori, se mal non ricordo. Gli dissi lo incarico che io aveva avuto, ed egli mi soggiunse che avea ritirato il plico. Ci furono dei complimenti di uso, ed egli mi fece credere che avrebbe fatta una scorsa in Capitanata per vedere sua madre. Gli augurai buon viaggio. Il signor Zuppetta era venuto dall’ estero con principii non nostri, ed egli avea dato pensiero al ministro Troya per talune proposte e per talune minacce che fece. Tanto più dette sospetto la sua maniera di agire quando si seppe il suo viaggio per la Capitanata. Nella fine di aprile del 1848 fui premurato dall’ avvocato D. Gaetano Trivisani e da altri di andare subito dal presidente dei ministri Carlo Troya, perché dovea dirmi delle cose di massima importanza. Non poteva mai immaginare quello che mi propose. Dopo aver fatto elogio dei sacrificii da me fatti pel regime costituzionale, mi fece la proposta per un mio viaggio in Puglia. — In Capitanata, nelle Puglie, egli mi diceva, si è sviluppato un comunismo dispiacevole, e tante cose brutte si spacciano per Foggia e per altri luoghi. — Mi sorprese la proposta del viaggio e 1′ oggetto pel quale lo si voleva ; ed io assicurai che le notizie erano esagerate, e niente era vero, meno qualche inconveniente per male interpetrazione della circolare sui demanii del Ministero dell’ interno. Ma il presidente Troya non si persuase e vie più mi fece insistenza. Vi erano varii deputati presenti, che pure mi premurarono a partire. Io diceva che non ve n’ era bisogno, e poi non mi fidava d’intraprendere un viaggio lungo dopo tanti travagli fatti. Troya ripeteva sempre che il mio viaggio era necessario, e soggiungeva:— a tanti sacrifìcii fatti aggiungete per amor mio quest’altro. — Presi tempo a risolvermi, e, dopo altre insistenze nei giorni consecutivi, mi risolsi al viaggio. Altra istruzione non ebbi se non che la mia prudenza doveva, come la mia influenza, riparare ai disordini che avevano avuto luogo, e che potevano avere una possibile esistenza. Dovendo essere in Puglia, mi persuasi di correre fino a Lecce per vedere le cose come erano. A facilitarmi nel mio disimpegno e per conoscere lo spirito pubblico delle Puglie io con la posta scrissi ai miei amici che voleva trovare a Foggia, a Barletta, a Trani e a Bari riunite le persone più influenti per parlar loro di cose attinenti al regime costituzionale, che ci regolava ecc. Sul mio viaggio ognuno si divertiva a fare i suoi commenti. Chi mi onorava quale spia del re per andare a preparare le Puglie ad una reazione reale, chi spacciava che io andassi a proclamare la repubblica ecc. Giunsi a Foggia il cinque maggio, la sera sul tardi, quando pioveva dirottamente. Era stanco assai, e, per avere più facilità a riposarmi, ordinai al cocchiere che si fosse diretto alla migliore locanda che vi era, e fui condotto in quella che esiste al largo s. Domenico. Una stanza ebbi solo cercai qualche cosa a mangiare per potermi coricare. Nonostante l’ora tarda ed il tempo piovoso assai, pure si seppe il mio arrivo, e taluni miei parenti vennero a trovarmi per condurmi da loro. Li ringraziai, all’idea che voleva coricarmi; come infatti alla loro presenza cenai e mi coricai. La mattina del sei, a prima ora, mi recai nella casa del consigliere Bartolomeo lacuzio, allora giudice in questa G. Corte civile, e mio amicissimo, ove mi trattenni in tutto il tempo che dimorai a Foggia. Io, che non ho perduto mai tempo nel disimpegno dei miei affari, dalle prime ore di detto giorno mi misi all’opera per l’oggetto che m’interessava. Parlai in pubblico e in privato, ma non comunicai al alcuno l’oggetto del mio viaggio. Solo ebbi due lunghe conferenze col segretario generale dell’ intendenza di Capitanata, che allora funzionava da intendente, di cui non ricordo il nome, ma è facile conoscersi; a lui dissi i timori del governo del re sulla situazione di Capitanata, e la premura avuta in farmi fare un trapazzoso viaggio. Convenimmo che pericoli positivi non vi erano, e che il voluto comunismo non esisteva; che le autorità locali e provinciali potevano riparare agl’inconvenienti, ed egli mi diede in iscritto tutti gli schiarimenti che io poteva desiderare per premurare superiori disposizioni, se mai fossero necessarie. Dall’ andamento delle cose e dai discorsi tenuti ebbi motivo di persuadermi che in Foggia non vi erano idee repubblicane e solo quel malessere sociale che nelle novità politiche si osserva nei primi tempi. Però le notizie, che si erano sparse e si spargevano, davano inquietitudine; e quello che si diceva a Napoli per le Puglie, nelle Puglie si diceva per Napoli e per le altre provincie. Era poi dispiacevole l’idea dominante, cioè che non si voleva la Paria. Si tenne unione nella casa in cui era, di giorno, e a porte aperte, e v’ intervenne chi volle. In questa unione comparve Luigi Zuppetta, che a Foggia si trovava insieme col deputato di Lucera signor De Peppo. Si parlò dello stato delle cose correnti, e ricordo precisamente i propositi del signor Zuppetta. Il certo si è che io gli interruppi la parola, ed insinuai a tutti di fare delle petizioni a S. M. per fargli conoscere qual’ era stata l’idea degli elettori nella nomina dei deputati, e quali erano i voti ed i bisogni della provincia ; e si fecero anche i borri delle petizioni. Dopo ciò io partii per la provincia di Bari ; ed a Barletta, a Trani e a Bari le cose erano come in Capitanata. Riunione ci fu pubblica a Barletta, a Trani e a Bari, e le stesse insinuazioni io feci per le petizioni, ed i borri si scrissero. A Barletta, a Trani, a Bari e nei paesi tutti, che percorsi, niuna idea di comunismo o di repubblica vi era, e le solite notizie allarmanti correvano. A tutt’ i miei conoscenti, a tutti coloro che mi vennero a complimentare io feci conoscere la necessità di mantenere 1′ ordine pubblico e di appoggiare il regime costituzionale. Al mio ritorno a Foggia passai pericolo di essere arrestato per l’opera dei tristi. Corse erano le prevenzioni che era una spia del re, e che voleva una reazione reale; e mi liberai perché aveva numerosi amici e parenti. Lasciai Foggia il giorno dodici maggio, e, viaggiando sempre solo e con un legno a me, io giunsi qui in Napoli defaticato e stanco la sera,sul tardi, del tredici ecc. Per questo mio viaggio di Puglia io mi procacciai la taccia di spia del re e dei ministri ; e ciò importò che non fossi rieletto deputato né a Foggia né ad Altamura : a Foggia mi fu preferito Luigi Zuppetta, e ad Altamura Emmanuele Melisurgo ecc. »
Il dibattimento incominciò sin dal 9 dicembre 1851, pel quale furono citati nelle provincie di Foggia e di Bari moltissimi testimoni, trovatisi presenti, come si asseriva, ai varii discorsi o del Zuppetta o del Barbarisi ; e, al proposito, ricorderò che quelli, che risiedevano a Foggia, partirono, allo scopo, per Napoli il giorno dodici dicembre, mentre i soli marchese Lorenzo Filiasi, Amanzio Sebastiani e Giuseppe Libetta si dissero pel momento infermi. Ci duole però di dover qui notare che non vi fu allora anima viva che avesse avuto il coraggio di affrontare decisamente, a viso scoperto e senza reticenza alcuna, la calunniosa accusa contro il Barbarisi per disperderla sulla sua parola, al lume della verità ; — non vi fu un pugliese, guidato dalla propria coscienza, che si fosse accinto a porgere la mano senza riserve a quest’ uomo, quand’ egli avea bisogno di generosi, pronti anche al sacrifizio, per salvarlo dal carnefice. E ciò, a dir vero, non per paura soltanto, ma fors’ anche perché l’ umanità, a parte le rare eccezioni, ‘ è sempre quella che era al tempo del Circo, o che abbia tra i supplizi suoi quello ad bestias, o che abbia o che non abbia toreadores : essa, per istinto, odia il forte, perché forte ; e, quasi provando disdegno contro il caduto, pollice verso chiede che gli sia dato il colpo finale.
Innanzi alla Corte speciale di Napoli, dunque, in l.a Camera, presieduta dal cav. Niccola Morelli, giudice di gran Corte civile, funzionante da presidente per la morte del titolare Navarra, e composta da Gennaro Lastaria, Angelo Carfori, Pasquale Amato, Pietro Ciceri, Michele Vitale, Domenico lu-liani e Salvatore Mandarini, assistiti dal cancelliere Gioacchino Ascione, e con l’intervento del procuratore generale Angelillo, comparve dei nostri, sulla scranna dei giudicabili, in mezzo ad altri trenta patrioti, il solo Saverio Barbarisi , difeso dall’avvocato Enrico Pessina, perché il Zuppetta, come dicemmo, con altri cinquanta, fu contumace. Questo dibattimento, in cui venne a svolgersi e a discutersi un processo di ben dugentocinquanta volumi, durò nientemeno che ottantotto udienze, dalle quali settantuno furono impiegate a raccogliere gl’interrogatorii degli accusati, a udire ben cinquecento cinquantaquattro testimoni, tra carico e discarico, a leggere le dichiarazioni di testi defunti, assenti o uditi in altre provincie, come di centinaia di documenti acquisiti agli atti, tre udienze per la pronunziazione delle conclusioni del P. M., quattordici per le arringhe dei difensori, e diciannove ore per la decisione in Camera di Consiglio. A così lungo dibattito Saverio Barbarisi assistette con ardimento giovanile, che gli veniva dalla coscienza di sentirsi puro, invano sperando che, attraverso il pantano, potesse la verità rimaner tersa ed immaculata, e, in un ultimo momento, trionfare di un’orpellata esagerazione e della menzogna. « Pieno di fede nella propria innocenza — così il suo biografo — e nell’alto ministero che adempiva sullo scanno dei giudicabili, egli parlò sempre ai suoi giudici con un’inflessibile superiorità di animo, e non prestò loro quell’ossequio che fu sempre uso ad avere pei magistrati, memore dell’antico suo posto’, perocché magistrati non erano coloro che sedevano arbitri del suo destino, ma uomini senza onore e senza coscienza, sicarii che tramutavano l’altare della giustizia in altare d’ignominia e di vendetta. Egli fu sempre il primo a protestare, come deputato, contro la sua sottoposizione a giudizio, perché giudicabile da più alto tribunale ; e, come imputato, contro tutte le illegalità che la Corte commetteva, o che lui direttamente ferissero o i suoi compagni. E innumerevoli fatti potremmo addurre del suo coraggioso procedere in quella pubblica discussione, che parve l’ultimo gemito della caduta libertà napoletana; ma ci basterà lo additarne due soli, come esempio del suo disinteresse e della nobiltà dell’animo suo. Quando un tal Nicola Barone, l’eroe della denunzia, il cui nome io ripeto a malincuore, andò a deporre in pubblico dibattimento su’ fatti proprii relativamente al quindici maggio col solo divario di opporli ad altri, volendo far credere che Barbarisi lo abbia introdotto nel seno della Camera dei deputati, ov’ egli diceva di avere osservati i fatti deposti, affinchè il Barbarisi convalidasse o non smentisse i suoi detti, cominciò dal largheggiare in lodi, dicendolo uomo moderato e tale, che in quella notte del quattordici avea fatta ogni opera perché l’ordine fosse conservato. Ma come prima il Barone ebbe finito di dire la sua storiella, Barbarisi si levò dal suo seggio e solennemente dichiarò mendaci le parole di lui, ricusando pure ciò che avea detto in sua difesa. L’altro fatto fu simile, ma avvenne in privato, perocché un tale Ansalone, discepolo del Barone, prima di comparire in pubblica discussione, gli mandò a promettere che se gli si fosse indirizzata qualche domanda dalla difesa, avrebbe risposto in sensi favorevoli a lui. Ed egli alla persona, che recò tale notizia, rispose: essere pronto ad eleggere la morte, anziché vergognosamente salvarsi con le parole di un mentitore ».
Le conclusioni del procuratore generale Angelillo, modificanti in parte per taluni l’accusa scritta, ma rimasta la stessa pel Barbarisi, furon pòrte con tono altizzoso e sprezzante, quasi che sullo sgabello a lui dinanzi sedesse la schiuma peggiore delle classi sociali, e verso cui, fin dall’esordio, si mostrò rude, implacabile, velenoso, salutando sarcasticamente tutti con queste parole : « — Ai vinti un’ancora sola di salute rimane: uscir di speranza ! » — E, venendo quindi ad esaminare largamente i fatti relativi a Saverio Barbarisi, non gli dette tregua un momento, e, inesorabile, ribadì l’accusa di cospirazione, con elevare a quinto evangelio il risultato sì scritto che orale di un processo, cui mancava essenzialmente ogni base giuridica.
« Essendo, quindi, il Barbarisi fra i requisiti a morte — continua 1′ anonimo biografo — fu trascinato insieme con gli altri nelle così dette cantarelle, prigioni orrende di Castelcapuano, senz’ aria e senza luce. Come affetto egli era di una epatite cronica, peggiorò di molto nella sua salute per un tale passaggio, cagione efficacissima dello accorciamento dei suoi giorni. A stento gli venne concesso dopo la sua difesa, finché le altre non fossero esaurite, ritornarsene al carcere di s. Francesco per aspettar quivi il risultato della decisione. E sono da ricordare le parole ch’ egli profferì quando chiese alla Corte il transito : Signori, io non posso reggere là dove mi avete inviato ; quivi io ne morirò certamente, che sono infermo e gravemente infermo ; e dopo pochi istanti d’intervallo : ma infermo di corpo, che lo spirito mio sta saldo e sereno. Così, se egli era stato uno dei più moderati cittadini allorché i tempi volgevano propizii alla causa popolare, fu pure uno dei più forti a protestare contro 1′ oppressione, che sempre più si aumentava in durezza e baldanza; né poteva altrimenti addivenire, perocché la moderazione nella prosperità ed il servaggio nelle avversità sono due facce di una sola e medesima virtù, della costante devozione al trionfo di una idea ».
La Corte speciale, con sentenza del dì 8 ottobre 1852, ritenne pel Barbarisi, che a base delle testimonianze di un Giovanni Coppola, di un Emmanuele Caso, di un Domenico Mazziotti, di un Giosafatte Caputo, di un Carlo Trotta, di un Raffaele Granata, di un Paolo de Vita, di un Giuseppe Solidati, egli fosse stato sempre di accordo con Luigi Zuppetta per invogliare le masse di Capitanata a proclamare la repubblica, —che, a Foggia, sulle asserzioni di Girolamo Fuccilo, di Raffaele Cassitti, di Lorenzo Filiasi, di Amanzio Sebastiani, di Luigi de Luca, avesse fatte, al pari del Zuppetta, svariate allocuzioni allo scopo di combattere la Camera dei Pari e la forma della Carta costituzionale. Ritenne, altresì, che a Bari, a Barletta, a Trani, a Bisceglie, a Molfetta e a Giovinazzo, per quanto ne asserivano un Francesco Saverio Monetti, un Giùseppe d’Alessandro, un Raffaele Moscatelli, un Vincenzo Tritta, un Giuseppe Lattanzio, un Ignazio Scarano, un Giosuè De Martino, un Franesco Paolo Siciliano, un Niccola Ceglie, un Francesco Fiorentino, un Francesco Paolo e un Giuseppe Campione avesse fatto sottoscrivere dei fogli volanti come un plebiscito, tendente all’ abolizione della stessa Camera dei Pari ed alla modifica dello Statuto, mentre veniva alterando a suo talento il primo foglio, su cui era scritto il testo della petizione al re ed alla Camera elettiva, col fare intravedere, invece, che si volessero i deputati rivestiti di potestà sovrana a fo¬mare una Costituente ; cosa che a Barletta, come asserivano un Filippo Esperti, un Nicola Varila e un Domenico Elefante, gli guadagnarono la nomea di matto. Ritenne, in oltre, sulle dichiarazioni di un Vito Langellotti, di un Giovanni Romanelli, di un Raffaele Porta, di un Antonio De Gennaro, ch’ egli avesse ottenuto promessa dal comitato segreto barese di un invio di seicento armati a Napoli pel giorno quindici maggio ; e che a Foggia, al suo ritorno da Terra di Bari, per quanto ne affermavano Giuseppe Metta, Niecola Pece, Teresa Tremamundo, Diego Crispino, Angelo Imperiale, Raffaele Faiella, Pietro Colavincenzio. Paolo de Vita e L. Matteo d’ Afflitto, tradisse apertamente la delicata missione affidatagli dal ministro Troya, e vi venisse, risoluto, a porre in atto la repubblica. Ritenne, finalmente, ch’ egli nei giorni del quattordici e del quindici di maggio alla Camera e alle barricate non si mostrasse meno audace degli altri suoi colleghi, e che si coprisse di estrema fellonia quando veniva partecipando alla proposta di un governo provvisorio e del decadimento della dinastia regnante, nonché allo sfregio fatto alle statue del re, gittatesi giù sulla via dai balconi di Monteoliveto. Per tali ragioni, dichiarandolo, al pari degli altri, reo di cospirazione contro lo Stato, lo condannava, non a voti unanimi, come fece per quelli,ma a maggioranza di soli voti sei, alla pena di morte col terzo grado di pubblico esempio.
Il Barbarisi ascoltò con indifferenza la lettura della sentenza, meravigliato soltanto che lo si fosse potuto ritenere colpevole di cospirazione insieme con quel Dardano, ch’ egli stesso avea fatto imprigionare sotto il Ministero del 3 aprile per un provvedimento di prevenzione ; e si mostrò ancora più sereno quando il commissario Orsini brutalmente volle separarlo dai parenti e dagli amici e lo menò in una stanza, spoglia e deserta di ogni suppellettile, custodito a vista con due birri.
Posteriormente, mercé scritto del 14 ottobre 1852, re Ferdinando da Tiriolo, per celebrare con atti di clemenza la festa di sua moglie, che avea lasciata puerpera in Napoli, fra le altre grazie concesse, commutava al Barbarisi la pena di morte in quella dell’ ergastolo ; ma, mentre i suoi compagni andarono a raggiungere il Settembrini, l’Agresti, il Faucitano nel bagno di s. Stefano, egli non potè seguirli per le condizioni anormali di salute in cui trovavasi, soffocato nei lamenti, nelle ansie e nelle pene dalla tirannide anche prima che questa lo avesse ucciso, così come il boa del deserto, innanzi di divorare la preda, la strozza nelle sue spire. Che anzi, aggravatosi a passi di gigante nelle sue infermità, si spense di lì a poco nello stesso carcere di s. Francesco. Ai figli fu negato, allora, di asportarne la salma onoranda, ma una nobile ed influente signora, col consenso di essi, 1′ ottenne per seppellirla nel sarcofago di sua famiglia (2); e vuoisi—cosa che sarebbe stata barbarie inaudita, se vera — che il cadavere le si sia reso ammanettato ! !..
Così finì Saverio Barbarisi. Che se egli non potè rifarsi all’aura vivificante e riparatrice dei tempi nuovi, ben dovè confortarsi nella sua lenta agonia al pensiero che la storia avrebbe additato il suo nome alla riverenza ed all’ ammirazione dei posteri. « Eterni, infatti, un tiranno 1′ orgoglio suo con le piramidi: la storia vi scriverà, più saldo che nel granito, quante lagrime costarono ad un vulgo oppresso ; ed al giusto, incatenato, mostrerà le corone che serba alla virtù, tardive, ma sicure ed immarcescibili (1) ». E Foggia, sua patria, che nulla fece per lui finora, segni nel libro d’ oro delle sue memorie più care il nome- di questo martire della libertà, che aggiunse un’ altra fronda di alloro alla sua corona.
E quando l’uno dei condannati pugliesi era già disparito dalla scena del mondo, veniva giudicato in contumacia Luigi Zuppetta con Vincenzo Lanza, l’altro nostro concittadino illustre, e con un’ ulteriore miriade di patrioti, il 20 agosto 1853, dalla stessa 1a Camera della Corte speciale di Napoli, composta allora del cav. Domenico Columbro, primo presidente, e dei giudici : Vitaliano del Vecchio, Gennaro Lastaria, Angelo Canofari, Michele Vitale, Antonio Galluppi, Vincenzo Cosentini e Nicola Gubìtosi, assistiti dal cancelliere-sostituto A. Tonibone, con l’intervento dello stesso Angelillo. E, riaffermatisi per lui i fatti già prospettati nell’ atto di accusa che noi innanzi ricordammo, risuggellatasi, a più chiare note che pel Barbarisi, la sua fede antidinastica che lo spinse a tentare con ogni mezzo il rivolgimento del governo e la successiva proclamazione della repubblica,, venne condannato anch’ egli alla pena di morte col terzo grado di pubblico esempio, insieme con i suoi compagni, tra i quali non comparve l’altro nostro concittadino Giuseppe Ricciardi, perché la Corte criminale di Napoli, con decisione del 19 febbraio 1853, avea già dichiarata per lui la sua incompetenza ratione loci, rinviandolo innanzi ai magistrati di Cosenza, ove, del pari in contumacia, fu condannato alla pena capitale.
Luigi Zuppetta, intanto, percorreva .pazientemente il suo calvario a Torino, dove, siccome già vedemmo, aveva preso dimora. Dopo tre anni che vi era rimasto, lungo i quali non potette ottenere di esercitarvi la sua professione di avvocato, né d’insegnarvi dritto penale per opera di Riccardo Sineo e di Angelo Brofferio, ora soltanto, che era già stato dannato nel capo, potè essere iscritto in quell’ albo degli avvocati. Ma anche durante 1′ esercizio della sua professione fu tenuto d’ occhio dalla polizia affinchè non si moltiplicasse la sua clientela; e, cosa strana, lo stesso ministro Giovanni Lanza, il quale lo teneva segnato nel libro degli esuli politici tollerati, gli fu’ nel 1858 ostile in un concorso per titoli, cui egli prese parte per conseguire la cattedra di dritto penale nell’ arciginnasio di Genova, preferendo, con manifesta ingiustizia, un Maurizio Bensa, avvocato genovese, già fregiato da lui della croce di cavaliere per benemerenze e virtù perfettamente ignote. Il Zuppetta allora gli mandò sdegnoso la seguente lettera :
Eccellenza,
È detto che in un paese ove è permesso al medico Lanza, ministro della istruzione pubblica, di elevarsi al disopra dell’autorità delle norme legislative, di rendere illusorii i concorsi, e di farsi indegnamente giuoco della fiducia ispirata nei più rispettabili candidati dalle promesse della legge e dai pomposi inviti del potere esecutivo, un prudente straniero deve rinunziare a qualsivoglia ingerenza, rinfermarsi tra le pareti di modesta cameruccia, ed aspettare in silenzio il trionfo della giustizia. E però, vigile custode della propria dignità, io rimetto nelle mani della E. V. il venerato decreto che mi autorizza a patrocinare presso le Ecc.me Corti di questi Stati regi; e dichiaro di non volere ulteriormente profittare nemmeno del beneficio di esercitare in Piemonte la professione di avvocato.
Luigi Zuppetta.
Ripiombato così nelle strettezze finanziarie, prese a girare per parecchie città di Europa, sostenendo estemporaneamente in pubbliche accademie le più aride tesi di dritto penale comparato, che gli venivano date allora allora da quanti correvano ad ascoltarlo, affermandosi dovunque grande maestro del giure. « Ma stanco dal lavoro e dalle disagiatezze, — qui soggiunge il suo biografo — in un pomeriggio, trovandosi a Piobesi Torinese, fu colto da un improvviso sviluppo di gastricismo bilioso, che annunciavasi con tutt’ i sintomi del cholera-morbus. Egli con freddezza socratica, vedendosi in pericolo di vita e considerando che sarebbe morto quale pubblico impenitente, e quindi gli sarebbe stato negato l’onore della sepoltura usuale, pregò il giardiniere di scavargli una fossa sotto il maggiore albero del giardino dell’avvocato Enrico Fava. E non dimenticò la iscrizione sepolcrale, che consegnò imperturbato allo stesso giardiniere, con incarico di farla ritrarre a lettere cubitali sopra una rozza tavola. Tale iscrizione era del tenore seguente : Qui riposano le ossa — di Luigi Zuppetta, — nato nella Daunia, — in Napoli dannato a morte — col 3.° grado di pubblico esempio — dai carnefici di Ferdinando II — Rifuggitosi in Piemonte, — quivi nel giorno 26 agosto 1854 si ebbe morte, — sepoltura non già, — che a questo supplì la terra del giardino — dello amico Fava. — Niuno si dia pensiero di pregare per l’ anima sua, — che alla bisogna dell’ anima — egli stesso ha pensato in vita. Disposto che ebbe e tutto ciò, ingoiò ‘una certa bibita e si ravviluppò fra le coltri, aspettando con tutta calma la morte. Ma, fortunatamente, invece della morte, venne il sonno ristoratore, ed egli, alle sètte del mattino successivo, si ridestava più vivo che mai, sebbene in una indescrivibile prostrazione di forze, che lo tenne convalescente parecchio tempo ».
Avendo il Zuppetta attratta ovunque su di sé l’ammirazione dei dotti, fu fatto segno al più grande onore dal Consiglio generale della repubblica di S. Marino, che lo chiamò dapprima, nel 1858, alla cattedra d’istituzioni civili e penali, nonché a giudice supremo, e che gli commise dappoi nel febbraio 1859 la compilazione di un nuovo codice penale che meglio avesse soddisfatto alla condizione dei tempi, progetto, che senza variazione di sorta fu presto codificato, sebbene, alla partenza del Zuppetta da S. Marino, un genio maligno, come’ egli stesso lo appellava, vi avesse fatto poi addurre delle modificazioni mostruose.
E questa odissea di vita nomade pel nostro grande patriota pugliese dovè perdurare ancora ininterrotta finché non spuntò per l’Italia la nuova aurora.
VIII
Mentre a Napoli si strozzavano il libero pensiero e le coscienze adamantine di quanti avevano accarezzato in cuore un palpito generoso per la patria, ornai avvilita ed oppressa da ciurmadori e da masnadieri della peggiore risma, a Foggia riuscivano affollati gli esercizii spirituali nella chiesa parrocchiale di s. Francesco Saverio, indetti dall’intendente Guerra, secondo il suo costume, per tutti gl’impiegati e gentiluomini della città,come preparazione al precetto pasquale. Mentre a Napoli si calpestava la morale e la religione, sacrificando, sull’ara delle vendette, creature innocenti, a Foggia, indifferenti, come se nulla ciò fosse, si andava in giro, chiedendo un obolo per le feste dell’incoronazione di s.a Maria del Pozzo in Capursi per volontà dello stesso Guerra, messo a capo di una Commissione speciale, composta del giudice regio, di un consigliere di beneficenza, di un decurione, di due avvocati, di un canonico e di altri spensierati. Vessato obolo codesto, a dispetto della fame divoratrice dei nostri concittadini, degli operai, di mezza borghesia, tanto che centinaia di spostati, come già vedemmo, con maschera e fucile, infestavano le campagne, qui spogliando i viandanti e tacendo ricatti, lì uccidendo animali e dando alle fiamme le bionde spighe, per vendicarsi di chi non li accontentava, — vessato obolo, dicevo, che in un sol giorno — noi si crederebbe — ebbe ad ammontare nientemeno che a circa centodieci ducati. E mentre a Napoli si facevano i funerali della giustizia e si conculcavano i diritti dell’uomo, a Foggia, con una serenità olimpica, si festeggiava il cardinale Mattei, vescovo di Frascati, colà di passaggio per andare a Capursi, e ansanti si accorreva da ogni classe al palazzo dell’intendenza pel rituale baciamano. A Napoli Ferdinando II innalzava patiboli ai patrioti; a Foggia, in piena parvenza di gaiezza. Pio IX fregiava della commenda dell’ordine di s. Silvestro l’intendente Guerra per aver fatto accogliere con deferenza ed entusiasmo un cardinale. Oh potenza stupefaciente del gran sonnifero corruttore !…
Dopo l’atto nefando, intanto, compiutosi dalla Corte speciale di Napoli le persecuzioni poliziesche, anche tra le mura di Foggia, ricominciarono senza posa: i liberali di ieri erano, ora con un pretesto, ora con un altro, novellamente ciuffati. Essi non avevano il dritto di vivere indisturbati nelle loro case, ma la loro casa naturale doveva essere la carcere; per lo che spesso vi erano menati entro pel più lieve motivo e senza misericordia alcuna. S’imputava agli uomini la rivoluzione, come potrebbe imputarsi il fiotto ai flutti, mentre la rivoluzione è l’azione dell’ignoto. Essa ben si disse che paia l’opera comune dei grandi avvenimenti e dei grandi individui confusi, mentre è in realtà la risultante degli avvenimenti medesimi. Gli avvenimenti spendono, e gli uomini pagano; gli avvenimenti dettano, e gli uomini sottoscrivono: la rivoluzione è una forma del fenomeno immanente che ci spinge da ogni parte, e che noi chiamiamo necessità.
La notte del 27 febbraio ’53 il commissario Domenico Pontillo con i suoi scherani arrestò per misura di polizia — era questa la frase di uso — Grazio Sorge, Paolo Annecchino, Fe-dinando Cipri, Michele Russo, Nicola Mancini, Giuseppe Garofalo, Raffaele Ferrandino, Giovanni De Anellis, GaetanoTanzi, Luca e Carlo Pece, e li trascinò nel carcere centrale a disposizione dell’autorità competente. Ed anche per misura di polizia si volle l’allontanamento da Foggia del dottor Nicola De Maria e di Cannine Durante per Taranto, di Luigi Ricca per Larino, di Michele Achille Bianchi per Bari, di Giuseppe Giannini per Teramo, di Raffaele Beato per Chieti e di Vincenzo Barbarisi per Trani. Colpiti costoro come dalla folgore a cielo stellato, implorarono “dal Guerra almeno un differimento di qualche giorno per la partenza; ma il Guerra fu inesorabile, e, mercé il Pontillo, impose loro di muovere immediatamente, tra le ventiquattr’ore, per le rispettive destinazioni. Sicché, allo spirare dei fatali, quei nostri concittadini dovettero, in mezzo al rimpianto degli onesti, lasciar la patria per 1′ esilio. In tal modo Foggia veniva sbarazzata di coloro che i regi appellavano « elementi torbidi », e si lasciava adito così ai più ligi di Casa Borbone di potervi venire a loro agio e di poter pure, volendo, restarvi con ogni sicurtà e fiducia. Insomma si era riuscito a serrare i foggiani in un pugno ferreo, ch’ era quello della reazione più violenta e sfacciata.
In quell’ anno 1853, per conseguenza, la celebre fiera di maggio riuscì affollatissima di venditori e di compratori, perché nulla si aveva più a temere, come negli anni passati, di tumulti e di rivolte, cause principali del suo languore. E si notarono in quell’occasione parecchie famiglie flnanco dell’aristocrazia napoletana, venutevi per diporto , come il principe di Sannicandro presidente del-nostro Consiglio provinciale, il marchese del Vasto, il duca di Serracapriola, il principe di Torcila, il duca di Bovino con i figli e le figlie, il duca di Civitella con le sorelle, il conte del Vaglio con i figliuoli, il principe di Ardore, il principe di Luperano, il conte di Savignano, gentiluomo di Camera di S. M., figlio del suddetto duca di Bovino, con la moglie, appartenente a casa Filangieri, e moltissimi altri, che è inutile qui ricordare. Ma se vi fu concorso di gente d’ogni paese, se buoni affari vennero conchiusi tra venditori e compratori, ciò potette ingrossare vie più le borse dei ricchi e degli agiati, ma non spostò d’una linea la condizione miserrima delle classi proletarie, che continuarono a dibattersi tra gli spasimi della fame, senza speranza di miglior ventura, Che anzi le loro sorti ebbero, in seguito, ancora più a peggiorare, stantechè per un sensibile inasprimento del prezzo dei cereali, essendo asceso quello dei grani duri a carlini ventinove, con un massimo di carlini trentaquattro per ogni tomolo, e quello dei teneri a carlini ventisei, con un massimo di carlini ventisette e forse anche di più, non solo venne elevato il prezzo del pane a grana cinque e mezzo e anche a grana sei per ogni rotolo, con la minaccia di doversi elevare vie maggiormente in prosieguo, ma si temeva il pericolo che gli stessi cereali non bastassero fino al giugno del venturo anno per i bisogni del pubblico, stantechè i possessori di essi, in grazia del buon prezzo, l’avrebbero tutto venduto, senza lasciarne per quello una proporzionata provvigione. Per la qual cosa cominciò a notarsi un fermento non lieve in tutta la provincia, che mise le autorità in serio allarme. Infatti Montesantangelo dette già segni di tumulti, usando violenze contro il sindaco; ragion per cui, il dodici ottobre di quell’anno, l’intendente Guerra dovè correre sulla vetta del Gargano per estinguere colà le prime faville d’un fuoco, che, espandendosi negli altri paesi e nel capoluogo, avrebbe apportato danni irreparabili.
Fu tenuto in Foggia, intanto, il diciassette di ottobre una riunione tra l’intendente, il sindaco Alessio Barone e i diversi granisti locali allo scopo di assicurare, primieramente, che rimanessero in Foggia almeno sessantatremila tomoli di grano, dote bastevole pei bisogni dei cittadini sino a tutto giugno dell’anno ’54, quando sarebbe sopravvenuto il nuovo ricolto, calcolandosi il consumo giornaliero per la sola città, oltre le cam¬agne, in duecento ventiquattro tomoli; — e, in secondo luogo, di fissare con una certa prudenza e convenienza un prezzo equo per dette maioliche, prezzo che, se da una parte non disostasse i proprietarii, dall’altra non dovesse essere causa di aumento di quello del pane, che, avrebbe affamata ancora più la povera gente. Ma i proprietarii tennero duro, e, sebbene avessero depositati i sessantremila tomoli di grano, secondo richiedevasi, vollero che questo fosse man mano comprato al prezzo corrente in piazza, prezzo che saliva sempre più con un vero crescendo rossiniano. Il momento fu quindi molto critico per le classi infime cittadina; sicché, non potendosi fare altrimenti per migliorare in qualche modo il sostentamento quotidiano almeno degli operai, si approntarono per loro dei lavori straordinarii. Si progettò, quindi, la continuazione della costruzione della strada a getto che da Foggia conduce al di là delle vigne, già iniziatasi verso l’anno 1847, nelle stesse condizioni di miseria pubblica: come pure si progettò di costruire un nuovo tratto di strada dal ponte dell’ Incoronata sino al santuario, e di compiere altresì ulteriori opere pubbliche, che si sarebbero consecutivamente concretate. La minaccia di un aumento maggiore del prezzo del pane si avverò presto, perché il ventisette di ottobre dello stesso anno ’53 il pane ordinario si vendeva per ogni rotolo a grana sei, e il pane di pura maiolica a grana sette e mezzo. Trovandosi, intanto, da due anni innanzi, formato un incipiente Monte frumentario per largizioni di tutt’ i proprietarii foggiani a benefizio delle classi povere, fu necessità allora di cominciare a dividere fra queste il grano di detto Monte, con relativi verbali di cautela, fatti presso il conciliatore, a norma del r. decreto del 1826, per non aggravare di spese quegl’infelici. Tali verbali erano considerati come atti pubblici ed esecutivi in caso d’inadempienza di restituzione ai sensi del detto r. decreto; e l’interesse, che gli utenti ne corrispondevano, era di una misura e mezza per ogni tomolo, con restituzione al quindici luglio dell’anno segnente. Si applicarono così dei pannolini caldi, ma non si riuscì a risolvere quella che, in fondo, poteva addimandarsi una vera questione sociale.
L’intendente Guerra, passato quel momento di burrasca, riprese, senza scomporsi, il suo metodo abituale di governo : — al popolo, insomma, che chiedeva pane di frumento per sostenere il corpo, ffece dare invece pane eucaristico per la vita dello spirito. Bel sistema codesto, in vero, anche per sfollare presto ogni paese e diminuire così ai dirigenti dello Stato le noie e i grattacapi !…
In sul far dell’alba del 1° gennaio 1854 si vide circondato di gendarmi il palazzo Barone alla piazza mercantile, e il r. giudice Carlo Basile, funzionante da commissario di polizia, fattosi aprire il portone in nome della legge, procedette, tra lo scompiglio, le lagrime e i gemiti dei familiari, allo arresto del sindaco signor Alessio Barone, il quale, immantinente, senza saperne il motivo; venne condotto con la sua stessa carrozza alle prigioni centrali, mentre, contemporaneamente, veniva arrestato lo scolopio Gabriele Cicella. All’annunzio dell’ arresto del sindaco, tutta la cittadinanza, come un sol uomo, non ebbe che a manifestare meraviglia e stupore, dato l’inattaccabile onestà civile e politica di lui e l’alto ufficio civico che occupava. Si sospettò, intanto, di una falsa denunzia per maneggi settarii politici, fattagli da un antico suo lavoratore di campagna, tal Cristofaro Pucci, anch’esso giacente agli arresti. Il povero gentiluomo rimase, tra ansie e palpiti inenarrabili, per ben nove giorni interi, ristretto nelle carceri, dove andò, il giorno otto di gennaio, a interrogarlo il solo commissario di polizia sul conto di quel Pucci che lo aveva denunziato ; e potette egli riacquistare la libertà non prima del nove consecutivo, quando, mercé proteste fatte di persona da alcuni suoi parenti presso il ministro di polizia in Napoli, questi, in grazia dei precedenti di lui e dell’ attaccamento sincero al governo del tempo, si affrettò a sventare, con apposita ministeriale, le mici= diali conseguenze del complotto calunnioso orditogli contro. E tal fatto mostra pure una volta come innanzi alle propalazioni maliziose e ai sospetti non vi era, in quell’ epoca, personalità alcuna che potesse contro agguerrirsi, sia pure notoriamente non uno spirito acceso, anzi il contrario, e come si dava ad essi facile ascolto, decretandosi, senza pensarvi su due volte, manette e ceppi a quanti il più vigliacco dei cialtroni avesse avuto voglia di ricattare.
Gabriele Cicella, per contrario, scortato dalla gendarmeria, fu fatto partire per Napoli, reclamato colà dal direttore della polizia, e con lui fu fatto partire quel Cristofaro Pucci, il delatore, che lo stesso ministro avea voglia direttamente d’interrogare, e la cui sorte ulteriore rimase poi del tutto ignota. Di li a pochi giorni, intanto, si vide ritornare il Cicella dopo aver compiuta, chissà come, in Napoli la sua missione forzata; ma,siccome v’ erano dei vecchi conti da regolare tuttavia con la giustizia, che non avea certo dimenticata la parte da lui presa con entusiasmo ed ardimento veramente unico e degno di nota neh’ ora della falsa e capziosa redenzione accennata ai popoli del Mezzogiorno nel 1848, fu menato a Lucerà. Un processo dei più perfidi fu quivi confezionato per perderlo ; ed ei dovette quindi subire un giudizio strepitoso innanzi a quella Corte criminale, che si mostrò con lui inesorabile, condannandolo alla pena di venticinque anni di ferri.
In quei giorni il vescovo monsignore Antonio Monforte, la cui influenza nella cosa pubblica, siccome vedemmo, era stata grandissima, cadde ammalato. E questa volta ei si ammalò per davvero dopo le tante altre, in cui, diplomaticamente, avea simulato dovérsi curare da mali inesistenti e immaginarii sol per sottrarsi a responsabilità momentanee o a frequenti dispiaceri e delusioni. L’epigramma di Marziale ebbe così, pur troppo, a verificarsi anche per lui. E il ricordate quell’ epigramma?—Celio, per evitare di far la corte ai maggiorenti di Roma, si fasciò le gambe, si gettò su d’un seggiolone, sospirò, si lamentò, fìnse di avere la gotta; ma la fortuna gli risparmiò la pena di fìngere, e alla fine delle fini gli mandò real-mente la gotta. A parte la celia, il povero Monforte si ammalò , sul serio, tanto che il 12 febbraio 1854 vennero chiamati a consulto molti medici valentissimi, tra cui il noto dottor Giovanni Cavallaro di Napoli. Ma il responso della scienza, come quasi sempre accade in casi gravi, non dette nulla a sperare, e fu giocoforza somministrargli frettolosamente il viatico. L’indomani, tredici di febbraio, Antonino Maria Monforte si spense nell’età di anni settantatre, dopo ventun’anno e sette mesi dall’ avere amministrata la diocesi ; e le sue spoglie mortali furono deposte, per sua espressa volontà, nella chiesa parrocchiale di s. Giovanni Battista. Non si provvide presto a surrogarlo, perchè pendevano pratiche pel distacco della chiesa di Foggia da quella di Troia, con cui trovavasi conglobata, cosa che verificossi, per altro, in quello stesso anno, come diremo di qui a poco.
Raffaele Guerra, pur avendo perduto nel Monforte un valido sostegno, perchè costui, tenuto dalle moltitudini quasi in incetto di santità, esercitava sii di queste il più grande pre¬stigio, non si perdette di animo, come credevasi, e continuò, senza stancarsi mai, a stringere sempre più il freno per evi-Lare che qualsivoglia nube venisse ulteriormente a turbare la serenità politica dei foggiani. E il due di marzo la polizia arrestò, infatti, Michele Cinquepalmi, vecchio ad ottantacinque anni, some arrestò del pari Giuseppe De Ninno, sospettati amendue ii avversare l’ attuale ordine delle cose ; e nel sei di marzo consecutivo s’impadronì novellamente di Iacuzio e di Vitale, i quali già avevano riportata condanna in un giudizio nelle forme le più rigide e severe, condanna però non ancora espiata per ragioni di gravami pendenti. Sicché la notte di quel giorno furono entrambi questi ultimi inviati a Napoli, ove il ministro di polizia personalmente li aveva richiesti, secondo l’usato. Ma, con loro, il triste elenco dei perseguitati foggiani nemmeno adesso era completo, che il sedici dello stesso mese L’intendente Guerra, per ordine avutone dal Ministero di polizia, faceva arrestare telegraficamente a Genzano di Basilicata F agrimensore Antonio Caso, il quale trovavasi colà ad espletare un’ operazione peritale per incarico avutone, con altri agrimensori, dal Consiglio d’intendenza.
Chi sia stato Antonio Caso è d’uopo dirlo ad orgoglio dei suoi concittadini, perchè il suo nome fregia ormai una delle più belle pagine della storia del nostro martirologio politico. Liberale per convinzione e per sentimento, fu egli un cospiratore dei più temibili, una delle colonne del partito rivoluzionario di Capitanata. Quando la setta napoletana dell’ Unità Italiana volle estendere la sua azione in tutto il Mezzogiorno, il Caso fa il primo nella nostra provincia a secondare tali mire, e, con suo rischio, offrì la propria dimora, qual sede di convegno e poi di associazione, ai giovani più bollenti del tempo e a quanti covavano odio implacabile contro il Borbone, nell’ unico intento di cooperare alla libertà e all’unità d’Italia. Questa specie di comitato segreto, di cui egli era stato fatto capo con F appellativo di gran commissario, venne battezzato col nome di Filo elettrico, perchè i corrispondenti di esso doveano stabilirsi uno per Comune, prima nella linea consolare, poi nelle diramazioni di questa. Tutti gli affiliati, come loro primo atto dì fede e di coraggio, imbrandendo un pugnale, dovevano pre-state giuramento su di un crocifisso (1), «on la seguente formola: “giuro di serbare il segreto intorno alla presente associazione ed ai segni che mi sono stati comunicati, e giuro, in oltre, per la libertà d’Italia! Una parola d’ordine dovea pronunziarsi tra loro quante volte volessero riconoscersi a vicenda: l’uno avrebbe esclamato Viva Gesù, cui l’altro avrebbe risposto viva s. Antonio. Si era riusciti, nel massimo mistero e da veri cospiratori, a far proseliti in parecchi siti della provincia e ad eludere per un certo tempo ogni vigilanza della polizia : ma le spie pullulavano a quell’epoca come funghi per piova, e non mancarono, per conseguenza, a scoprire del pari assai presto il Filo elettrico e a darlo in pasto alla ferocia della reazione. Non appena Antonio Caso giunse da Genzano a Foggia, fu, per ordine dell’ intendente Guerra, la notte istessa, insieme al detenuto Battista De Toma, fatto partire, con poderosa scorta di gendarmi, per Napoli, dove il ministro di polizia lo reclamava, siccome aveva usato con altri, forse per fargli sentire più da vicino quanto fosse il peso della mano vendicatrice del tiranno. E il dì 4 ottobre 1854 egli comparve, pel giudizio, innanzi alla Corte criminale di Lucerà, dopo aver subite, in fosche celle, le peggiori torture morali e materiali per aver tentato invano il fisco a strappargli dalle labbra il nome dei suoi compagni di setta. Un così gran segreto gli stava sepolto nel cuore, né v’ era tema eh’ esso, per forza di lusinghe, di minacce o di raggiri potesse gorgogliare e ribollire, anche suo malgrado, come vin giovane in botte vecchia e mal cerchiata, e che finisce col trapelare tra doga e doga, e col metter di sé fuori anche una goccia sola, bastevole al saggio. Egli assistette mutolo come un muro al dibattimento; e, impassibile, senza muover ciglio, sentì pronunziare la sua condanna a morte. Gittato poscia in quelle carceri giudiziarie e malmenato come il più sozzo dei delinquenti, quivi restò fino a che tale pena venne commutata, per grazia sovrana, in quella di venti anni di ferri e di ducati mille di multa. Trasportato quindi a Napoli, venne rinchiuso, in un
(1) Questo crocifisso, di grande proporzione ed annerito dal tempo, io vidi esposto a Napoli nella Mostra de’ Ricordi storici, V anno 1911, nella gran sala municipale sulla galleria Principe di Napoli, ad occasione dei festeggiamenti del Cinquantenario del risorgimento meridionale d’Italia, come in un caleidoscopio di preziosi cimelii. Era stato esposto colà per volere e consenso di Giuseppe Caso, figlio di Antonio, mio affettuoso compagno d’infanzia, e tuttora costante amico. primo momento, nel castello del Carmine, e di qui passò al bagno di Procida, dove trascinò la catena del forzato sino al 26 giugno del 1860, quando per ordine del dittatore ne usciva. Durante i lunghi anni di martirio e di espiazione egli volle, con paziente cura, ritrarre la topografìa dei luoghi di pena, nei quali era stato sepolto; e ciò fece perchè i venturi e tutti coloro, cui avea reso il suo contributo per la conquista della libertà, sapessero come e dove scontavano i patrioti il peccato di voler redenta la loro terra dal servaggio.
Antonio Caso, tornando in Foggia a respirare aura di libertà, dopo di aver consunta mezza esistenza pel bene comune, non chiese a chicchessia né plauso, né guiderdone.
IX.
Foggia, che tra le gagliarde tanaglie dell’intendente Guerra potea dirsi ormai divenuta smorta, snervata, e mi si permetta una frase medica — dalla faccia ippocratica, ebbe, in soprassoma, a soffrire nelF anno 1854 F invasione dei bruchi nelle sue campagne, le quali rie rimasero largamente devastate, non ostante le immense e svariate cure profilattiche usatesi per ogni verso in combatterla, mercè anche F intervento da Napoli del prof. Francesco Briganti, cattedratico di scienze naturali, una vera competenza in materia. E come se il calice per essa non fosse saturo di amarezze, venne colpita da un flagello ancora più terribile, dal colera. Cominciato questi con pochi casi il 17 agosto ’54, prese a gittare ovunque, in men che noi dica, preoccupazione e scompiglio. E parve allora che Foggia si trovasse in uno di quei tempi vivamente descritti dal Manzoni, in cui, tra una compagnia di viandanti non e’ è nessuno che rompa il silenzio, e il cacciatore cammina pensieroso, con lo sguardo a terra, e la villana, zappando nel campo, smette di cantare senza avvedersene, in uno di quei tempi forieri della burrasca, quando la natura, come immota al di fuori e agitata da un travaglio interno, par che opprima ogni vivente e aggiunga non so quale gravezza ad ogni operazione, all’ ozio, all’esistenza stessa. E crebbe, crebbe in un batter d’occhio l’asiatico morbo e durò fin circa la seconda quindicina del vegnente settembre, seminando disperazione e morte. La strage si avverò a preferenza, nel quartiere dei cappuccini, donde poi dilagò per ogni sito, sicché fu adottata, anche per essa, dalle autorità locali la profilassi del caso, e si aprì un lazzaretto nel vecchio palazzo Onorati, che trovavasi fuori il ricinto della città, in posto isolato. E mentre nelle case e sulle vie, alle prese col male, si soccombeva fulmineamente, nelle chiese si facevano tridui, settenari! e novene per implorare dal Signore quello che la scienza pur troppo non potea, né sapea dare. Foggia aveva assunto per davvero il greve aspetto d’ una città morta. Chi era in condizione di poter prendere il largo, lo aveva già fatto o raggiungendo altro paese immune o 1′ aperta campagna, se non si fosse accontentato di seguire il pregiudizio di buona parte della gente grossa, di nascondersi cioè su di un qualche lastrico solare altissimo, per sfuggire così « all’ ira di Dio e rimanere esente da pena pei proprii peccati ». La paura insomma, quel brutto e contagioso sentimento,
Che ‘l sangue vago per le vene agghiaccia,
aveva invaso ogni ceto, senza distinzione: e proprietarii, e professionisti, e impiegati, tutti tutti la dettero a gambe, come tanti spiritati, tra i quali ebbe a contarsi, con universale stupore, lo stesso sindaco Alessio Barone, il quale rifugiavasi con la famiglia in un suo podere a poche miglia da Foggia, e donde non fece ritorno prima del trenta settembre, quando il terribile morbo era completamente scomparso. Per lo che vi fu impellente necessità di emettersi un r. rescritto, mercè il quale si faceva ordine ai funzionari di ripresentarsi subito in residenza, altrimenti sarebbero stati considerati come destituiti di fatto. E da una statistica approssimativa, intanto, compilatasi il diciannove settembre, potè trarsi che, dal diciassette agosto sino a quel giorno, si erano verificati dugentotrentuno casi di colera con centocinquantotto morti.
L’intendente Guerra, che non ebbe a smentir mai il suo carattere, per rendere omaggio ad un’ enciclica del pontefice Pio IX, che ordinava un giubileo per tale infausta ricorrenza, volle nel mattino del cinque dicembre, circondato dagl’ impiegati civili, praticare, come al solito, lui stesso pubblicamente la religiosa funzione, visitando con fasto le tre chiese all’uopo destinate, cioè quella di s. Giovanni Battista, l’altra di s. Pasquale e la chiesa matrice, dove si tenne la rituale benedizione. Ma, come se ciò non bastasse, volle solennizzare altresì il giorno otto dicembre, e con sfarzo maggiore, nel sagrato dell’ intendenza la festa della Concezione, quando permise che il popolo invadesse le sale del palazzo, quasi che questo fosse il centro addirittura della cristianità foggiana. Quivi omelie, inni liturgici a grande orchestra echeggiarono d’ ogni parte, mentre al di fuori, presso al portone, fra trasparenti allegorici e luminarie splendenti, si vedeva dedicato un tempietto alla Vergine, e dove la sera si sostò per poco quando ebbe ad uscire in processione, dalla chiesa parrocchiale vicina, il SS.0 , destinato all’oratorio dell’intendente, il quale seguiva il corteo, sostenendo tra mano il tradizionale ombrello di damasco rosso. Così si chiuse in Foggia l’infausto periodo colerico.
E fu in quell’ epoca che V antico voto dei foggiani venne esaudito, voto dirètto ad ottenere il vescovado con diocesi a sé, indipendente da “Troia, secondo le moltissime pratiche fattesi all’ uopo fin dal 1844 dai maggiorenti della città e dallo stesso estinto vescovo monsignor Antonino Maria Monforte, il quale preferì sempre, ad ogni altra, la residenza, di Foggia come sua sede.
Infatti la Chiesa collegiale foggiana, sotto il titolo di S.a M.a dell’Assuuta, fu finalmente eretta a vescovado, staccandosi dalla diocesi di Troia con r. rescritto del 12 aprile 1854, e fu restituita così al prisco onore della madre antica, come vollero taluni, perciocché Arpi avea pure il suo vescovo. Ma, checché sia di ciò, F importanza eh’ ebbe la chiesa di Foggia sin dal 1′ epoca della sua fondazione, che risale a Roberto Guiscardo, e completata da Guglielmo II, ultimo dei Normanni (anno Do¬mini MCLXXII m. madii), come rilevasi da un’ antica lapide messa sul sommo della sua porta maggiore, non è certo da andare ignorata. Che anzi la dotazione, di cui essa ebbe a godere, fu sempre delle più laute e cospicue, in grazia di sovrane concessioni. E fu Carlo I d’Angiò che cedette archipresbytero et capitulo maioris ecclesiae fogitanae le decime di tutt’ i dritti reali della città di Foggia cathoUci reges Siciliae, che erano appunto i sovrani normanni, edificatori del tempio considerando per tal modo la chiesa foggiana e come prelatura minore, perchè succeduta alla cattedra vescovile di Arpi, indipendente del tutto dalla diocesi di Troia, e benanche come loro regia cappella palatina. E fu lo stesso principe che le donò un intero dritto di regalia, qual’era il dazio che si esigeva sullo scannagio degli animali nel perimetro della sua intera giurisdizione, chiamato il corpo fiscale del dritto, che la Corte esigeva sul macello, da non confondersi punto col ius bucceriae, quale dote Carlo II si compiacque anch’ egli di ac-crescere con assegnarle ulteriori annue prestazioni. E non si mostrarono da meno degli angioini i re della dinastia aragonese, che Alfonso I e Ferdinando II l’arricchirono di nuovi privilegi, estimandola sempre nei loro regali diplomi come una delle maggiori chiese del regno, major ecclesia Fogiae. E la stessa antica università foggiana, con erigerla dappoi a sua chiesa di ius patronato, le assegnava annui ducati quattrocento di dote, che, con deliberato del 7 settembre 1740, i reggimentarii o decurioni della città ampliavano vie più, assegnandole, con la creazione di una congrega di spirito sotto il nome della Iconavetere, gli emolumenti chiamati di porta e rotolo, che pel passato si erano annualmente percepiti dal mastrogiurato prò tempore, e che, in seguito, per speciale convenzione, venivano divisi tra il mastrogiurato istesso e gli eletti.
Ora, giunto il momento di ridare alla nostra chiesa l’antico splendore e di sottrarla pure una volta dalla tutela della curia troiana, vi fu lotta aspra—e non poteva essere altrimenti — per la costituzione appunto della sua mensa vescovile. Si volle in un primo tempo, cioè il 28 di giugno ’54, che il pontefice, segregando la rendita della mensa di Troia da quella di Foggia, lasciasse a quest’ ultima anche la proprietà dell’ ex-feudo o casale di s. Lorenzo in Carminiano, ottenuto per legato da re Ruggiero I normanno nel settembre 1092, e di cui la mensa di Troia avea sino allora percepiti i frutti per semplice ragione di amministrazione. Ciò però non potette verificarsi per F accanita opposizione del capitolo troiano, che avea mandati in Roma appositi delegati a combattere tale pretesa. Fu necessità quindi che il Capitolo di Foggia deputasse all’ uopo un suo rappresentante (1) per sostenere colà i diritti e le difese della chiesa foggiana. Ma se aspro e lungo fu il dibattito, si riuscì per altro ad ottenere finalmente il distacco della diocesi di Foggia da quella di Troia, chè il pontefice, con bolla del 14 aprile ’55, dichiarava cattedrale la nostra chiesa basilica con- destinazione vescovile, comprendendo nella sua diocesi la città di S. Marco in Lamis, sino allora amministrata dall’arcivescovo di Manfredonia, e stabilendo la rendita della sua mensa sul terzo pensionabile, determinato per annui ducati duemila e quattrocento a peso della chiesa di Troia. Destinato, quindi, per la erezione della cattedra fu il vescovo di Lucerà monsignor Giuseppe Jannuzzi, dandoglisi all’ uopo tutte le facoltà qual sub-delegato apostolico; sicché tale mandato venne da lui stesso annunziato il 28 luglio ’55 con lettera diretta alla prima dignità del Capitolo di Foggia, nonché al sindaco della stessa città. Fu egli, perciò, che fece rilevare un’ apposita pianta topografica per poter stabilire i confini delle due diocesi, e che dovette assistere a larga conferenza tenutasi da speciale deputazione (1), venuta il 21 settembre ’55 da Foggia per confutare, a norma di bolle pontificie e dei dettami del Concilio di Trento; le pretese del Capitolo troiano sul santuario dell’ Incoronata e sulla cappella di s. Lorenzo, a fine di decidere se codesti due poderi dovessero entrambi conglobarsi 0 non nella nuova diocesi. E monsignor Iannuzzi, incaricato con sovrano rescritto del 22 dicembre di quell’ anno a risolvere da sé tale questione cotanto dibattuta, ordinava con decreto inappellabile del dì 11 gennaio 1856, che il solo santuario dell’ Incoronata si aggregasse alla diocesi di Foggia, perchè posto neh” ambito della stessa, ma che la cappella di s. Lorenzo rimanesse tuttavia alla dipendenza del vescovo di Troia, trovandosi in quel territorio. Ciò pure riusciva da solo, a dir vero, di grande vantaggio della nuova diocesi, avuto riguardo, oltre alla rendita di un terreno boscoso preziosissimo, ai provventi rilevanti annuali del santuario per oblazioni e voti, essendosi raggiunto, nei due mesi di aprile e di maggio dell’anno 1855, un numero nientemeno — noi si crederebbe — di ben ventisettemila messe. Con lo stesso lannuzzi fu stipulato F istrumento riguardante la erezione in cattedra della chiesa dal municipio di Foggia, rappresentato dal signor Francesco Paolo Villani, funzionante da sindaco; il che ebbe luogo in Lucerà il dì 3 gennaio 1856 per notar Andrea Modula, riservandosi altresì con detto rogito, a prò del municipio, tutt’ i diritti di precedenza e di patronato, che da tempo remoto esso aveva nella basilica costantemente esercitati. Quale riserva fu suggerita da gravi ragioni nello interesse del Comune, il quale fin dal 1841 avea sostenuta una lite giudiziaria strepitosa presso la Consulta generale del regno contro il Capitolo, dimostrando, mediante antichi documenti e, in ispezie, in -orza di un rogito del 12 novembre 1674, il dritto di patronato dell’università foggiana sulla chiesa -e sulla cappella della sacra Icone. Tale causa, strenuamente difesa dai signori Francesco Targiani e avv. Tommaso Perifano, venne decisa favorevolmente pel Comune nel 1843, e l’avviso della Consulta di Stato venne sancito da sovrano rescritto. Fu per cotal modo dato finalmente dal sub-delegato apostolico monsignor lannuzzi il possesso della nuova cattedra nel dì 2 febbraio 1856 con solennità pubblica e con popolari feste, durate per tre giorni interi.
Si attese quindi dai foggiani con grande ansia la nomina del loro primo vescovo. Infatti cominciò a buccinarsi il nome del sacerdote Pasquale Ricci, maestro di sacra teologia nel seminario arcivescovile di Napoli, ma poscia si seppe che questi non aveva accettato 1′ alto ufficio, e che erasi invitato, in sua vece, il sacerdote Prospero Tizzani, preposto della chiesa della Trinità dei Pellegrini in Napoli, il quale, alla sua volta, vi aveva pur rinunziato. Finalmente pervenne al Capitolo la notizia ufficiale della nomina a Pastore della nascente diocesi in persona di Bernardino Maria Frascolla, can.co della chiesa cattedrale di Andria, uomo di assai acuto ingegno, di grande dottrina’nelle materie teologiche, e, quel che è più, oratore eloquentissimo. Questi, venuto in Foggia sulle ventidue ore del 27 luglio 1856, e, entratovi con ogni pompa, sul, rituale caratteristico cavallo bianco, fece un’ ottima impressione alla cittadinanza per la sua dignità, dottrina ed eloquenza, veramente ammirevoli.
Egli cercò di rialzare, con ogni mezzo, il prestigio dell’ autorità episcopale, e, allo scopo, richiamò, fra l’ altro, in osservanza un antico cerimoniale della chiesa relativamente ai grandi pontificali, cioè quello che due primarii e nobili gentiluomini della città facciano sempre da cavalieri presso il solio con l’apprestare l’acqua, nei lavamani che fa il vescovo, portando uno il boccale col bacino e l’ altro il tovagliuòlo in guantiera di argento. Sicché un tale cerimoniale si vide per la prima volta adottato nella festa della patrona della città, il quindici agosto di quell’anno, quando furono chiamati a compiere l’onorifico ufficio i signori Giacomo Celentano e Francesco Paolo Villani, vestiti entrambi con abiti di spada.
E, col prestigio dell’ autorità episcopale, riuscì egli a rialzare benanche le condizioni dell’ insegnamento nel seminario diocesano, chiamando uomini di polso ad occuparne le cattedre ; e tentò di dare inoltre, più giù, grande impulso al giovane clero nella palestra oratoria, di cui egli era un atleta, esortandoli col dire : « E’ ornai tempo d’ingagliardire i sensi di fede nelle classi civili, mercè la splendida parola, e d’alimentare il patriottismo vero contro la insidia di coloro che attentano alla fede d’Italia ». Ed egli stesso, dopo quattro anni dalla inaugurazione del suo episcopato, volle con le sue prediche quaresimali « invitare al pascolo della fede il suo gregge, lasciando al paese il più bel ricordo d’un vescovo, la parola eloquente, erede del prestigio toccato ai Crisostomi e ai Basilii » (1).
X.
La pazza e tormentosa tirannia borbonica de’ giorni di straripante reazione, che abbiamo già innanzi notata, si acuì vie più quando il famoso Orazio Mazza, direttore della polizia, redigeva la celebre circolare relativamente agli attendibili (leggi liberali), le cui liste, ideate dal Peccheneda, suo degno predecessore, e che chiamerei di vera proscrizione dal grembo della umanità vivente, erano pur numerose di patrioti foggiani. In quella circolare, che fu mandata a tutti gì’ intendenti e ai sotto-intendenti del regno, e, per conseguenza, anche a Raffaele Guerra, le istruzioni, che, con un senso di profondo disgusto, vi si leggevano, erano le seguenti :
1.° Vigilanza perenne sugli attendibili, ben rintracciandosi i loro movimenti ed i loro comitati, le abituali loro riunioni, in quali siti’ precisamente, e F oggetto vero di esse
— 2.° Quali attendibili sieno più frequenti nella lettura dei giornali, dove e quando si leggano, quali discussioni si facciano; in qual senso si apprendano le notizie, chi ne sia lo spacciatore
— 3.° Se gli attendibili sieno in contatto con persone influenti, e quale ne sia la ragione
— 4.° Udire con circospezione i discorsi degli ecclesiastici
— 5.° Esaminare se il partito dei realisti si vegga scoraggiato, e, in questo caso, dargli appoggio
— 6.° Seguirsi dappertutto i girovaghi, comici ecc. ed ogni individuo che, senza un oggetto ben noto, si trasferisca da un Comune all’ altro
—7.° Vigilanza accortissima sulla corrispondenza epistolare, ed aprirsi col massimo- riserbo le lettere dirette ai demagoghi
— 8.° Fare minuto elenco di coloro che fanno uso di cappelli di strana foggia e di barbe intere
— 9.° Vedere quali case frequentino gli attendibili, specialmente la sera.
È da figurarsi, sotto l’ usbergo di tale circolare, a quale ridda potettero abbandonarsi i sanfedisti e le spie a danno dell’ universale, tanto che il 5 agosto ’55 lord Palmerston alla Camera dei Comuni, dando lettura dell’ esecrando documento, provocò si proclamasse essere dovere di umanità e di decoro per tutti gli Stati costituiti il mettere al bando della civiltà il governo borbonico, che un’altra illustrazione inglese, Guglielmo Gladstone, appellava dappoi « la negazione di Dio ». Per gli attendibili, insomma, non vi era habeas corpus, ma li si considerava a dirittura destituiti d’ ogni protezione di legge. Qualsiasi denunzia, fin provocata da odii personali o da vendette collettive, bastava per applicar loro le manette e per tenerli nel fondo di una carcere lungo un mese, due ed anche un anno, senza intervento di magistrato ; come, del pari, ad ogni lieve sospetto di perturbamento della pubblica quiete, la polizia davasi ad invadere le case e a perquirerne ogni angolo, senza aver riguardo di chicchessia. Era quindi naturale che anche a Foggia, cotanto ricca di attendibili e di attendibilissimi, niuno potesse rimanere risparmiato da vessazioni e da incessanti, da inesauribili persecuzioni. Al menomo cenno, infatti,, di qualche spia, la polizia, individualizzata nel feroce ‘ Fujano, il famigerato sergente della gendarmeria, l’occhio destro di Guerra, calpestava chiunque senza riguardi di sorta, e ne bistrattava selvaggiamente opinione e onore. E fra i tanti aggravii molesti ed atti arbitrarli orrorosi quivi consumatisi per mesi e mesi, senza prender mai lena, si osò perfino di lasciare ingarentita la persona del sindaco, commettendosi un bis in idem col riprodursi cioè, in tempi ormai più tristi, quasi quello che si era fatto per Alessio Barone in Vincenzo Celen-tano, di cui si mise in dubbio, dopo appena tre mesi dalla sua nomina, con una leggerezza e con una perfìdia da far rabbrividire, la onestà civile, ormai nota per urbem et orbem, come noto altresì era il suo attaccamento al governo, umiliandone il giusto orgoglio con una visita domiciliare, il 25 agosto 1856, a mezzo del commissario di polizia, e risultata completamente negativa.
Epoca pur troppo miseranda codesta di nefandezze orrorose e vigliacche!… Ma meglio che essere insidiato e colpito alle spalle da mano ignota, nell’ ombra, senza saper nulla di nulla, senza il menomo prodromo del sospetto, non erano forse da preferirsi le forche del novantanove o le fruste del ventuno ?
Il 12 dicembre ’56 giunse a Foggia la notizia dell’ attentato contro Ferdinando II, compiutosi in Napoli F otto dicembre da Agesilao Milano, da quell’ ardente calabrese, imitatore „ di Cassio Cherea, che tentò di ridestare in Roma la liberta repressa da Tiberio e soffocata da Caligola, con uccidere costui. L’impressione, in vario senso, di un tale accaduto fu e-norme; e il Guerra, chiudendo ogni adito a dimostrazioni anche lontanamente favorevoli da parte di chicchessia, fu sollecito ad ordinare invece ringraziamenti a Dio ed al paradiso intero per lo scampato pericolo del re. Ed ecco un’ improvvisata celebrazione di messa solenne ed un Te Deum, con invito plenario ad autorità civili e militari nel solito oratorio dell’ intendenza ; ecco, con F intervento dello stesso intendente, dei funzionarti e degli impiegati di tutte le pubbliche amministrazioni, un’ altra messa, ancora più solenne, nella cattedrale, ed un’ omelia del vescovo Frascolla, che si scagliò contro il regicida con parole di fuoco, bollando il suo atto come derivante « da perfidia, da sfrenatezza di costumi e da poco timore di- vino ». E, dopo il consueto giro in corteo per le vie della città come protesta collettiva, si cominciarono a mandare, con ap-posite staffette in Napoli, indirizzi di congratulazioni diretta-mente a Ferdinando.
Come se ciò non fosse già troppo, si organizzarono delle deputazioni speciali per fare ostensivi a lui col vivo della voce i sentimenti di cordoglio delle popolazioni di Capitanata, e, ad un tempo, di attaccamento e di fedeltà. E’nel quindici dicembre, due giorni dopo in cui Agesilao Milano in piazza del Cavalcatolo, vestito dell’ abito del 4.° grado di pubblico e-sempio, era stato, di fronte al suo battaglione, soppresso dal carnefice col capestro, o, come dicevasi, col laccio in sulle for-che, dopo aver gridato, secondo ne scrisse il commissario Ber* tini nella sua relazione, «Dio mio, muoio come un ladro per la libertà d’Italia ! » (1), partì da Foggia una prima deputazione, composta del vescovo Frascolla e del can.co Antonio Zicari, i quali fecero ritorno il diciotto dello stesso mese, lieti entrambi di aver provocato con la loro presenza il gradimento del re. E, nel ventinove consecutivo, ne partì una seconda, molto più numerosa e imponente, composta di monsignor Iannuzzi, vescovo di Lucerà, di monsignor Passero, vescovo di Troia, di monsignor Rossi, vescovo di Sansevero, dei sindaci di Foggia e di Lucerà, nonché dei signori barone Giambattista d’Amelj di Lucerà, di Antonio Sorrentini di Foggia e di un Fiorde-lisi di Cerignola, ai quali volle accompagnarsi il vescovo Frascolla, desideroso di rivedere pure una volta la paffuta faccia del re. Ed anche in tale rincontro, con arte machiavellica, si riesciva a cloroformizzare il sentimento delle masse, che, nell’intimo fondo del loro animo, non poteano non palpitare di simpatia pel poco avventuroso soldato calabrese, giacché non vi ha popolo libero senza la morte del tiranno, o, come disse il Lavicomterie, «finché il tiranno respira, la libertà soffoca».
Foggia, intanto, ch’era divenuta in apparenza sì docile e remissiva sótto il torchio premente ed asfissiante del Guerra, si aspettava, d’altra parte, che di tale docilità e remissione ai fosse tenuto conto nelle alte sfere per risparmiarla almeno da onte assai vergognose, da gratuiti e sanguinosi oltraggi. Eppure, per una fatalità inconcepibile, la nostra città era destinata ad assumere la figura di Cenerentola di fronte alle altre sorelle di Capitanata, e a rassegnarsi, suo malgrado, specialmente alle preferenze ingiustificate verso di Lucerà, con cui da tempo trovavasi in gara. E il suo livore contro di questa, rimasto sempre latente, però vivo e scoppiettante ad ogni minima occasione, ebbe anche in quel torno di tempo vie più ad acuirsi, perchè, con decreto del 2 di aprile 1857, Ferdinando II credette di elevare a liceo il collegio di Lucerà, tenuto dai pp. gesuiti, la sciando nell’ oblio il r. collegio di Foggia, che sotto la sapiente scorta degli scolopii aveva educato alla scienza ed alla letteratura parecchie generazioni, ornando, specialmente Foggia, di una pleiade di uomini preclari.
E non potea dissimularsi dai foggiani l’ingrata impressione ricevutasi nel ventiquattro aprile consecutivo per tale munificenza reale verso Lucerà, quando il capoluogo avea ben dritto di essere preferito a ogni altro paese della provincia, e a codesta città, in ispecie, che trovavasi ad avere, per giunta, un tribunale per mero caso e in semplice via transitoria, divenuta poi definitiva a detrimento di Foggia. Il fatto dell’elevamento a liceo di quel collegio, se provocò le loro proteste, non lo fu certo per sé medesimo, isolatamente preso, ma perchè ebbe a vedersi a chiare note che non si tenesse in alcun conto il capoluogo, e che anzi lo si volesse porre addirittura in coda della provincia anche relativamente all’ insegnamento della giovane generazione, come, con inconsulto criterio, si era fatto per l’amministrazione della giustizia. Che se, pur protestandosi, ebbe a comprendersi che, innanzi all’ultimo fatto compiuto in suo danno, non restasse che chinare il capo, per non potersi rifare un decreto già pubblicato, risorse allora in ognuno, con più buona ragione il desiderio di riparazione, almeno in parte, al grave ed antico torto subito ; e, visto che trovavasi in progetto una concessione reale di staccate sezioni di tribunale civile a parecchie provincie, cercò di domandarne una per sé. Ogni ulteriore ingiustizia, insomma, che compi vasi, non faceva che rianimare nei foggiani le doglie di una piaga non mai risanata, non potendosi riconoscere in alcun’ altra dritti acquisiti che solo la loro città potea vantare.
Perchè non è ozioso qui il ripetere pure una volta, fra le tante, che Foggia per la sua splendida giacitura, per la sua centralità nella Capitanata godette da tempo immemorabile il dritto del foro, dritto che ereditava legittimamente da Arpi, città libera sui iuris, e dove risiedeva la suprema magistratura, pretoria, siccome rilevasi da un documento dell’ottobre 1280, che serbasi nell” archivio del Capitolo di Foggia (1). Che sin dall’ epoca di Basilio II diveniva essa la sede dèi Catapani, specie di magistratura, cui, per quanto ne riferiscono Guglielmo Appulo (2) e Leone Ostiense (3), fu dato tal nome pel gran potere o potere supremo,’ del quale erano investiti, additandosi tuttavia, secondo tradizione, col nome di Corte dèi Catapano il palazzo ove stanziava il Catapanato. Che, in seguito, lo svevo vi stabiliva l’Imperial Magistrato di giustizia, tribunale dalle forme dell’ antica legislazione alemanna ; dopo di cui Alfonso d’ Aragona vi fissava un commissario o un doganiere, e poscia un uditore, e, più giù, un fiscale o presidente con facoltà di garentire l’industria degli armenti, e di esigere le fide, e di decidere sommariamente le liti nell’ interesse dei pastori. Che il figlio di costui, Ferdinando I, agnominato Ferrante, v’instituiva dappoi il gran tribunale della dogana, cum piena jurisdictione civili et criminali, mero et mixto imperio et gladii potestate, da cui discendevano, in grado di appello, le così dette tenenze doganali, uffizii destinati a decidere le piccole cause dei locati o doganati, e che risiedevano in Aquila, in Solmona, in Castellaneta, in Taranto, e fino in Cosenza e in Catanzaro, tribunale codesto veramente unico in Italia, come Osservava il nostro Marcantonio Coda (4), cui sottostavano tutt’i titolati, baroni ed università del regno non solo, ma gli stessi prelati, concedendosi loro completa guarentigia ed immunità, e mille privilegi, fra’ quali l’asporta» zione di armi. Che, abolitasi la dogana del Tavoliere da Giù-seppe Bonaparte, il quale concedeva a colonia perpetua le sue terre mercè la legge del 21 maggio 1806, cessarono, per conseguenza, le funzioni del tribunale di Foggia, funzioni sene,rimasero, invece, attribuite alla magistratura comune. I foggiami, ragionevolmente, ebbero a deplorare non poco la perdita fatta, e fin d’allora presero a supplicare perchè fosse loro concesso, in rimpiazzo, un tribunale ordinario. E non furono vane le loro suppliche, che Gioacchino Murat, succeduto a Giuseppe Bonaparte, con decreto del 26 di settembre 1808, dispose « che la residenza del tribunale di prima istanza e del tribunale criminale per la provincia di Capitanata venisse stabilita in Foggia nel palazzo1 dell’ abolita regia dogana ». Però la installazione non ebbe luogo (vedi triste caso !) per un dissentimento insorto tra il mastrogiurato di quel tempo, tal Gioacchino Antonellis, ed il barone Nolli, intendente. Costui, nonostante il luogo indicato dal real decreto, pretendeva che il tribunale si collocasse, per contrario, nel convento di s. Domenico, di cui prevedeva la prossima soppressione, per far rimanere all’ intendenza tutto il palazzo dell’antica dogana. Fu allora che il mastrogiurato Antonellis, volendo proteggere i domenicani, fece di notte tempo rilevare una pianta topografica di quel palazzo per dimostrare che in esso potevano ben contenersi e gli uffici del tribunale e quelli dell’ intendenza. Di ciò si offese il Nolli, il quale giurò, a dispetto, che questo non sarebbe più venuto in Foggia ; e provocò egli stesso, infatti, altro decreto, sottoscritto dal Murat a Baiona, col quale si dispose che provvisoriamente il tribunale si conferisse a Lucerà.
Fu dunque alla gretta gara di due persone che avrebbero dovuto porre un freno all’impeto delle proprie passioni e pen-sare più seriamente al bene pubblico, anziché manomettere i dritti del capoluogo, le cui sorti erano loro affidate; fu a codesta poca diligenza, alla leggerezza di due tipi troppo vivi e garosi, e non già a necessità di convenienze topografiche, a voto concorde della provincia o ad altra ragion di Stato che Lucerà deve la odierna sede del tribunale. Che se questo non fu più di là rimosso né da Ferdinando I di Borbone col Suo decreto speciale del 1.° maggio 1816, dovuto chissà a quali possenti influenze o a pratiche segrete, perchè in contraddizione della stessa legge organica di pari data, con la quale si disponeva che non solo il tribunale civile e quello di commerciò, ma la Corte di giustizia civile e criminale, la Corte di Assise e financo il giudice istruttore distrettuale dovessero risiedere nelle capitali delle provincie, e per la Capitanata, a Foggia (1), né rimosso da Ferdinando IJ col rescritto del 16 maggio 1837 (2) lo fu solo per essersi voluto rispettare lo statu qua ante.,., rendendosi così omaggio ai predecessori, e per volere distribuiti i diversi vantaggi à tutt’ i paesi del reame indistintamente, allo scopo di non dispiacerne alcuno e di non addoppiare in tal modo la dose dei nemici di casa Borbone, i quali han sempre pesato nell’una delle coppe della bilancia. Nonpertanto non si osò mai da chicchessia sconoscere il dritto in Foggia di continuare ad essere T antica sede di giustizia per la Capitanata e di riavere perciò quel tribunale che le era stato finalmente concesso e che in linea provvisoria avea perduto, dritto che col mutar degli uomini resta invulnerato, e il cui pensiero di rivendicazione, sempre vivo, sempre desto, sempre dominante, passa, come la fiaccola delle Panatenee, di generazione in generazione,
(1) L’art. 2.° della legge del 1.° maggio 1816 diceva così : « Ciascuna provincia avrà le sue amministrazioni separate, le quali risiederanno nelle rispettive capitali. Queste sono Napoli, Caserta, Salerno, Potenza, Avellino, Poggia, Bari, Lecce, Cosenza, Reggio, Catanzaro, Compobasso, Chieti, Aquila e Teramo. E la relazione, che .precedeva tale legge e che portava la firma del ministro Francesco Ricciardi, conte dei Camaldoli, usciva in questi detti : « Per ciò che riguarda la sede dei tribunali, non ho consultato che il comodo dei litiganti. Così per la Capitanata, Samevero e Foggia, sono le due sedi più comode, quella per la parte settentrionale e questa per la meridionale. È ben vero che Lucerà, più che Foggia, è vicina al Fortore, che limita la Capitanata nella parte occi¬dentale ; ma tale vantaggio è di poca importanza, giacché Foggia non ne dista poi tanto dal confine orientale verso il mare, e dal confine meridionale, che è l’Ofanto. In Foggia il commercio, l’industria, la sede dell’intendenza richiamano tutta la provincia ; in Lu¬cerà bisogna andare espressamente. Finalmente a Foggia non vi è necessità di fare nuove spese ; il locale vastissimo, che ivi esiste, si presta a tutt’ i bisogni ». (Vedi Scritti e Documenti varii di Francesco Ricciardi, conte dei Camaldoli, preceduti dalla sua Vita, scritta da suo figlio Giuseppe, e da un’introduzione di Leopoldo Tarantini, pag. 156 e 157, – Napoli, 1873.
Il decreto, di pari data, diceva all’ art. 1.° così : « Le disposizioni dell’ art. 2.° della nostra legge in data di oggi sulla circoscrizione dei nostri reali domimi al di qua del Faro non fanno veruna innovazione sull’ attuale residenza dei tribunali delle provincie di Terra di lavoro, Capitanata e Terra dì Bari ».
(2) Il rescritto cominciava con queste precise parole : « Sua Maestà, imitando 1′ esem¬pio dei suoi predecessori, non ha creduto nella sua saggezza di permettere di trasferirsi in Foggia i tribunali, che dalla loro installazione furono sempre in Lucerà ecc., tanto più che la città’ di Foggia gode d’altra parte il vantaggio di avere l’intendenza, il tri¬bunale di commercio e l’interessante amministrazione del Tavoliere ».
perchè vi è un antico proverbio che dice : Quelli che hanno scordano, ma quelli che perdono ricordano (1).
Ma anche questa volta il voto di Foggia rimase lettera morta : essa dovè non solo subire, nolente o volente, il novello atto di preferenza già rato e consumato in prò di Lucerà con l’elevazione di quel collegio a liceo, ma non potette scuotere in qualsiasi modo la supina indifferenza di chi non la credette meritevole di un trattamento di giustizia, lasciando tranquille e indisturbate tutte le sezioni del tribunale nella privilegiata sede lucerina. Né valsero premure fatte personalmente dai maggiorenti della città presso Leopoldo, conte di Siracusa e fratello del re, che il tre giugno di quell’anno capitò in Foggia con le sue sorelle, principesse Carolina ed Amalia, restando una notte al palazzo dell’intendenza, e che andava con esse ad imbarcarsi a Manfredonia per Trieste. Né valsero i buoni ufficii presso Ioinville, figlio del fu re di Francia, Luigi Filippo, e della principessa Amalia, sorella di Francesco I, che si trovò di pasaggio anch’ egli per Foggia il diciassette ottobre di quel-l’anno, venendo da Brindisi in forma privata, e che pernottò all’ antico albergo Apicella, per essere Y indomani a Napoli presso Ferdinando II, suo zio.
Lucera, più che Foggia, ebbe anche questa volta forti protettori ; e la ragione del più forte, sventuratamente, è sempre la migliore. Ma la forza, separata dalla giustizia, per quanto ne insegna Tullio, perde il nome di virtù e diventa ferocia. E al mondo, oltre il diritto della forza, oltre questo feroce fatto constatato da Hobbes e invano negato dagl’ idealisti, regna forse altro dritto ? !..
A riparazione, in parte, del torto fatto a Foggia per l’ elevazione del collegio dei gesuiti di Lucera a liceo, solo nel marzo del 1859 le si accordarono, a richiesta del Consesso munici= pale, quattro cattedre universitarie presso il collegio delle scuole pie, l’una di chimica e di storia naturale, che venne affidata al signor Francesco Gabaldi, l’altra di fisiologia e di anatomia comparata al dottor Luigi della Martora, la terza di dritto e di procedura civile all’avvocato Vincenzo Celentano,e l’ultima di dritto e di procedura penale all’avvocato Ferdinando Villani. In seguito, nel settembre dell’istesso anno, le si con-cessero altre tre cattedre, quella cioè di medicina legale e di medicina pratica, che fu affidata al dottor Domenico de Angelis, un’ altra di patologia, di clinica e di ostetricia, per non essersi più attuata quella di chimica e di storia naturale, al dottore Giuseppe Manolla, ed un’altea ancora di dritto romano e patrio all’avvocato Michele Buontempo, mentre veniva, contemporaneamente, ad occupare la cattedra di agricoltura, già esistente da tempo remoto, il dottor Vincenzo Nigri.
E intanto il collegio degli scolopii di Foggia, che pure era stato sì benemerito, come dicemmo, della pubblica educazione, dovè aspettare i tempi nuovi per essere elevato, come quello di Lucera, anch’ esso a liceo. Oh come sempre tarda la giustizia degli uomini !…
XI.
Momento importantissimo per Foggia fu la venuta di Ferdinando II il 10 gennaio 1859 ad occasione del disastrosissimo viaggio intrapreso, e che fu 1′ ultimo, pel matrimonio di Francesco, principe ereditario, con la principessa Maria Sofìa, figliuola di Massimiliano, cugino del re di Baviera e sorella di Elisabetta, imperatrice di Austria, la quale dovea sbarcare a Manfredonia, e che, per la malattia del re, scoppiata in forma fulminea, e letale in quel di Lecce, approdava poscia a Bari.
La città, in pieno movimento di aspettazione, rifa a nuovo le facciate degli edifizii, riatta le sue strade, rizza da per ogni dove pennoni, trofei ed archi di trionfo, allaccia a sé, con fili te-legrafici, Manfredonia e Lucerà, e abbella senza risparmi e con raro senso artistico gli appartamenti al palazzo della dogana, destinato ad ospitare la famiglia reale. Sontuose macchine d’illuminazione vanno costruendosi sulle piazze, macchine dalle foggie fantastiche, architettoniche e dai vividi e smaglianti colori. Una di esse sorge in piazza Portareale in forma di guglia, fatta a spese del ceto dei pastori pugliesi in segno di ringraziamento al re per la cassa di prestanza loro concessa. E su colossali trasparenti si veggono dipinte le immagini dei sovrani con questa roboante epigrafe: A sua Real Maestà — Ferdinando II — Re del Regno delle due Sicilie —-Monarca e padre augusto clementissimo — Foggia — glorificata da un avvento sospirato memorando — colma d’ineffabil gratitudine — l’ omaggio avito di sua devota sudditanza e d’incrollabil fede — tributa reverente. E svariate ulteriori leggende, più o meno scipite, più o meno esagerate, su altri trasparenti variopinti, appaiono come queste: Gloria a Ferdinando II ; — Agli augusti sposi benedizione ; — Col borbonico giglio sia lieta e fiorente la rosa di Baviera ; — Foggia ai suoi sovrani giura fede e riconoscenza. Un apposito comitato, costituito dall’ intendente, sotto la presidenza del sindaco, si agita senza posa da mane a sera perchè il ricevimento e le relative feste riescano solenni. Il direttore del Tavoliere provvede di uniformi sfolgoranti le sue guardie ; il capo-squadrone Della Rocca affascia le guardie! di onore di tutta la provincia e ne fa bella mostra nel capoluogo ; il vescovo Frascolla fa adornare con damaschi e broccati il maggior tempio, ove già in alto giganteggia sull’ altare maggiore la sacra Icone, ed ergesi sul solio vescovile un trono pel re. Ogni angolo della città vedesi popolato di magistrati, di militari di ogni arme, di guardie reali, di funzionari dello Stato, appositamente venuti da tutte parti per lo straordinario avvenimento, mentre e berline reali, e landaus, e cavalli inglesi meravigliosi, e cavallerizzi, e cocchieri e fanti brulicano nel cortile del palazzo dell’ intendenza. Due primarii scenografi arrivano da Napoli, che, per ordine del ministro dell’interno, son destinati a ritrarre su tele i diversi siti dove accederà il sovrano con gli augusti sposi, per farne delle vedute da poliorama. Ed ecco il duca di Serracapriola, commissario del re, e il duca di Laurenzana, con la principessa di Partanna e con la duchessa di S. Cesario, dame di Corte, che vanno in Manfredonia ad imbarcarsi per Trieste, donde condurranno l’ augusta sposa;— ecco i generali Santovito, Statella e Nunziante, il conte Gaetani, il principe Imperiale ; ecco S. A. serenissima il marchese del Vasto, cerimoniere di Corte; ecco mille altri “che precedono il re per fargli onore.
Ferdinando II, incontrato dall’ intendente Guerra, dal comandante delle armi, tenente colonnello Rizzoli e dal direttore del Tavoliere Rossi presso Montaguto, pervenne in Foggia, con la famìglia reale, sulle ventidue ore del già detto 10 gennaio 1859, in mezzo ad una folla plaudente, che gli si accalcava d’intorno, non avendo egli voluto, nel suo ingresso, a fianco della carrozza, né usseri né guardie reali, né guardie di onore, per essere così più da vicino al popolo. Egli entrò da porta Napoli, dove, sotto un arco trionfale grandioso, sormontato da statue, rappresentanti il genio borbonico in atteggiamento di coronare la giustizia e la virtù, si trovarono raccolte le autorità, sei dame foggiane, deputate a servire la regina (1), la commissione pei festeggiamenti, le congreghe di spirito e il clero, con a capo il vescovo Frascolla, cui il re volle baciar la mano, imitato in ciò dalla regina, dai principi e dal seguito. Il corteo, tra il suono delle bande musicali, si diresse alla cattedrale, ove, a pie dello scalone, era pronto un ricco baldacchino dalle aste dorate, sorretto da otto decurioni, sotto cui il re entrò nel tempio, mentre al limitare di esso il Frascolla, infra i vescovi Iannuzzi di Lucera e La Scala di Sansevero, offriva l’ acqua benedetta. Ferdinando prese posto sul trono, mentre la regina, il duca di Calabria, il conte di Trani e il conte di Caserta occuparono delle sedie a bracciuoli, su soffici tappeti, nel presbiterio, cui seguivano i funzionarii di Corte, i vescovi, l’intendente, il sindaco, il Decurionato, i magistrati e tutta F immensa massa di alte personalità civili e militari. Monsignor Frascolla impartì la benedizione, dopo di che si cantò una litania alla Iconavetere, che risplendeva tra fasci di fiammelle a cera, e che il re, ad intervalli, attentamente fissava col suo occhialetto, non essendo potuto riuscire, per la smisurata altezza in cui era collocata, a distinguere il tanto decantatogli miracolo a traverso i sette veli, per lo che mostrò desiderio di trovare, al suo ritorno, il sacro Tavolo smosso più in basso. I reali ridiscesero quindi sulla via, ove aspettavano eleganti equipaggi, e recaronsi al palazzo dell’ intendenza. Quivi il re, acclamato dalla folla, si fece al balcone per ringraziare,. mentre la regina rimase dietro i vetri pel freddo, e il principe ereditario si sollazzava da altro balcone a gittare tari ed a provocare così sulla piazza un pipa-pigia assai ridevole. Di qui a poco furono ricevuti a palazzo tutt’ i principali funzionarii, e, a preferenza, l’ intero Decurionato con il sindaco Vincenzo Celentano. Dopo lungo conversare il re e la r. famiglia si ritirarono nei rispettivi appartamenti, avendo il primo invitati per la sera a pranzo, oltre agli alti personaggi venuti con lui, F intendente, il comandante della provincia, i generali, i vescovi, il sindaco e il capo-squadrone delle guardie di onore. La sera vi furono grandi luminarie per là città e gala al teatro, ove, però, nessuno dei rr. intervenne», Un episodio grottesco destò il buon umore del re, il quale avendo appreso che fosse in Foggia il domenicano monsignor Passero, vescovo di Troia, e, non vedendolo, ne dimandava il motivo dell’assenza. Allora gli si dovette dire che, malauguratamente, il cameriere di monsignore, un distrattone dei più autentici, avea dimenticato di portargli da Troia la mantelletta, senza della quale quegli non avea creduto conveniente di presentargli, e n’era rimasto perciò dolente in casa dei Varo, ove alloggiava. All’ ultim’ ora giunsero Salvatore Murena e Ludovico Bianchini, l’uno ministro delle finanze e l’altro di polizia, nonché la principessa La Scaletta, dama di corte della regina, e il cav. Sanseverino, segretario particolare del re, i quali, a causa di una tormenta di neve per via, erano rimasti molto più indietro alle camozze reali. Il re volle, intanto, che il suo appartamento venisse custodito non già dagli usseri o da altri, ma soltanto dalle guardie di onore. L’indomani, di buon mattino, egli udì la messa con la r. famiglia nell’ oratorio privato dell’ intendenza, messa che fu celebrata dal vescovo Frascolla ; dopo di che volle vedere il sindaco e le deputazioni speciali per ringraziar loro dei sontuoso ed entusiastico ricevimento avuto. S’intrattenne, in oltre, buona pezza coi vescovi di Foggia, di Lucerà e di Sansevero, nonché con quello di Troia, che finalmente era stato messo dal suo domestico in condizione di presentarsi al re, e, a diciassette ore e mezzo, accompagnato dalle autorità e dalle guardie di onore in grande uniforme, Ferdinando partì con la r. famiglia alla volta di Cerignola per essere la sera ad Andria, e di qui poi a Lecce, promettendo di ritornare pel prossimo giorno venti, quando avrebbe festeggiate in Foggia le nozze di suo figlio. II popolo lo acclamò sin fuori l’abitato, fiancheggiandone le carrozze, mentre i più umili non lasciarono di gittargli suppliche e di chiedere grazie.
Ferdinando II, la stessa sera del suo arrivo in Foggia, segnò un decreto con cui volle espandere la sua sovrana clemenza sino a coloro che, per commessa violenza ai precetti di legge, erano stati colpiti da relativa retribuzione di pena, per lo che furono diminuite di quattro anni le condanne ai ferri, e di due anni quelle a pene correzionali; furono condonate le detenzioni e le ammende per contravvenzioni, nonché tutte le pene ai condannati politici, tuttavia ristretti in carcere dopo l’ultima commutazione fatta, tre giorni prima di partire da Caserta, dell’ergastolo e dei ferri a sessantasei di essi i più pericolosi, in esilio perpetuo.
In seguito, mentre a Foggia si aspettava il ritorno del re, siccome questi avea promesso, cominciarono da Lecce a giungere notizie della infermità che ivi lo avea colto, infermità che si disse sempre di lieve momento, presentandola ora con la forma di catarro, ora con quella di reumatica. Intanto il ventitre di gennaio si vide passare per Foggia il medico di corte Pietro Ramaglia, chiamato da Napoli con dispaccio telegrafico; il che mise in tutti un pò d’allarme. Però si continuò a dire che si trattasse di men che nulla, e continuarono a Foggia i preparativi pel ritorno del re, quando, all’ improvviso, sì riesci a sapere che l’itinerario delle feste era radicalmente mutato, perchè Maria Sofia sarebbe sbarcata non più a Manfredonia ma. a.Bari, dove Ferdinando con la r. famiglia si era già recato sul Tasso da Brindisi. Infatti il tre di febbraio tale sbarco verificossi colà, tanto che a Foggia si tennero pure, all’ oggetto, delle dimostrazioni popolari e si cantò in chiesa il Te Deum. Un mistero intanto aleggiava intorno alla infermità del re, e nessuno osava squarciarne le ombre. Un accenno a qualche cosa di anormale fu dato il sedici febbraio dall’ arrivo di S. A. R. il principe Leopoldo, conte di Siracusa, che correva con posta forzata ad abbracciare in Bari suo fratello. Oltre di ciò non seppesi altro di positivo, sino a che l’undici marzo si annunziò d’un colpo che Ferdinando era partito da Bari per Caserta, dove già trovavasi a causa di una recrudescenza reumatica catarrale, e dove si era creduto altresì di somministrargli il viatico. E finalmente, dopo che il principe Imperiale avea compiuto uno special voto del sovrano di condursi in pellegrinaggio per implorare la divina grazia al santuario di s. Michele a Montesantangelo, a quello dell’ Incoronata, al tempio di S.a M.a Patrona di Lucera e all’altro della Iconavetere, la notte del ventitre maggio un laconico telegramma di urgenza, pervenuto all’ intendente Guerra, annunziava la morte del re.
Ferdinando II, dunque, che lord Palmerston disse essere stato non il re più tiranno ma il più stolto, finì per tal modo nell’ età di quarantanove anni e quattro mesi e mezzo, dopo ventinove anni di regno. I suoi sudditi ebbero ad ignorare sino all’ ultim’ ora l’ entità del male e l’avanzarsi precipitoso della catastrofe, sebbene si fosse da taluno, durante il corso della malattia, ciò preveduto con propalare quindi delle fosche notizie, che le autorità cercavano di soffocare financo con arresti. Infatti a Foggia Orazio Sorge e Saverio Tarantino aveano presagita la fine del re; e per un tale presagio, non destituito di verità, si videro costoro, nella notte del ventisei aprile, accalappiati dai gendarmi come due uccelloni di malaugurio.
Ma se non l’ aveano preveduto generalmente i suoi sudditi, bene l’aveano preveduto lo stesso Ferdinando e i suoi familiari. E, per vero, fin dal giorno eh’ egli partì da Caserta, fattosi benedire con l’acqua santa dal suo confessore monsignor Gallo, nell’uscire dalla reggia col suo lungo corteo di vetture, a tre cavalli ciascuna, scorse due frati cappuccini, appoggiati alle mura del quartiere di cavalleria di fronte al portone, sprofondantisi in inchini, e ne tolse pronostico di sventura. Sicché, mentre corrispose per cortesia al saluto, si rivolse conturbato alla regina e le disse in dialetto, così come sempre soleva : « Tere’, che brutto viaggio che facimmo sta vota ». E triste e pensieroso apparve da quel punto lungo la via, resasi ad un tratto impraticabile per fiera burrasca di neve, scatenatasi d’ogni parte, e che mise in pericolo il proseguire oltre. Ma da, Avellino, ove si rimase una notte, si dovette il dì appresso necessariamente far sosta ad Ariano, ove il re arrivò intirizzito a segno ch’ ebbe bisogno di possenti cordiali per risollevarsi dal grave abbattimento e dalla prostrazione in cui era caduto. Accolto nell’episcopio, sentì l’urgenza di andare a letto, facendo rimanere nella camera contigua il suo fedele guardarobiere Gaetano Galizia ; quand’ ecco, a notte fonda, destatosi “di soprassalto, chiamò, impaurito, all’accorr’uomo ; al che il Galizia si precipitò ad entrare nella camera del re, e lo rinvenne con una pistola in pugno e con gli occhi sbarrati mirando nel muro, ove diceva si fosse aperto uno sportello per menarvi fuori un assassino. La cosa era pur troppo inverosimile, ma il Galizia, chiamati a sé i quattro fidi marinai della lancia reale, eh’ erano come una guardia costante del corpo del re, frugò con essi dappertutto, ma nulla vi scoperse, tanto che credette il suo sovrano in preda ad allucinazione, e non più si mosse, con gli altri, tutto il resto della notte dal fianco di lui per tenergli compagnia. In tali condizioni di spirito e di corpo Ferdinando pervenne a Foggia, ove fu preso da brividi di freddo e da dolori nelle ossa, che seppe però ben dissimulare agli occhi della maggioranza con affettata gaiezza. Eppure un qualche scaltro avrebbe potuto con ragione rivolgergli sin d’allora la domanda di Gian Paolo: « Perchè mai tanta tristezza in questi sorrisi?» Peggiorando ancora, nel giorno quattordici raggiunse, dopo altre disastrose tappe, la città di Lecce, ove il sedici, sfinito addirittura di forze, fu costretto a prendere il letto, cominciando a verificarsi sin da quel punto una certa tumefazione alle cosce, cui seguì una rapidissima suppurazione nel!’ inguine, e quindi in tutto il corpo, divenuto poscia, come ‘ per incanto, ricetto di vermi e di putredine. Lo stato suo diventò presto sì grave che telegrafossi in Baviera allo scopo possibilmente di far sospendere, almeno pel momento, la partenza della principessa sposa; ma, non potendosi poi più oltre rimandare, ella fu consegnata a Trieste dall’ imperatrice d’ Austria al commissario del re, duca di Serracapriola, al cavallerizzo maggiore, duca di Laurenzana, alle dame principessa di Partanna e duchessa di s. Cesario, e, sulla fregata napoletana II Fulminante, approdò a Bari, ove a stenti Ferdinando potette farsi trasportare da Lecce. Ma un tal viaggio gli inasprì l’asse cerebro-spinale in modo che vi fu un istante in cui egli perdette totalmente i sensi, e lo si credette morto. Con una navigazione forzata di cinquanta ore fu menato a Resina nel palazzo della Favorita, e di qui, poi, per ferrovia, a Caserta, nella cui reggia entrava, ai primi di marzo, quasi cadavere. Vuoisi che quando a Bari ei fu deposto su di una barella sotto coperta, ebbe ad esclamare, estremamente sconfortato: «Questa è l’anticamera della tomba!…»
La prossima morte, dunque, non potè non prevedersi da lui e da’ suoi intimi sin dal primo dì, in vista del terribile malanno che lo aveva assalito con tanta ferocia ; e, se ciò si tenne scrupolosamente celato ai suoi sudditi, facendo loro credere or si trattasse di affezione reumatico-catarrale, dipendente da’ disagi del viaggio e dalla rigidità della stagione, or di una semplice piaga suppurata di nessun conto e già in via di guarigione , mentre era uno dei più gravi casi di coxalgia con piemia, lo fu, naturalmente, per una certa superstizione, come per non provocare, in qualsivoglia guisa, un allarme in chicchessia e un grave turbamento nell’ ordine pubblico (1).
Toccò al pittore Domenico Caldara, nostro concittadino foggiano artista di gran valore e prediletto di Casa Borbone, il dover ritrarre le sembianze del re sul suo letto di morte per ordine della regina Maria Teresa, che ne lo invitava a mezzo del principe don Sebastiano di Spagna. E, infatti, il 24 maggio 1859 egli venne menato alla camera mortuaria, ove due soldati di marina vegliavano il cadavere, che ad intervalli scoprivano per ripulire, con un pennello impregnato di un disinfettante, le piaghe purulente che ne bruttavano il corpo già in dissoluzione. Caldara ritrasse su tela, a grandezza naturale, il volto del sovrano, composto a calma serena, ma emaciato, appiccolito, quasi deforme. Il ritratto fu compiuto in quattr’ore appena, e di cui Maria Teresa volle fossero eseguile altre dodici piccole copie per donarle ai dignitarii di Corte. Dugento piastre furono pagate per quel ritratto, come ducati ottanta per ciascuna successiva copia di esso; ma sì dell’uno, che delle altre neanche gli avanzi furono trovati poscia mai presso alcuno. In seguito si ordinò allo stesso artista di riprodurre, in
(1) All’ultimora, col Palasciano e col Prudente, fu invitato a consulto anche il nostro concittadino Vincenzo Lanza, sebbene si sia trovato, in sulle prime, difficoltà della Corte ad avvalersi del consiglio di un liberale, da appena tre anni tornato dall’ esilio La regina Maria Teresa, però, pur avendo fatto venire tutti tre i dottori a Caserta, inibì loro di vedere il re, e volle che essi avessero dato il loro parere su di una semplice minzione fatta dal Ramaglia. Il Lanza si dispiacque di ciò non poco, pentendosi di avere, accettato l’invito ; ma, udita la relazione, borbottò con palese ironia : « Il re starà bene, fatelo nutrire di latte di donna». Il dottore Francesco Rosati, uno dei medici punititi, scoppiò dal ridere, al che il Lanza gli disse ; « Innanzi a Vincenzio Lanza (coni «gli stesso chiama vasi, anziché Vincenzo) non si ride. Ferdinando II morirà dopo aver contemplato il suo cadavere ; non e’ è più rimedio : la fitiriasi si svilupperà subito in seguito alla piemia ». E quando ritornò a Napoli, raccontando l’incidente ad amici colleghi, soggiunse : « Io ebbi da lui un passaporto e son ritornato ; ma con quello rilasciatogli da me non vi è speranza di ritorno. »
tela di quattro palmi per quattro e mezzo, gli ultimi istanti di vita del re; ed egli eseguì il lavoro riconducendosi alla regia di Caserta e giovandosi altresì di una fotografia della camera mortuaria allora già disfatta. Ferdinando è raffigurato nel suo letto di morte, avente da un lato monsignor Gallo, intento a pregare per lui, e dall’altro Maria Teresa, ginocchioni e languente, con un crocifisso di avorio stretto tra mano. Quest’altro dipinto, pel quale il nostro valentissimo concittadino intascò il premio di duemilaseicento ducati, nemmeno si è saputo mai dove sia andato a finire. Esiste forse tuttora o venne distrutto? e da chi? e quando?… Solo la fotografia di esso, insieme a quella della camera mortuaria, si conserva dalla famiglia Caldara in Napoli, e che io stesso un dì ebbi occasione di vedere.
A Foggia la istantanea notizia della morte di Ferdinando produsse in ogni ceto un’impressione enorme; ma anche qui, come a Napoli, come in tutto il regno ben’ ebbe a rifarsi in mille punti la comica scena manzoniana di don Abbondio nell’ apprendere da Renzo Tramaglino la morte di don Rodrigo. La si credeva inverosimile, falsa, quasi impossibile, tant’era, nell’intimo, agognata; però quando il sagrestano ne riconfermava la notizia, confortandola con dati precisi e ineluttabili da togliere via ogni dubbio dall’animo: « Ah è morto dunque?! è proprio andato ? » esclamò quasi fuori di sé dalla gioia il timido curato ; « vedete, figliuoli, se la Provvidenza arriva alla fine certa gente ! Sapete che l’è una gran cosa, un gran respiro per questo povero paese! Che non si poteva vivere con costui !…».
E, il ventitre di maggio, nella chiesa cattedrale foggiana gli si fecero sontuosi funerali, senza che una lagrima spuntasse sul ciglio di alcuno degli stessi suoi fidi, mentre già prestavasi, ad un tempo, dalle truppe e dai funzionarii giuramento al troppo giovane e novello re Francesco II
Morto il re, viva il re!
XII.
Francesco II, consigliato a seguire una politica di conciliazione, non appena salito sul trono, emise il 16 giugno ’59 quel pomposo decreto di completa amnistia per tutt’i reati politici, riguardanti il perioda dal 1848 al 1849, abolendo ad un tempo le famose liste degli attendibili, oggetto di censure e di sarcasmi di tutta Europa. Potevano questi finalmente avere, d’ora innanzi, le carte itineràrie e le fedi per esami dottorali, che prima non potevano ottenere, nonché concorrere per ogni pubblico ufficio; e gl’insegnanti potevano riaprire i loro studii privati; e gli uomini di affari prender parte novellamente ai pubblici incanti; e tutti, tutti potevano allontanarsi dalla propria residenza senza chiedere più permesso a chicchessia. Ma un momento dopo ei ne parve quasi pentito, giac¬ché ordinava al direttore generale della polizia, Franeeseantonio Casella, d’inviare immediatamente una circolare «affinchè s’invigilassero gli uomini veramente pericolosi », con l’aggiunta proposta, dal Troya, per mitigarne la cattiva impressione: «sieno stati o non nelle liste degli attendibili ». Per tale amnistia molte famiglie foggiane, che sino allora aveano versate copiose lagrime sulla sorte miserrima dei loro cari, perseguitati in ogni guisa dalla polizia e condannati alle patrie galere, potettero emettere alfine il più gran respiro, sollevando i loro animi al pensiero di presto rivederseli accanto.
Il suddetto direttore generale, intanto, con telegramma del ventitre luglio, ordinava all’ intendente Guerra di festeggiare in Foggia l’avvento di Francesco nei giorni 24, 25-e 26 dello stesso mese, quando del pari lo si sarebbe fatto in Napoli. Ciò venne puntualmente eseguito dalle autorità civili, militari ed ecclesiastiche, ma con la completa assenza di entusiasmo da parte del popolo foggiano, che non ebbe né il tempo, né la calma, né una ragione qualsiasi per manifestare, cognita causa, i proprii sentimenti.
Il nuovo re volle quindi propiziarsi le simpatie dei foggiani, e nel quattro di ottobre di quell’anno concesse parecchie decorazioni a coloro che avevano festeggiato suo padre, allorché l’ultima volta, il dieci di gennaio, era venuto in Foggia per la occasione delle sue nozze con Maria Sofia di Baviera. Per lo che l’intendente Guerra fu fatto commendatore dell’Ordine di Francesco I, e il sindaco Vincenzo Celentano, cavaliere costantiniano di grazia. Furono fatti altresì cavalieri di seconda classe dell’Ordine di Francesco I i componenti il comitato pel ricevimento e per le feste, cioè i signori: marchese Pietro de Luca, allora consigliere d’intendenza, Giuseppe della Rocca, anche consigliere d’intendenza in Soprannumero, Pasquale Saggese, Domenico Frascolla, Raffaele Nannarone, Giacomo Celentano, Giovanni Barone di Gaetano e Lorenzo Scillitani, rimanendone però esclusi, chissà per quale motivo, Pasquale Scoccherà e Giuseppe Buonfìglio, altri due componenti del comitato medesimo. E si ebbero del pari la stessa croce di cavaliere di seconda classe dell’Ordine di Francesco T Gaetano della Rocca, capo-squadrone delle guardie di onore, pel servizio prestato da queste presso la r. dimora, nonché Francesco Paolo Siniscalco ed Antonio Vaccarella, per avere, il primo, ospitato nella propria casa il generale Giovanni Statella, e, il secondo, il generale Alessandro Nunziante.
Ma, ad onta delle amnistie promulgate e delle croci che mandava dispensando come scapolari, peggio che non si faccia oggidì per ragioni elettorali o per altre più meschine e inconfessabili ragioni, Francesco II fu vociato imbecille dal primo dì che saliva sul trono delle due Sicilie, e non ebbe un’ora di favore né presso il popolo, né presso la stessa Corte, ove, oltre alla cospirazione orditasi da suo zio Luigi, conte di Aquila, che covava il pensiero di divenire reggente del giovane re, precipitò gli avvenimenti e rese assai più facile la caduta della borbonica dinastia la congiura riattivatasi dalla regina madre Maria Teresa per porre sul trono, in cambio del ventenne figliastro, il suo figliuolo Luigi, conte di Trani. Costei, che era riuscita a guadagnarsi in Corte la più grande influenza, distruggendo addirittura quella di suo cognato Leopoldo, conte di Siracusa, divenuto presso di tutti ormai un essere inascoltato e deriso per lasciare non garentito l’inesperto Francesco, si dedicò con ogni possa a questa specie di reazione di palazzo contro costui, mentre reggeva la presidenza del Consiglio dei ministri il generale Carlo Filangieri, designato a Francesco II da suo padre morente, come colui cui soltanto do¬vesse in momenti diffìcili affidarsi. E cominciò, quindi, Maria Teresa a mandare emissarii specialmente a Foggia, dove avea molta gente fedelissima alla sua causa, e che prescelse a centro della rivolta soprattutto, come diceasi non so con quanta base, perchè patria dello scolopio Niccolò Borrelli, precettore del re, e dove surse presto un comitato, dopo i relativi accordi presi col famoso Nicola Merenda, vecchio arnese di polizia, venuto appositamente a intorbidare le acque per conto di lei. E questo comitato, abbastanza movimentato, cui si erano affiliati molti gentiluomini del paese e della provincia col tacito assenso, vuoisi, dello stesso intendente e del vescovo, si riuniva indisturbato dalla polizia tutte le sere sino a notte fonda, e dove spesso fu gridato : « viva Luigi I ». Il così detto partito della regina-madre avea molteplici tentacoli e diramazioni nelle tre Puglie, come ovunque; esso era aiutato da una camarilla assai in fluente : da monsignor Gallo, potentissimo specialmente in quel di Bovino, da qualche generale e da parecchi altri vescovi, tra’ quali i più accentuati si mostrarono monsignor Matarazzo di Bitonto, monsignor Pedicini di Bari, monsignor Iannuzzi di Lucerà, monsignor Longobardi di Andria, monsignor Apuzzo di Sorrento, monsignor d’Avanzo di Castellaneta, il p. Paradiso, rettore del collegio dei gesuiti di Lucerà, e qualche frate di s. Giovanni di Dio di Foggia, che facea da messaggiero tra’ diversi cospiratori della Capitanata.
Uno dei componenti più autorevoli, fattivi ed energici del comitato per Luigi era il marchese Lorenzo Filiasi, il quale un bel dì fu inviato a Napoli dai compagni di congiura per prendere accordi precisi con la regina-madre intorno al modo ed all’epoca dell’insurrezione, essendo a Foggia tutto pronto per la buona riuscita della cosa. Egli però era nel falso convincimento che a parte della congiura fosse lo stesso presidente del Consiglio, generale Filangieri; sicché, essendo con lui in buone relazioni di amicizia, gliene parlò nei primi giorni del settembre. Ma il Filangieri, che nulla per lo innanzi avea trapelato della brutta trama che si ordiva a danno del re, credette suo dovere di avvisamelo. Non lo avesse mai fatto, che il bonario Francesco, senza approfondire il fatto e cercare di sventarlo direttamente con mezzi energici, preferì parlarne accademicamente, come di volgare calunnia, alla regina-madre, che considerava per sé buona ed affettuosa, come ebbe a ripetere allora, pure una volta, al suo primo ministro, con la frase : « È la moglie di mio padre ! » Alla quale rivelazione Maria Teresa, furba insino al midollo, finse di sciogliersi in lagrime e di protestare fortemente contro i suoi facinorosi nemici e calunniatori, ma, l’indomani, imbattutosi nel palazzo col Filangieri, che profondamente odiava, si vendicò di lui e lo punì dell’azione commessa chiudendogli violentemente l’uscio sul muso, come vuole taluno, o addirittura sputandogli sul viso, come altri sostiene. Per la qual cosa da quel giorno cinque settembre costui si disse infermo e si allontanò dalla direzione dello Stato, di cui non volle più riprendere le redini, rivolgendo al conte di Siracusa quelle famose parole, che furono come un testamento ed un presagio : « Poiché i miei consigli non sono stati né graditi, né accettati, lascio al altri l’amaro uffizio di fare da becchino alla dinastia, che da me si voleva a tempo salvare, e che non l’ho potuto per l’ostinazione di chi avrebbe dovuto comprendere il mio sincero proposito: è brutto fare il Pilato in politica. Iddio a questo mi ha condannato».
Assunto in prosieguo alla direzione della polizia generale Luigi Aiossa, che si compiacque di rinnovare nel regno i fasti del Peccheneda e del Mazza, non poteva non andar ricordato il fallito tentativo del principe Luigi e di Maria Teresa, e quindi i nomi specialmente dei funzionarli sospettati di aver preso parte allora nella cospirazione contro Francesco. Fra questi non isfuggì all’ Aiossa il nome di Raffaele Guerra, il quale, per conseguenza, avendo perduta ogni fiducia presso il re e il Ministero per avere, per lo meno, col semplice nicchiare favorita quella congiura, fu, il ventiquattro dicembre di quell’ anno, messo a ritiro con la metà del soldo. E, come sempre avviene per despoti spodestati, Raffaele Guerra il giorno della sua partenza da Foggia, che avveniva il 29 dicembre ’59, non trovò anima viva al suo fianco, e mosse quindi alla volta di Napoli solo col corriere postale, accompagnato, più per convenienza che per attaccamento, dal direttore del Tavoliere cav. Filippo De Rossi e dal segretario della Beneficenza Tito Mola sino alla real tenuta di s.a Cecilia, a poche miglia lontano dalla città. Con la sparizione di lui ben può dirsi si sia chiuso per Foggia il periodo più orroroso di slealtà, di menzogne e d’ipocrisia.
Nominato a successore del Guerra Bernardo Sanfelice, duca di Bagnoli, questi giunse da Napoli a Foggia il dì 11 di gen-gaio ’60, e, ricevuto fuori V abitato dalle autorità e da’ migliori cittadini con ben trenta carrozze private, fece il suo ingresso nel capoluogo tra una folla rispettosa, recandosi difi¬lato alla cattedrale, per dare così il suo primo saluto alla grande protettrice della sua nuova residenza. E qui vuole la tradizione che, durante i pochi istanti eh’ ei vi rimase per farvi orazione, i famosi cappelli dei due vescovi defunti, monsignor Santulli e monsignor De Sangro, penzolanti dall’alto del cornicione, presero ad agitarsi, rinnovando così alla presenza di lui il consueto prodigio che, a quanto si dice, avverasi spesso in quel santuario. E vi ritornò il giorno sedici successivo, nella occasione del genetliaco del re, in tutto il fastigio e la pompa che gli venivano dal suo grado, nonché dalla qualità di gentiluomo di camera, di cui indossava la smagliante uniforme, con chiave d’oro e col petto ricoperto di molteplici decorazioni, oltre la fascia dell’ Ordine di Russia.
E, al sacro mescendo il profano, il duca di Bagnoli, a conoscere intera la società foggiana, la sera del diciannove febbraio, come prima eccezione alla regola severissima mantenutasi fino allora nel san Graal del palazzo dell’intendenza, dette un gran ballo.
Uno dei suoi primi atti amministrativi fu la proposta di Alessio Barone a nuovo sindaco di Foggia, in sostituzione di Vincenzo Celentano, il quale fin dall’ultimo dicembre era stato nominato consigliere d’intendenza. Sicché il Barone, nel giorno 2 marzo ’60, prese possesso per la seconda volta dell’ alta carica di primo magistrato della città. E lo stesso intendente inaugurò quindi la nuova sessione del Consiglio provinciale di Capitanata, presieduta dal duca di Bovino, con un discorso pregno di promesse e di speranze per 1′ avvenire della provincia, mercè i soliti paroloni, destinati a far nuli’ altro che un pò di frastuono, peggio che quattro noci rinchiuse in un sacco. Ma, in fondo in fondo, anche ad avere tutta la buona volontà di questo mondo, che cosa avrebbe potuto egli fare in prò dei suoi amministrati, i quali, per altro, aveano perduta ogni fede non solo negli amministratori locali, ma negli stessi governanti ? Costoro — lo avean visto ormai anche i ciechi — erano venuti sempre meno ai loro impegni, ed ora specialmente niun prestigio potevano più esercitare, stantechè le sorti del regno andavano a precipizio, e non passava giorno che non cadesse una pietra dal pericolante edilìzio dello Stato. –
Ritiratosi il Filangieri dalla presidenza del Ministero, vi era asceso Antonio Statella, principe di Cassare Costui po¬teva vantare la sola gloria di avere, venti anni innanzi, non secondata la volontà di Ferdinando nella questione degli zolfi — con l’Inghilterra, e di avere riportata perciò la pena della relegazione a Foggia, ma, ottuagenario qual’era ormai e senza autorità, non era certo adatto a reggere le sorti dello Stato in momenti sì difficili, tra le esorbitanze poliziesche dell’ Aiossa da un lato, le mene instancabili dei clericali dall’altro, e l’ardore, per ultimo, crescente dei liberali che avean ripreso a ragione ogni lena e coraggio. La corsa alla dissoluzione era fatale : dal 4 aprile al 7 settembre 1860 gli avvenimenti si svolsero senza posa come tanti anelli di una catena che si aprono e si disfanno l’un dopo l’altro in forza di una legge chimica di decomposizione. Non vi era colpo di mano, non vi era espediente che potesse arginare l’irrompere della catastrofe Dal convento della Gancia, in Palermo, ove si era combattuta la prima santa battaglia nel nome d’Italia, all’uscita di Francesco II da Napoli, e quindi alle lotte sanguinose del Volturno e del Garigliano, alla presa di Gaeta e di Messina, e poscia al brigantaggio, che, come ben fu detto, disonorò la caduta di quel principe e rifermò le maledizioni della civiltà sulla sua stirpe, si può dire sia stato un unico e solo periodo evolu¬ivo che non si poteva arrestare, l ultimo atto cioè del dramma della dinastia borbonica, destinata a finire, in omaggio alla umanità, nel reame di Napoli. Onde a ragione scagliava Victor Hugo il suo terribile grido, come voce inesorabile del destino: « 0 despoti, io vi sfido ! fermate la pietra che cade, fermate il torrente, fermate la valanga, fermate l’Italia, fermateli mondo, precipitato da Dio nella luce !…. »
Che se a Napoli, da una parte, dopo i fatti di Palermo, sperava tuttavia un ispettore di polizia, il famoso Sbordone, di soffocare gli entusiasmi dei cittadini col regalare bastonate a dritta ed a manca per le vie, a capo di una sbirraglia, e di arrestare quanti gli capitassero tra’ i piedi, e, dall’ altra, un qualche ministro, più accorto e generoso, cercava di mitigare, come poteva, l’ira universale, tentando ora cataplasmi di blandizie, ora quelli di favori, senza guadagnarsi per questo la gratitudine di chicchessia, così a Foggia del pari se, da una parte, il commissario di polizia Flavio Chiarini osò di esercitare tut-tavia il sic volo, sic iubeo sulle più innocenti manifestazioni del pubblico, invadendo con la gendarmeria, nella sera del 11 maggio ’60, la platea dei teatro Ferdfinando, e arrestando, con generale disgusto, quanti erano indistintamente colà, e che avevano applaudito o fischiato un po’ vivacemente la nuova opera I Pirati Spagnuoli del M.° Petrella, dall’ altra, inutilmente il duca di Bagnoli sperò di produrre l’ impressione contraria con l’intervenire di persona a scarcerarli, rimproverandone aspramente quel funzionario e facendolo dopo undici giorni traslocare in punizione da Foggia a Bari. Il paese era stanco di promesse e di manchevolezze, di giuramenti e di spergiuri : tutto era considerato come una montatura o un trucco per riguadagnare alla dinastia borbonica quel favore che ormai avea totalmente perduto anche da parte degl’indifferenti e fin dei suoi fedeli. Lo sbarco dei Mille a Marsala, la loro marcia audace e trionfale su Salemi, su Alcamo, su Monreale, su Rampagallo, la rapida conversione su Palermo, l’ entrata di Garibaldi nella città dei Vespri eran fatti codesti che non potevano certo tenersi celati, né potevano distruggere la enor¬me impressione che veniva a produrre sulle masse del continente. E su quelle foggiane, in ispezie, non potevano esse non esercitare un’ influenza maggiore, perchè tra la generosa e trion-fatrice falange dei Mille trovavasi puranche uno dei suoi figliuoli prediletti, Moisè Maldacea, uomo di provata fede liberale, che, nei tristi giorni delle cospirazioni, era stato dal Borbone dannato al capestro, e che poscia, sotto la divisa di cacciatore delle Alpi, battutosi da forte a Varese nel 1859, era caduto ferito a Calatafimini il 15 maggio 1860, dopo di che lo si era visto riapparire, di lì a poco, quasi leone indomito, a Milazzo, come, più giù, tra i più ardimentosi combattenti, lo si vide al Volturno (1).
(1) Il Maldacea ebbe a meritare le speciali simpatie del generale Garibaldi ; e allorquando venne ferito a Calatafìmi, questi ebbe cura di farlo trasportare con ogni riguardo nel vicino paesello di Vita, ove era stato improvvisato pei garibaldini un ospedale In un convento. Nacque a Foggia da Vincenzo Maldacea nell’anno 1822; e, quando dalle falangi garibaldine passò nell’ esercito, quivi rimase sino a che ebbe ad assurgere al posto di tenente-colonnello, col quale grado si ritirò, pensionato, a vita privata. D’allora prese domicilio a Bari, ove occupò parecchie cariche gratuite ed onorifiche, e dove mori in tarda età, circondato dal pubblico rimpianto, pari al rispetto ed alla stima profonda che aveva per lo innanzi colà meritata. Il mio amicissimo grande ufficiale Ernesto Della Torre, valoroso superstite anch’egli dei Mille, ricorda tuttavia con profonda ammirazione questo suo pugnace commilitone, pel quale E. E. Ximenes, direttore del Museo e dell’Archivio storico dei Mille in Bologna, deplorava testé, con ragione, in una lettera al preildenta dell’Associazione delle patrie battaglie in Foggia, l’ingiustificato oblio da parte della sua città natale.
Il fermento era immenso ; la caduta dei Borboni era inevitabile, e la si aspettava da un momento all’ altro. Non valevano quindi più né repressioni, né facilitazioni : le prime aumentavano il disdegno, le seconde provocavano il riso.
Che se la polizia a Foggia, il dodici di giugno, in un accesso irrefrenabile e selvaggio di necrofobia, volle arrestare il noto Luigi De Noia perchè, propalando le notizie della rivolta di Sicilia e delle vittorie garibaldine, aveva incitati gli operai ad una manifestazione di gioia, e lo si mandò a Lucerà con forte scorta di dragoni in mezzo a delinquenti comuni, essa indignò maggiormente le masse, eh’ erano già vigili per accogliere anche tra loro, come i fratelli siciliani, il liberatore. Invano pattuglie di dragoni giravano a cavallo notte e dì per le vie di Foggia onde evitare qualsiasi tumulto; invano il comandante della provincia teneva consegnate le truppe nei quartieri ed avea messe in sull’ avviso le stesse guardie di onore e la gendarmeria, pronte ad accorrere a qualsivoglia movimento di piazza, che la rivoluzione in modo latente avanzavasi a passi giganti. Essa sfidava ogni ulteriore e stupida precauzione di sgherri o di pretoriani, e non cedeva d’un passo innanzi alla valanga degli ordinamenti liberali che la zecca legislativa del Ministero Spinelli, surto col famoso Atto sovrano del 25 giugno 1860, datato da Portici e con cui Francesco II concedeva in articulo mortis la Costituzione, vomitò dal luglio all’ agosto consecutivo per galvanizzare il reame del Borbone, diventato già cadavere putrefatto.
Invero, più che male accoglienza, il disprezzo addirittura meritò questo subitaneo cangiar di tattica di Francesco per vedersi mancare all’ ultim’ ora il terreno sotto i piedi. Qualunque promessa di benefìcio facea sorridere di pietà, perchè il giuramento di Casa Borbone era sempre fatto con le labbra, ma non con la coscienza, era una restrizione mentale, era un falso giuramento, coverto da un cappello di santità, ragion per cui essa guadagnossi dalla storia il nomignolo orroroso di dinastia spergiura.
Alle quattro pomeridiane del ventisei giugno pervenne al duca di Bagnoli un dispaccio telegrafico dal ministro di polizia e, contemporaneamente, altro consimile dal generale comandante territoriale di Bari, coi quali gli si partecipava la reale concessione avvenuta degli Ordini costituzionali e rap presentativi nel regno ; talché, dopo un’ ora, tutta la città fu tappezzata di lunghi fogli a stampa, su cui si leggeva :
Intendenza della Provincia di Capitanata
Essendosi S. M. il Re N. S. degnato di accordare degli Ordini costituzionali e rappresentativi nel regno, l’intendente della provincia, nel darsi la premura di pubblicare questo atto di sovrana munificenza, annunziata or ora per telegrafo, vive sicuro che si accoglierà con rispettosa riconoscenza e pieno di fiducia nella somma bontà che da ognuno si è dimostrato verso di lui da che ha l’ onore di amministrare questa provincia, e ritiene che tutti si rimarranno tranquilli in attenzione di conoscere le precise sovrane concessioni, tosto che ne giungerà la comunicazione.
Foggia, 26 giugno 1860.
L’Intendente
Duca di Bagnoli.
I foggiani si soffermavano, or qua or là, per apprendere il verbo ducale ; in ognuno, non appena appagata la sua curiosità, si allontanava con la massima indifferenza e senza far comenti, quasi come se la cosa non lo riguardasse per nulla.
E il dì appresso l’ istesso intendente fu sollecito render noto originalmente l’Atto sovrano alla cittadinanza con una nuova affissione, che suonava così :
Intendenza della Provincia di Capitanata,
La Maestà Sua, con Atto sovrano, datato in Portici il 25 giugno corrente, ha dichiarato quanto segue :
« Desiderando di dare ai nostri BENEAMATI SUDDITI un attestato della nostra sovrana benevolenza, ci siamo determinati di concedere gli Ordini costituzionali e rappresentativi nel regno, in armonia coi principi italiani e nazionali, in modo da garentire la sicurezza e prosperità in avvenire e stringere sempre più i legami che ci uniscono al popolo, che la Provvidenza ci ha chiamato a governare. A questo oggetto siamo venuti nelle seguenti determinazioni :
« 1.° Accordiamo una generale amnistia per tutt’i reati politici sino a questo giorno ;
« 2.° Abbiamo incaricato il commendatore D. Antonio Spinelli della formazione di un nuovo Ministero, il quale compilerà nel più breve termine possibile gli articoli dello Statuto sulle basi delle istituzioni rappresentative italiane e nazionali.
« 3.° Sarà stabilito con S. M. il re di Sardegna un accordo per gli interessi comuni delle due Corone in Italia
« 4.° La nostra bandiera sarà da ora innanzi fregiata dei colori nazionali italiani a tre fasce verticali, conservando sempre nel mezzo le armi della nostra dinastia.
« 5.° Quanto alla Sicilia accorderemo analoghe istituzioni rappresentative, che possano soddisfare i bisogni dell’ isola, ed uno dei principi della nostra r. Casa ne sarà il nostro vice-re.
« Portici, 25 giugno 1860.
Francesco. »
L’intendente, pieno di ammirazione per la docilità degli abitanti di questa provincia, vive sicuro che scorgendo essi sempre più assicurata la pace e V accordo italiano, tutti si riuniranno intorno al real trono del nostro re con i sentimenti di devozione e di riconoscenza, e fruiranno delle concessioni sovrane con la maggiore moderazione per mostrarci degni e meritevoli di goderle.
Foggia, 21 giugno 1860.
L’Intendente
Duca di Bagnoli.
La stessa glaciale indifferenza del giorno prima mostrarono i beneamati sudditi foggiani alla lettura dell’Atto sovrano; sicché T intendente, che credeva di poter sortire un effetto favorevole ed entusiastico con tale comunicato, dovette in cuor suo rinunziare alla soddisfazione di poter riferire al ministro la spontanea manifestazione di esultanza da parte del popolo, e. accontentarsi invece d’indire pel tre luglio una manifestazione, per contrario, ufficiale e di convenienza rituale, col fare indossare ai militari la grande uniforme e con ordinare le luminarie ai pubblici edifizii (!). Che anzi ebbe a soffrire una delusione maggiore quando, per posta interna, ricevette una lettera anonima, con la quale gli si diceva « che si fosse preparato a partire, se non voleva essere sagrificato », mentre un cartello, anch’ esso anonimo, attaccato di notte tempo da mano ignota sul prospetto del palazzo dell’ intendenza, eccitava il popolo foggiano a rispondere degnamente con le barricate alla quarta concessione della Costituzione, elargita con falso giuramento d’ onore da Casa Borbone, prima che il quarto spergiuro si avverasse. E la gendarmeria fu sollecita di lacerare, non appena scoperto, 1′ audace scritto, mentre gli eunuchi più in voga corsero a lenire F acerba doglia del minacciato duca.
Invano il ministro Giacomo de Martino, che aveva l’ interim del dicastero dei lavori pubblici, essendo il marchese Augusto La Greca, titolare, in missione a Parigi, invano, dicevo, sottoscrisse un contratto di concessione al Delahante di una strada ferrata dal Tronto a Taranto, e che avrebbe solleticato i pugliesi, passando per Foggia, con derivazione per Barletta, Bari, Brindisi, Lecce ed Otranto. A Foggia si rise anche di ciò, vedendosi in febbrile attività perfino la zecca delle decretazioni e delle concessioni, quasi che non vi fosse più tempo a prodigarle in vantaggio vero dei sudditi, che solo allora riconoscevansi degni di andar trattati come uomini, mentre, tenuti per lo passato in conto di peggio che bestie, si era preferito con compiacenza di lasciarli a gemere nella schiavitù e nella fame. Avrebbesi dovuto invece prevedere in tempo lo scoppio feroce della tempesta, quando cioè il cielo fosse stato ancora sereno, e solo allora prepararsi possibilmente a scongiurarne i tristi effetti. Le dighe all’ Adige, al Po, alla Senna non si fanno certamente quand’ essi, già rigonfii, abbiano raggiunto ed oltrepassato il segno di guardia. Come Laocoonte, addivenuto cieco per aver troppo veduto, tutti gli uomini di buon senso, rimanendo immoti innanzi alla valanga di promesse e di concessioni dell’ultim’ora, avevano ben ragione di ripetere che la vicenda dei fatti da essi veduti e dei continui disinganni provati li ammaestrava della loro cecità. L’ energia del peccato forse piace talvolta più di quest’ onestà in extremis, che arresta le anime quando già hanno guardato il fondo nell’ abisso. Che se si dovessero da noi creare i tre regni d’oltretomba, daremmo il paradiso all’ onestà pura, il purgatorio al peccato deciso, e l’inferno a queste coscienze trepidanti e meschine, che rasentano il peccato e non vi si tuffano entro sol per paura di restarvi inghiottiti.
La Sicilia, infatti, era già tutta in fiamme, e con la capitolazione di Milazzo Giuseppe Garibaldi si rese padrone di ogni angolo dell’isola, che le truppe regie non seppero difendere, arrivando sempre tardi, per contrapporsi alle rapide mosse del nemico. Quivi potea dirsi ormai finita la guerra guerreggiata contro il Borbone, guerra che s’iniziava, intanto, in modo ancora più vertiginoso sul continente e col più grande spavento e terrore di re Francesco. Il quale manda invano, nel dodici di luglio, il Manna ed il Winspeare a Torino per domandare, come ultima ratio, un’ alleanza col sovrano del Piemonte, e il marchese La Greca a Parigi per implorare pure una volta la protezione di Luigi Napoleone.
Ruit hora ! L’ eroe di Caprera già accingevasi a toccare con i suoi prodi le terre di Calabria, quando il generale Nunziante si ribellava al suo signore con la famosa dichiarazione d’italianità e di dedizione, che tutti sanno, persuaso che la dinastia borbonica «non poteva essere più sostenuta onestamente da chiunque sentiva di avere una patria ad amare e rispettare ». A questo colpo di grazia che i più fidi, diventando fedigrafì, davano, pel crollo inevitabile ed ornai potenzialmente avvenuto, alla Casa regnante, il torrente della rivoluzione doveva irrompere per necessità ovunque, come irruppe con impeto devastatore, senza che più alcuno, come dicemmo, avesse i mezzi e la forza di frenarne il cammino.
A Foggia Filippo De Rossi, direttore del Tavoliere, che fin dal momento dell’anonimo al Bagnoli aveva subodorato 1′ avvicinarsi della bufera, nella notte del tre di luglio pigliò il largo e si allontanò frettolosamente dalla residenza per la volta di Napoli. Dopo cinque giorni lo imitava il sindaco Alessio Barone, che si partì anch’ egli con l’intera famiglia per la capitale col pretesto di avere colà una delle sue figlie inferma nell’educandato di s. Marcellino, ed il Decurionato, avendo presto proceduto, su invito dell’ intendente, ad una novella terna nelle persone di Saverio Salerni, marchese di Rose, di
Gaetano Postiglione e di Giacomo Celentano, venne surrogato dal primo di essi, che ne fu il prescelto. Lo stesso vescovo Frascolla si vide a mal partito, perchè i preti cominciarono a buccinare qualcosa sul suo conto, ond’ egli, rizelatosene, volle punirli col sospendere a divinis Antonio Carone, rettore deità» congregazione del Carmine, e il sacerdote Antonio Varraqeni nonché con l’ esiliare l’ altro sacerdote Michele Meola. Ma il rigido provvedimento spiacque a tutto il clero e a non pochi cittadini, sicché la sera del nove di luglio» prima dell’ avemmaria monsignor Frascolla credette prudente consiglio, anche a parere dell’intendente, di lasciar Foggia, recandosi a Lucerà, e di qui a S. Marco in Lamis. E tre giorni dopo la sua partenza, il mattino del quattordici, fu rinvenuto il suo stemma gentilizio, ch’era collocato sull’arco del portone dell’episcopio, in via s. Domenico, bruttato in nero e del tutto cancellato, così come contemporaneamente trovossi lo stemma del commissariato di polizia. L’intendente, esasperatosi di ciò, ordinava che si riattassero tutti due gli stemmi, e, fattili riporre al loro posto, vi mise a guardia i gendarmi per evitare che nelle notti susseguenti si ripetesse lo sfregio.
Ma anche per lo stesso duca di Bagnoli cominciò iL periodo delle disgrazie. Fu preso, infatti, da terrore quando seppi il dodici di luglio che, nelle acque di Sicilia, Garibaldi avea catturato un vascello, faciente parte della flottiglia napoletana, su cui trovavasi imbarcato un suo figliuolo, impiegato nella marina militare. Egli ignorava quale sorte gli fosse toccala nello scontro ; ma, dopo molte e molte ore di trepidazione, dorante le quali aveva telegrafato a parenti e ad amici per sete di notizie, riesci finalmente a sapere che il suo Cesare era illeso, ma prigioniero con tutto l’equipaggio. Ne rimase scosso oltremodo, pur sapendolo salvo, tanto che da quel momento si mostrò sempre preoccupato e distratto, anzi parve non fosse più energico e risoluto, come prima, nel disimpegno del suo ufficio. 1 liberali ne approfittarono, cominciando a guadagnarne la volontà ; ed ottennero così da lui, nel diciotto di luglio, il traslocamento del loro concittadino e cancelliere della polissi» Giuseppe Musei, nonché la promessa di eguale trattamento per il segretario della Camera consultiva di commercio Francesco Della Martora.
VILLANI — Cronistoria di Foggia
Il Decurionato, intanto, fu chiamato a far le terne degli uffiziali per la nuova guardia nazionale, che comunicò all’intendente nello stesso diciotto di luglio, due giorni prima che quella riprendesse, come riprese, il suo servizio negli antichi locali sotto il palazzo dell’ intendenza. Ma, allora pervenuto altro decreto, col quale, si ordinava una variante tanto nel numero, quanto nei limiti di età, aumentandosi di altri cento militi il contingente di Foggia, che rimaneva quindi fissato a quattrocento uomini, e mutandosi l’età stabilita di anni trenta a cinquantacinque in quella di venticinque a cinquantacinque, vennero,, il ventidue di luglio, suppletivamente proposti dal Decurionato un quarto capo-compagnia, tre capi-plotoni e quattro capi-sezione.
Lo stesso Decurionato procedeva, inoltre, alla nomina della Giunta, voluta dal recente Statuto costituzionale, per preparare le liste elettorali e le elezioni dei deputati, prescegliendo dal suo seno quattro decurioni.
11 comitato centrale dell’ Ordine di Napoli avea da buona pezza spediti i suoi emissarii nelle Calabrie, nel Salernitano, nell’Avellinese e nelle Puglie per suscitare concorde e simultanea agitazione nelle provincie; ma, col ritorno degli esuli, ebbe esso, come tutti sanno, a subire delle modificazioni per discrepanza di criterii tra’ i suoi componenti. Il comitato dovette dividersi perciò in due; l’uno, appellato dell’ Ordirle, rimase sotto la presidenza del marchese d’ Afflitto e con la sua sede in casa di Andrea Colonna, l’altro, chiamato di Azione, si formò sotto la presi-denza dell’ illustre foggiano Giuseppe Ricciardi. Questi due comitati dell’ Ordine e di Azione differivano tra loro non nella finalità, ch’era la stessa, cioè la fusione del regno di Napoli con quello di tutta Italia, ma intorno al momento della esplosione. Il primo —e mi servo delle parole di Niccola Nisco, che ne fu testimone oculare — voleva la insurrezione subitola fine di obbligare il re ad andarsene per opera del -popolo senza lo intervento garibaldino, onde si potesse sostenere nel campo diplomatico {l’adesione all’unità voluta nel Napoletano, non imposta. Il secondo si affaticava a ritardarla, bramoso sopra ogni cosa ch’essa avvenisse soltanto per mezzo di colui che era capitano del popolo armato, e che doveva, cacciando d’Italia i Borboni, i francesi e gli austriaci, assicurare il trionfo alla democrazia pura.
Di qui la stessa diversità di tendenze ebbe ad avverarsi, com’ era naturale, nelle provincie, per lo che in Foggia sursero del pari, la sera istessa del venti luglio, due comitati: l’uno in casa del marchese Saverio Salerni di Rose, che sarebbe stato dei liberali inspirantisi agl’intendimenti del comitato di Azione di Napoli, l’altro nell’orfanotrofio Maria Cristina, dei così detti moderati, che sarebbe stato, né più né meno, una diramazione del comitato centrale dell’ Ordine.
Affollatissimi riuscirono entrambi i comitati; ma nel loro seno vi furono persone molto pratiche, che ebbero a notare, nell’ interesse comune, la necessità e l’urgenza di fonderli insieme per un’opera unica e più efficace. Ed una di queste fu monsignor Gherardo Santaniello, un oratore sacro basilisco e di gran valore, che il Frascolla avea fatto venire da Potenza, prima a predicare, e poi per insignirlo della dignità teologale nel Capitolo foggiano, e che divenne, in prosieguo, con sorpresa di tutti, suo emulo… ed avversario. Questi intervenne nel comitato dei liberali, che chiameremo ricciardiani, a casa del sindaco di Rose, e, chiesta la parola, cominciò col plaudire all’iniziativa di costituire i foggiani in comitato permanente di agitazione per rendere così più agevoli e più fattivi gli apparecchi del mutar di Stato ; ma, con suo sommo dolore, dovea deplorare una divisione del gran partito liberale anche prima ch’esso raggiungesse la meta ultima del trionfo. Vis unita fortior, la unione fa la forza—egli esclamava—, e bisognava stare uniti insieme, serrati in un sol fàscio per conseguire più sollecitamente il comune intento. Egli avea fede che tutti sentissero tale necessità, e che non dovevasi né potevasi imitare in ciò il comitato centrale di Napoli, già suddiviso, e che forse sarebbe venuto anche ad un accomodamento intorno al creatosi dissenso sulle modalità, in vista del comun fine.
Infatti l’accordo tra i due comitati napoletani ebbe dappoi a verificarsi, mercè l’intervento del nostro Luigi Zuppetta, tornato anch’egli dall’esilio, e che distese il programma degli uomini di azione, avente di mira l’unità, la libertà, la sovranità della nazione, accettando, per la necessità del momento e per non compromettere l’edilìzio, fecondato col sangue di tanti martiri, la formola: Italia una, con Vittorio Emmanuele,re costituzionale. E tale definitiva comunanza venne suggellata nel dì otto agosto di queir anno, assistendo tutt’i liberali, indiistiatamente, ai funerali di Guglielmo Pepe nella chiesa dei Fiorentini, che ben rappresentavano i funerali della monarchia assoluta, e spiegando poscia un’azione unanime, formidabile, una gara prodigiosa con unicità d’intento, quando Garibaldi annunziò dalla Sicilia di voler passare sul continente.
In un piccolo centro — continuava dunque il Santaniello-“, dividendosi e suddividendosi, si sarebbe finito col discreditarsi, col dilaniarsi, con l’annullarsi anche prima di veder la luce, per lo che avea fede profonda in quanti, sentendosi schiettamente liberali, avrebbero, nel!’ interesse dei comuni intendimenti, aderito all’idea patriottica di sorgere come un sol’uomo a combattere in nome dell’indipendenza, e della libertà.
Il discorso, applauditissimo, produsse una grande impressione, tanto che fu rimandata ogni decisione a dopo essersi ponderatamente esaminata la cosa, previo il consiglio dei migliori, In vero, tutti, e dell’una e dell’altra falange, dopo molte pratiche fattesi all’uopo, si convinsero che il fondersi tra loro era una necessità ; sicché fu stabilito per la sera del ventidue luglio, sulle ventiquattr’ ore, un comitato plenario in una delle sale dell’ orfanotrofio, dove sarebbero convenuti d’ ogni parte, e si sarebbe proceduto altresì alla nomina del presidente. Ma la seduta fu così tumultuosa a proposito dei diversi nomi che si prediligevano, che non si potè venire a capo di nulla, e l’adunanza si sciolse, con rimandarsi a tempo indeterminato ogni; idecisione sulla scelta del presidente, pur dandosi allora allora convegno giù al largo Gesù e Maria, donde mossero tutti, con evviva e gridi di gioia, a percorrere in massa le vie della città. La qual cosa spiacque non poco all’ intendente duca di Bagnoli, che il dì appresso pubblicava un’ordinanza proibitiva dà assembramenti e di clamori in piazza, sotto pena di correzione a norma dì legge, affidandone alla guardia nazionale l’esecuzione. Il Bagnoli, nelle cui fibre già annidavasi la paura, tentò ancora di far la voce grossa per non dispiacere i suoi padroni, ma ei già vedeva lo espandersi delle fiamme della ri-, volizione in tutta la provincia, e ben giudicava non vi fosse, più forza umana capace di estinguerle. A Sansevero il popolo tu rivolta, aveva insultato e costretto a fuggire quel commissario di polizia, per lo che fulmineamente era stato destituito il ff» sottointendente, consigliere Antonio Cortese, che non seppe o non volle usare mezzi violenti di repressione. E a Foggia ìstessa il giorno trentuno successivo, nel quale dovea solennizzarsi il genetlìaco di Maria Teresa, madrigna del re, il popolo fece sapere al Bagnoli, mediante parecchi graduati della guardia Razionale, che in piazza nulla dovea farsi in simile ricorrenza, altrimenti si sarebbe reagito con una dimostrazione ostile ; in seguito di che questi dovè circondarsi di prudenza, e festeggiarlo tacitamente nell’ oratorio dell’ intendenza.
XIII
Scorazzava da tempo la campagna del Tavoliere un noto bandito a nome Nicola Morra, nativo di Cerignola. Costui, appartenente a famiglia di « soprabiti »», com’ egli stesso enfaticamente diceva, perchè nato da Giàndonato Morra, àgiatissimo proprietario e di buona reputazione, che voleva fare di suo fìglio un Canonico, ma che per asinità e mal costume dovè acconciarsi a vederlo semplice castaldo – non avea che ventidue anni appéna, quando la notte del 4 aprile 1849, per salvaguardare, nella sua Qualità di fattore di campagna, il podere del suo padrone dal pascolo abusivo di estranee mandre, uccise, a colpi di pugnale, in quel di Lucerà, quasi trascinato pei capelli ad una specie di dichiaramento, un giovane guardiano» Condannato per questo reato a venticinque anni di ferri, ne scontò soli sette o pòco più giacché riusciva nell’ anno 1857 ad evadere dal bagno penale di Nisida e a ritornare in Capitanata, ove si dette per necessità alla Vita del masnadiero.
Un’ aureola di romanzesche leggènda lo circondava, e perciò egli prese ad esercitare un certo fascino, misto di simpatia e di paura, in chiunque s’imbatteva, e che, all’ occasione, sapeva anche beneficare con danaro, se in misero stato ; per la qual cosa non v’ era persona che osasse tradirlo con denunziarlo alla polizia, ma tutti, quasi in gara, gli assicuravano sicura ed agiata esistenza quotidiana
In conseguenza di ciò molta gente ne rimase, specialmente in Foggia, compromessa sul serio, cui la polizia non lasciava certo di far sentire il peso della sua mano. Fra’ tanti si so-spettò una volta sin d’un tal Carlo Giannini, capo di uffìzio della intendenza e capo-plotone delle guardie di onore, avviluppato nell’ incanto del bandito, e lo si sospese da ambo gli ufficii. Invano questi protestò, invano chiamò temerarii e giudizio e provvedimento, che l’ intendente fu irremovibile, irreconciliabile. Ed egli chiese allora di giustificarsi personalmente col re, e d’implorare da lui grazia e riabilitazione. Che anzi ottenne dal principe Leopoldo, il quale trova vasi in quel momento a Foggia, un permesso speciale per essere ammesso alla presenza di Ferdinando II in Bari ; ma, partito il 21 marzo 1859 a quella volta, non appena toccò Barletta, dovè ritornarsene, perchè quel sotto-intendente avea ricevuto ordine tassativo dal ministro di polizia di non fargli a nessun costo proseguire il viaggio. Sicché il pover’ uomo se ne tornò dolente, confuso è sconcertato quasi come un cieco che abbia smarrito il suo bastone, e si tappò tra le pareti domestiche per scontare nel silenzio un peccato fors’ anche non mai pensato, né commesso.
All’ombra, dunque, di tali protezioni Nicola Morra giustamente si sentiva quasi al di sopra dell’Achille omerico, invulnerabile fin nel tallone, e, pur non lordandosi mai le mani di sangue, commetteva ricatti a dritta ed a manca o con usare la massima scaltrezza ed audacia, o con dare alla sua richiesta la forma semplicissima di un prestito grazioso. E i gendarmi, per conseguenza, andavano sempre sulle peste di lui inutilmente, che il Morra ne sfuggiva come uno scoiattolo al loro dente viperino, disparendo nei tanti spechi, che generosamente gli si aprivano per nasconderlo, e tal fiata umiliandoli perfino col far loro baldanzosamente le fiche e gli sberleffi. Oh quante volte essi si trovarono perciò in condizioni di rassomigliare ai postumi e famosi carabinieri di Offembach, ch’eran costretti a venir ripetendo :
Nous somme les carabiniers
La sureté des foyérs,
Mais par un malheureux hasard
Nous arrivons toujours trop fard
Parecchi episodii van raccontandosi di lui, e che furono pure consacrati in ispeciali memorie scritte sul bandito (1), episodii che, dispogliati dei fronzoli, di che la tradizione si piace spesso abbellire perfino i truci fatti umani, ne rivelano, in fondo in fondo, il carattere non comune ai suoi compagni di ventura, e ci additano in lui un uomo quasi abbozzato su’ vecchi tipi, descritti da Federico Schiller, intolleranti di stringere il loro busto in un farsetto e la loro volontà nelle leggi, schifiltosi di un secolo parolaio ed eunuco, paladini e vendicatori dei deboli e degli oppressi contro i forti e gli oppressori.
Un giorno Morra si recò a Foggia, ove spesso s’internava indisturbato, e mostrò ad un amico di bramare e di volere ottenere ad ogni costo un certo cavallo corridore, di puro sangue, già provatosi invincibile in parecchie gare sportive, e che si apparteneva ad un tal Nicola Palazzi. Ma T amico, che volle provarsi a trarlo fuori dalla scuderia invito domino, senza riuscirvi, gli disse che l’impresa non fosse possibile, cui, perciò, bisognava rinunziare. Con sorriso di scherno Nicola Morra, il quale non indietreggiava innanzi all’impossibile, rispose deciso : « eppure il cavallo sarà mio ». Infatti l’indomani, presso l’alba, si fece egli stesso sulla porta della scuderia, e, con tono da signore che non ammette repliche o dinieghi, chiamò il fantino, ancora mezzo dormiente, e, mettendogli nel cavo della mano cinque piastre, gli comandò di bardare il cavallo designato. Il fantino, sbalordito di fronte a tanta risolutezza, e pen-sando che quei fosse un congiunto od un amico del suo padrone, fors’anche mandato da lui, obbedì senza titubanza veruna; al che Morra, fattasi mantener la staffa da luì medesimo, montò in sella e si allontanò a galoppo. Scopertasi tosto l’abile truffa, il Palazzi andò in ismanie, il fantino venne arrestato come complice, e Foggia rimase attonita innanzi a tanta temerità. Ma, dopo un certo tempo, il Morra, annoiatosi della bestia, la rimandò al Palazzi, fors’ anche più vegeta di prima, e con una lettera cortesissima di ringraziamento.
Un altro dì, vigilia della festa della madonna di Ripalta in Cerignola, si trovava egli colà insieme con un altro suo compagno di ventura, tal Gabriele Buchicchio, un basilisco, anch’esso evaso dal bagno penale, dappresso ad uno steccato dove correvasi il così detto pallio, che do ve vansi disputare tra loro diversi cavalli, caracollanti di già sulla pista per saggiare il terreno. Tra questi il Morra ne adocchiò uno dalle belle forme, che sembrava agilissimo ; e il desiderio d’impadronirsene si tramutò presto in atto. Si avvicinò, infatti, al fantino con un’indifferenza da far strabiliare, ne domandò il nome del proprietario, e, saputo ch’ei fosse un Manciacapo di Trìnitapolì, se ne congratulò vivamente. « Stupendo, stupendo davvero ! esclamò, squadrando il bello animale da capo a piedi, é solleticando così la vanità del fantino innanzi al popolo numeroso, mentre s’impadroniva della briglia e invitava colui a smontare di cavallo col fargli scivolare in mano altre cinque piastre di argento. Il fantino, alla vista di quel metallo seduttore, non sapendosi dar ragione di ciò che avveniva, scavalcò còme un automa, e, nell’ atto che guardava l’ ignoto a bocca aperta, questi saltò in sella e, dopo avergli gridato : « Di’ al tuo padrone che il suo cavallo l’ha portato via Nicola Morra », diè un colpo di sperone e come razzo disparve. Ma non passò molto tempo e anche il cavallo di Manciacapo fu ridato con una lettera di ringraziamento pel momentaneo favore conseguito, avendo egli preso già altro cavallo corridore da Luigi Lomuscio di Foggia, che, a suo tempo, benanche restituiva.
In giubba all’ungherese, in calzoni neri e stivaloni, con un fazzoletto di seta attorno al collo così come usava andar dì consueto, il Morra capitò un giorno alla masserìa detta Pischitella, sul confine tra Cerìgnola e la Basilicata; e, spacciandosi per un guardiano che andava in cerca di tre giumente sperdute, chiese del signore del luogo per ottenere un po’ di biada pei suo cavallo. Antonio Padula, il proprietario, che in quel momento trovavasi nel pianterreno a darsi gaiezza con una sua favorita, bel tocco rusticano, lo accolse bruscamente, quasi rimproverandolo di tale richiesta; ma l’appetitosa donnina, con un’aria da padrona, sbuffando anch’ella, ne tolse un sacchetto; e, senza infingimenti, glielo gìttò ai piedi come un’elemosina fatta contro genio. Il Morra, quasi scandendo tra le labbra un «vi ringrazio», Io riaccattò da terra nervosamente e si allontanò. Ma, venuto a sedersi presso il suo cavallo che avea biadato, accese la pipa e, noiato, prese ad osservare attentamente quello che intorno avveniva. Era l’ora del mezzodì: un buon odore di vivande venne, in un punto, a solleticargli le nari, che due contadinette, con canestri ben ricolmi e fumiganti, gli passarono veloci d’innanzi per andare a rifocillare il loro superbo signore. Nel contempo uno di quei massari preparava per sé, in un pagliaio, del pancotto scipito, e che, in vedere lo sconosciuto a bocca asciutta, lo invitò cortesemente a tenergli compagnia. Morra ringraziò, ma, fattoglisi vicino, riuscì a investigare quali fossero le abitudini quotidiane del Padula. Saputo quanto gli abbisognasse, salutò il buon’uomo, e, rimontato in sella, lasciò la masseria. Dopo due giorni, allorché verso le tre pomeridiane il Padula usciva a cavallo dal cancello del suo podere e prendeva la via di Candela, gli si fece di fronte il Morra. Soffermatolo, gli annunziò il suo véro nóme, al che quegli allibì dallo spavento, mentre l’altro afferrava la cavezza del cavallo e gli intimava di seguirlo. Il Padula si fece guidare come un agnellino sin dentro ad un campo ben protetto da spessi alberi fronzuti e dove occhio indiscreto non avrebbe potuto raggiungerli. Quivi pervenuti, il Morra con accento glaciale gli disse: «Caro signore, ti chieggo un favore, e spero mi vorrai accontentare con le buone, non avendo punto intenzione di farti alcun male. Mi presterai non più di ottomila ducati in oro, perchè ne ho tanto bisogno sull’istante; e poi ti assicuro, in fede mìa, che ti saranno completamente restituiti ». L’altro, in udire, rigò di copiose lagrime le gote; al che il Morra, ponendogli il pugno sul muso, gli disse: « Possibile !.. Sei tu lo stesso di ieri?., tu, sì spavaldo, sì sprezzante innanzi a quel bocconcino principesco?!.. tu, che ti godesti con lei un succulento desinare senza darti pensiero di quel poveraccio, ch’ero io, rimasto a fumare accanto al tuo portone, ed a cui di malavoglia facesti l’elemosina di un meschino sacchetto di biada?!,. Ed ora osi piangere in tal modo ai suoi piedi?… Oh il vigliacco che sei ! Ti disperi per sì vile moneta! Ma a che serve l’averne poi tanta a giacere nei forzieri?.. Pensa, invece, che gli ottomila ducati andranno a quanti soffrono, e che ti restarono sempre ignoti, perchè di loro non ti dai mai briga, — andranno alla gente che patisce ad ogni ora le torture della fame, da te non mai provate, gente che, in contraccambio della pietà che ho per essa, salverà poi me dalle unghie della giustizia. Farai così, in fondo, senza volerlo, un’opera buona, non mai per lo innanzi pensata o compiuta, un’opera di vera e santa carità cristiana ». Quindi, dato in uno scroscio di riso, gli si fece maggiormente da presso, e, mutando in faceto il tono burbero della sua voce « Senti » gli disse, « voglio ora consolarti fra tanto angosciare : tu non hai figli; supponi quindi ch’ io sia un tuo rampollo prediletto, e che debba prender moglie. Oh caro il mio papà, il mio buon papà ! Dammi, dammi una porzione della dote che mi spetta e che non puoi rifiutarmi. La dote, la dote dunque; ci siamo intesi?… Orsù, papà, facciamo presto! ».
Il Padula, coartato a scrivere un biglietto a suo fratello, gli richiese, senz’ altro, la non lieve somma impostagli, biglietto che fu portato a destinazione da uno dei suoi massari, appositamente fatto venire con circospezione in quel sito. Dopo una notte di palpiti e di ansie, passata in compagnia del bandito, il Padula finalmente l’indomani, verso l’alba, non appena pervenne l’intero prezzo del riscatto, potette riavere la libertà, con promessa del Morra che gli ottomila ducati, ricevuti a titolo di prestito, gli si sarebbero un dì o l’altro restituiti. Infatti non passò molto tempo e Morra, recatosi di persona alla masseria, ridette al Padula la metà della somma, dichiarandosi tuttavia debitore degli altri ducati quattromila.
E un altro dì, per provare al signor Federico Pavoncelli, suo. compare al fonte battesimale, che di lui, benché solo, bisognava temere per davvero, mentre l’altro pare lo stimasse come uomo dappoco, da consigliare l’amico barone Zezzi di nicchiare innanzi ad una richiesta fattagli dal Morra di mille ducati a prestito, ne sequestrava il figlio Gaetano nei dintorni di San Martino, conducendolo a Tressante, e gli chiedeva in riscatto dodicimila ducati in oro. Bastò per lui unicamente la soddisfazione di aver messo per breve istante in grande scompiglio il suo detrattore e di avergli data —a suo dire— una lezione; perchè, in fin delle somme, è a sapersi che né al giovine sequestrato fu poi torto un capello, né al padre di lui fu furato un quattrino. La vanità dei delinquenti, siccome nota il Lombroso, supera quella degli artisti, dei letterati e delle donne galanti: è la vanità della propria forza, della propria bellezza, del proprio coraggio, delle male acquistate e poco durature ricchezze, e, ciò che è più strano e più orribile, della propria abilità nel delinquere.
Ed anche a titolo di prestito a breve scadenza richiese altra volta a Domenicantonio Figliolia di Foggia un’ ingènte somma, e, non essendone stato accontentato, montò in bestia; pure, con evidente simulazione, lo mandò a salutare a mezzo del suo fattore, ringraziandolo come se il favore gli fosse stato fatto davvero, per il che gli si protestava amico. Amico un corno!… che Figliolia da quel dì fu preso da tale un panico che non si sentì più sicuro in Palazzo d’ Ascoli Satriarìo (così denominavasi la masseria tenuta in fitto, dove dimorava), e volle tornarsene in città. Per eludere però la vigilanza del bandito, che avrebbe potuto fargli per via un brutto tiro, si fece chiudere ermeticamente in una botte come un Diogene in 64°, e trascinare da un carro tirato da buoi sino a Foggia. Il Morra dovè riderne a crepapelle; ma non tardò tempo che si vide pervenire dei messaggi di pace da parte del Figliolia, e, coi messaggi, buone somme di danaro.
E ricatti non meno gravi, fatti per lo più a scopo di vendetta, con minacce di grave danno e di morte, ebbero a subire or l’amministratore di casa Larochefoucauld e del duca di Bisaccia, or Francesco Paolo Siniscalco, ora il marchese Luigi de Luca, or mille e mille altri, senza che la polizia, costantemente inetta, avesse potuto mai porgli le branche addosso.
La sera del 22″ giugno 1858, con la più grande semplicità e naturalezza, egli, alle porte di Foggia, in compagnia del compare Nazzaro Spinelli, un cuoco alle carceri centrali, e di altri parenti ed amici, fra cui la bella Rosina, sua donna del cuore, osò imbandire una poetica cena sotto la volta serena e stellata del cielo, sull’erba molle e fresca, dietro le mura del convento dei pp. alcanterini. Si brindava colà allegramente, vuotandosi boccali su boccali di buon vino, e frammezzando le laute libazioni con tale uno schiamazzo da attrarre su di loro l’attenzione di un geloso e timido colono vicino. Questi aveva sull’aia le bighe del grano mietuto, e credette allora che gli sconosciuti banchettanti, già brilli, avessero delle cattive intenzioni e volessero, anche per una semplice bravata, far mano bassa del suo ricolto. Pensò quindi, a precauzione, di avvisarne i gendarmi, i quali vennero sul posto in numero di tre per arrestare, col loro facile cerimoniale, i componenti la festosa comitiva. Ma la più grande delusione ebbero essi a provare quando, nell’avvicinarsi, si accorsero che un uomo, scattando da terra come .molla, e, montato in arcione, ratto si dileguava tra le ombre, e che quell’ uomo era Nicola Morra.
E ancora più umiliante per la gendarmeria fu l’incontro con lui sulle sponde dell’Ofanto. Il Morra col Buchicchio aveano guadato il fiume, quando udirono un colpo di fucile a breve distanza; al che il primo, per indagarne la causa, s’inoltrò nel bosco, donde il colpo era partito. Con sua sorpresa riuscì a intravedere tra il folto delle querce un gendarme solitario, che portava tra mano due colombi, e, non sapendosene spiegare il tipo, gli si avvicinò pian piano, indifferente, senza punto destare ombra di sospetto. Il gendarme, accortosi di lui, lo salutò, domandandogli se avesse un cane, che potesse rintracciargli nel bosco un colombo sperduto.
— Non sono un cacciatore «rispose il Morra; «ma voi donde venite?
— Siamo stati a perquisire la masseria d’Impicciatore Audice in cerca di Nicola Morra, che si dice vada spesso colà a prendervi asilo.
— E i vostri compagni ?
— Sono ancora là, ma verranno or ora qui su carretti che il padrone della masseria fa approntare, perchè, non essendo noi gendarmi a cavallo, non potremmo a piedi passare il fiume ingrossato. Io li ho preceduti per fare un pò di caccia ai colombi.
— Bravo ! » riprese il Morra. « Ma essi non si sono brigati affatto di voi, perchè, guardate là, sono già passati tutti all’ altra riva.
Infatti un buon nerbo di gendarmi, col suo tenente, si scorgeva in lontananza di là dal nume.
Il povero gendarme, in ciò scoprire» fu preso dallo sgomento vedendosi impossibilitato a più raggiungere la squadra; ma il Morra ne Io rincorò e si offerse lui stesso al guado facendolo adontare in sella sul suo cavallo, mentre ei né rimase indietro sulla nuda groppa. Durante la traversata ebbe agio il Morra dì scrivere con la matita, a forti lettere, sulla correggia bianca, che il birro portava a bandoliera: « Se i compagni ti domandano chi ti ha fatto guadare il fiume, di’ che è stato Nicola Morra ». È da figurarsi il putiferio avvenuto tra i gendarmi allo scoprimento della canzonatura, e la bile del tenente, che si vedea così messo alla gogna per dover ricondurre in città ì suoi subordinati a guisa dì segugi con la coda tra le gambe.
Eppure una volta, trovandosi il Morra alla masseria Montesquareillo, dì proprietà del vescovo di Bovino, ove, per un forte turbine di neve che intirizziva le ossa, era venuto a riposarsi presso un guardiano suo amico, fu riconosciuto da un eremita, che dimorava colà a custodia della chiesetta del podere, e stette veramente ad un pelo per cadere in trappola. L’ eremita, che stava solo, perchè il guardiano trovavasi momentaneamente assente, lo avea fatto ad arte sedere in cucina presso l’ardente focolare, e, credendolo caduto in sonno profondo, balzò con due salti giù nel cortile, donde, bardato un muletto, ne uscì con sbarrar di fuori il portone e eon legarvi su in croce un grosso palo per evitare in tal modo che di dentro lo si potesse più aprire. Egli correva, naturalmente, ad avvisarne la polizia, la quale, infatti, sguinzagliò su Monteequarcitto, senza perdita di tempo, ben cento armati. Ma il Buchicchio, che, pre¬veggente, avea preferito di starsene ricoverato sotto un pagliaio in quelle vicinanze, anzichè di entrare col Morra nella masseria, riuscì a scoprire il tranello, e, non appena l’eremita si allontanava sul suo muletto, affrettossi ad aprire il portone e a mettere in salvo il compagno. Sicché, quando i gendarmi in folla, guidati dallo stesso eremita già trionfante pel buon colpo fatto, ebbero a giungere sul luogo, trovarono la gabbia aperta e l’uccello fuggito; che anzi, come a scherno, sul muro della cucina, ove quegli era stato lasciato pocanzi a dormire» scopersero una scrìtta, fatta col carbone, che diceva : « Stavo una volta, ora non più ».
La polizìa, non potendo avere, a niun costo, nelle mani il Morra, perseguitava senza posa i parenti di lui, sperando con tal mezzo d’indurlo spontaneamente a costituirsi. E ne sottomise infatti, fra l’altro, a sorveglianza speciale un cognato, costringendolo in Foggia a recarsi ogni mattina davanti a quel commissario. Che anzi si volle estendere il provvedimento anche alla moglie di costui, e sorella del bandito, Loreta Morra, la quale, però, non volle darsi per vinta, facendo sapere che fosse impossibile per lei il muoversi, trovandosi incinta. La polizia non le aggiustò fede, e ordinò che un medico si accertasse del vero stato di lei. L’indagine, superficialmente fatta, risultò negativa; ma il medico espresse ulteriore parere che, per aversi un esauriente giudizio, era d’ uopo osservare le pudende di lei. E la polizia emise la relativa autorizzazione. Saputo ciò Nicola Morra, non dette egli tempo all’ Esculapio foggiano che commettesse tale profanazione, e, non appena l’ordine fu dato, volle dar pane per focaccia, rendendo di pubblica ragione l’oltraggio compiutosi da circa due mesi sulla figliuola di un alto funzionario locale, e che erasi fino a quel momento tenuto nascosto; per lo che si» videro in Foggia, come all’ aprirsi di una scena, affissi,dei grossi cartelloni, in cui si leggeva:
Sono un medico di Parigi. I miei prodigi riempiono di profonda meraviglia il mondo intero ! Ho guarita la moglie del marchese Maupas, come pure la moglie del visconte Magnan! Ora voglio far conoscere la mia valentia a questa Puglia intera. Ho visitata anche la figlia del comandante la provincia, ed ho constatato che è gravida di due mesi. Auguro al comandante un bel maschietto, e gli raccomando di procurargli un buon minchione di padre !
Un saluto a tutt’i foggiani.
Nicola Morra
La penna è un ritrovato infernale : ben si disse perciò che Lucifero, precipitando dal cielo, restasse spennacchiato nelle ali da un fulmine dell’ arcangelo, e codeste penne, cadute sul nostro globo, sieno state dall’uomo raccolte ed aguzzate per servirsene come freccie, attoscate col pessimo dei veleni, che è l’inchiostro. Il libello di Morra produsse il suo effetto, che, a soffocare lo scandalo sul nascere, furono fatti sollecitamente partire per Cerignola Loreta Morra e suo marito.
Questo strano tipo di bandito elargiva ai bisognosi parte o tutto dei suoi proventi, e, tra le benedizioni e gli osanna, egli incedeva- per le campagne quasi come se fosse un benefattore dell’umanità sofferente, e interpretava il vangelo a modo suo, sottraendo ai ricchi ciò che loro superava, per darlo ai poveri. Duemila ducati, che tolse all’ amministratore di Larochefoucauld e del duca di Bisaccia li divise fra massari e pastori. Ad un vecchio, che, su di un asinelio, era menato moribondo alla città dal suo tenero figliuolo, lacero e smunto per miseria estrema, dette un dì un sacchetto di piastre perchè avesse potuto curarsi. Ad una povera donna, cui la recente leva aveva portato via l’ unico figlio, rimasto nel deposito dei coscritti a Foggia, e che disperavàsi per non avere più, d’ ora innanzi, chi le procurasse un pane, dette una moneta di argento, più un biglietto di raccomandazione, col quale avrebbe potuto, a suo dire, presentarsi a chiunque di quei paesi, per riunire, senz’altro, la somma di dugentoquarantotto ducati e sei carlini, che abbisognavano per dare un cambio al governo. Infatti la poverina, dopo poco tempo che andò in giro con quel biglietto, trovò profetiche le parole del Morra e potette riavere il figlio.
E a codesti benefizii, che usava con l’ assottigliare le sue entrate e col profittare del timore che incuteva il suo nome, ne tenne dietro qualcuno a tinte più forti, lo strappare cioè il danaro dalla borsa altrui per donarlo a chi gli piacesse, non solo allo scopo di togliere costui da un imbarazzo finanziario, ma di compiere così un atto di ribellione verso i potenti.
E al proposito ricordiamo di una certa fittuaria, che aveva un debito, non potuto da tempo soddisfare, di mille ducati con un signor De Mito di Ascoli Satriano, il quale, naturalmente, per garentire il suo avere, la minacciò di un sequestro giudiziario. Colei, non avendo sul momento come stornare tale esecuzione forzata, si confidò tra le lagrime col Morra, il quale, interessatosene, le prestò la suddetta somma, suggerendole che, allorquando l’usciere fosse venuto alla masseria pel sequestro, gli avesse mostrato il danaro, denotandogli che, a causa d’infermità, non potendo condursi in paese, aspettava che le avessero portata alla masseria la ricevuta firmata dal De Mito, ed avrebbe subito pagato. Infatti l’usciere, col suo seguito, abboccò all’ amo, e, ritornato munito di quietanza, gliela consegnò, ricevendosi il danaro. Però mentre costui su di un biroccino si trovava già parecchie miglia lontano dal podere, sulla via di Ascoli, fu assalito dal Morra e dal Buchicchio, i quali, minacciandolo di morte, lo costrinsero a consegnar loro il danaro esatto. Per lo che il De Mito perdette ad un tempo e credito e danaro.
Ed erasi cotanto propagata la fama di essere il Morra largamente generoso con gli umili e con gli oppressi, che questi, o il conoscevano o noi conoscevano, facevano a gara per garantirlo e per prestargli aiuto in ogni occasione.
Le autorità, che non trascuravano mezzi per raggiungere il Morra n’ andavano disperati ; e si ricorda un tal tenente Martucci, residente a Bovino, che promise di ghermirlo in quindici giorni, se gli si accordavano sei guardiani del duca Guevara e ventiquattro gendarmi a cavallo, cosa che, ottenuta, menò a nulla, perchè quel birbo ben seppe sempre pigliare a gabbo il Martucci, e, dando per dileggio a credere che quei si divertiva di podere in podere, anziché fiutare la preda, fece un dì tappezzare le mura di parecchi paesi con i seguenti versi :
Per ogni borgata, per tutte le vie
Ingrascia il Martucci ne le masserie.
Risparmia ai tuoi fidi cotanto strapazzo,
Ritorna a Bovino, chè sei un pupazzo;
Ritorna, ten prego, e se a te pur piace,
A Morra Nicola ridona la pace.
Re Ferdinando, cha ci tenea moltissimo a farlo cadere nei lacci della giustizia per poter rialzare in quelle contrade il prestigio della polizia, ormai messa alla gogna, credette di a-verlo già tra mano, e ne esultò quando, nel suo ultimo viaggio verso Lecce, passando per Cerignola» sentì da una folla, che plaudente Io accerchiava, rivolgerglisi una donna molto ardita, chiedente grazia per lui. Domandò allora chi ella fosse, e, saputo ehe chiamavasi Teresa Cibelli, zia del bandito, la esortò paternamente a farlo presentare, nel qual caso gli avrebbe fatta la grazia. Ma Morra non mise fede alla parola del re, ceh’ egli potentemente odiava e contro cui spendea tuttodì anche la sua opera per minarne il regno, essendo in relazione con i capi-settarii dell’ epoca, specialmente con Albino di Morro, che fu capo del governo provvisorio di Potenza, nonché con diversi comitati rivoluzionarii, tra’ quali fu spesso messaggiero di notizie segrete e di lettere compromittenti.
« Nicola Morra — dice il suo biografo — si faceva di fuoco per rovinare quel re, che gli prometteva la grazia. Da Foggia correva a Potenza, quindi tornava donde era partito, per nuove commissioni, per nuovi plichi da consegnarsi, per nuovi ordini. Era una macchina che eseguiva tutto puntualmente e con una prontezza incredibile. Sempre a cavallo e in moto, aveva dimenticato che cosa significasse riposo. La sera del 26 gennaio’59 era a Foggia in casa di un tale Gaetano Postiglione, il quale gli affidò un importantissimo plico, che dovea consegnare a monsignor Santaniello. « Ricordati — gli diceva il Postiglione — che tieni nelle mani le nostre teste ! » — Don Nicola lo guardò per poco, quindi disse : « Credi forse che il cuore di Morra sia quello d’un traditore ?» — Il 3 febbraio dava nelle mani del vescovo quel plico, e si trattenne con lui alcun tempo, ragionando di ciò che succedeva nel regno : « Il re è ammalato, gravemente ammalato. Si susurra che è stato avvelenato a Bari. I medici gli hanno contati i giorni. » — « Eppure me ne dispiace — rispondeva Morra. — Poveretto ! Non può godere le feste per lo sposalizio di suo figlio ! Odio il re io, non il padre di famiglia. » — « Va, don Nicola, torna a Foggia, e di’ agli amici che monsignor Santaniello li saluta e l’incoraggia. » — Don Nicola partiva per mandare a fine nuove commissioni affidategli, mentre quel povero re Bomba non si dimenticava di lui, lo sognava nelle notti lunghe ed insonni, pensando che con lui tutto finiva ».
Eppure quando Giuseppe Garibaldi era già sbarcato coi Mille a Marsala, e i gigli di Casa Borbone accennavano a rapidamente sfrondarsi, il Morra, che sognava porre anche il sua braccio in servizio della rivoluzione, — come, in seguito, ebbe occasione di fare Gabriele Buchicchio, il quale arruollossi tra i volontarii e si battette sotto Capua, assurgendo al grado di capitano dei garibaldini (!), e che fece poi i suoi conti con la giustizia non prima dell’ anno 1864, quando potette essere arrestato —, il Morra, dicevo, venne gravemente ferito al gomito il 4 agosto 1860 in uno scontro presso la cappella di s. Lorenzo a poche miglia da Foggia. Egli andava a cavallo col Buchicchio, quando fu avvistata la carrozza del proprietario foggiano Giovanni Barone, che veniva dalla città alla sua masseria. Sedeva accanto al cocchiere un guardiano, ed entro, con lui, vi si trovava un giovane fattore, tal Domenico Grassi. Alla intimazione di fermarsi, il guardiano, sollecitato dal suo padrone, rispose con una fucilata, che raggiunse il Morra al gomito ; al che questi col Buchicchio fecero parlare anch’ essi i loro fucili, e molto più sapientemente, perchè ne rimasero uccisi il cocchiere ed il Grassi. In tal punto il Barone col guardiano ebbero il destro di aprire lo sportello e di darsela a gambe levate, mentre i due banditi, abbandonando l’ ulteriore preda, si allontanarono di galoppo. Alla distanza di quattro giorni il Morra, dopo essere rimasto celato in una casa a Cerignola, temendo che l’arto si cancrenasse per mancanza di cure, si vide nella necessità di scompagnarsi dal Buchicchio e di dare un addio alla vita brigantesca per presentarsi spontaneamente a quel pretore locale.
E così, infatti, sulle ventitre ore del nove di agosto Nicola Morra, col braccio destro fasciato e a tracollo sul petto, in compagnia della madre e di sua sorella, in una carrozza da nolo, circondata e custodita da dragoni a cavallo, passò per Foggia tra una folla di curiosi, cui, indifferente, mandava saluti e sorrisi. Tale convoglio sostò per poco al largo s. Eligio, ove il comandante della provincia venne a dare gli ordini opportuni pel proseguimento del viaggio sino a Lucerà.
Il Morra fu giudicato da quella Corte criminale il 1.° di ottobre del 1865, difeso dagli avvocati Gaetano de Peppo di quel foro, e Vincenzo Barisani del foro foggiano, e fu condannato a diciotto anni di ferri ; per lo che gli venne poscia assegnato come luogo di espiazione il bagno di S. Stefano, che egli nel susseguente cinque di novembre andò a raggiungere.
E così quest’ uomo leggendario e pericoloso scomparve dalla faccia del Tavoliere, che riacquistava pace e sicurtà, ma che dopo molt’anni, scontata la pena, ebbe a rivederlo alla macchia e a soffrire di lui nuove gesta brigantesche, che lo tra¬cinarono a pene ulteriori, sino a che lo vide vecchio, ma sempre impenitente, chiudere clamorosamente la sua esistenza.
XIV.
Dopo la breve parentesi, dedicata ad un uomo che fu un impasto di Capaneo e di Erostrato, e che rappresentò, quindi, un fenomeno della razza brigantesca assai strano e degno di nota, ripigliamo il filo della nostra narrazione.
Prescelto in sull’appressarsi della nuova aurora italica a sindaco di Foggia Saverio Salerai, marchese di Rose, prestava egli il suo giuramento il 1.° di agosto del 1860 innanzi al duca di Bagnoli, e insediavasi lo stesso dì col novello Decurionato al palazzo municipale. L’avvento di lui fu bene accetto ai liberali, che presero così maggior lena e ricominciarono a far pesare più di prima la loro mano sull’ animo dell’ intendente, già preso nelle ossa, come dicemmo altrove, dai brividi della paura. Non dovettero essi, infatti, affaticarsi molto per ottenere soddisfazione contro il conte Gaetani, colonnello di cavalleria, che trovavasi in Foggia da più giorni con la sua famiglia, incaricato, com’ egli stesso facea credere, di una compra di cavalli e di muli per uso del treno, ma ch’era sospettato invece di essere né più né meno che- una spia borbonica. Vollero che costui fosse espulso dalla città senza misericordia, e il duca di Bagnoli il 5 agosto ’60 gl’impose tosto di partire.
Non contenti di ciò, i liberali pretesero—ma questa volta non l’ottennero — che fossero del pari allontanati da Foggia la famiglia del marchese Orazio Cimaglia, dove il Gaetani era stato alloggiato qual loro parente, nonché tutti quelli che lo avevano avvicinato nella sua breve dimora in città. Alle riluttanze dell’intendente si rispose però con la violenza. E la sera del nove di agosto una folla di popolani circondò la casa Cimaglia, e, prendendo a gridare «abbasso, abbasso», nonché scagliando pietre contro le, invetriate dei balconi, intimò al genero del marchese, signor Nicola Delli Santi, l’ostracismo da Foggia. Al tumulto infernale accorse la guardia nazionale, che riusciva a disperdere i dimostranti ; ma il marchese Cimaglia, che temette seriamente per sé e per i suoi, la notte istessa decise di partire con essi, sul far dell’alba, per Manfredonia.
La nuova rappresentanza municipale cominciò a rivedere le bucce agli antichi amministratori. Si parlava di sperpero di danaro e di mistificazione di spese, fatte per opere pubbliche da tre anni in qua; sicché il sindaco di Rose e i suoi collaboratori, i quali erano intenti a questo lavoro, che diremo d’inchiesta amministrativa, mentre, in fondo in fondo, aveva un certo acre sapore di parte, temendo che si osasse dagl’interessati una qualche sorpresa alla sede municipale con lo scopo di voler tentare una sottrazione dei relativi documenti, disposero che un picchetto di guardia nazionale venisse a garantirli. Per conseguenza riescirono ad assodare ed a rendere di pubblica ragione che, essendosi fatte, due anni prima, delle ingenti spese per la venuta di Ferdinando II e pel suo ritorno non più verificatosi, queste, che non erano state punto legalmente autorizzate da chicchessia, erano passate, col beneplacito dell’intendente Guerra, come spese fatte per opere pubbliche del tutto ipotetiche. Un quadro completo dell’attuale situazione del bilancio si volle quindi rendere ostensivo al pubblico; cosa che fu fatta il nove di agosto, quando, con un foglio a stampa da’ caratteri cubitali, lo si affisse per la città a rulli di tamburo.
Sopraggiunse la festa solenne dell’ Iconavetere, padrona della città, che, secondo il consueto, comincia il tredici ago-slo e dura per tre giorni fino al quindici. Era da prevedersi che in quell’ anno 1860 non poteva evitarsi che si avverasse un qualche tumulto, dato il gran fermento che si alimentava dai diversi comitati rivoluzionarii, surti come per incanto in tutta la provincia in forma palese o latente. La sera del tredici agosto, dunque, molta folla si era radunata in contrada san Tommaso, ove nella chiesa dedicata all’apostolo erasi tra-sportata sin dal mattino processionalmente, avvolta in candido lenzuolo, la sacra Icone, in omaggio alla tradizione, che la vuole rinvenuta in un lago, su cui divamparono tre fiammelle, formanti ormai lo stemma della città, e donde fu menato poi alla prossima taverna del gufo, nel cui sito i cristiani le eressero un altare. Le vie erano splendienti di fantastiche luminarie, e le bande musicali soffiavano, soffiavano nelle canne dei loro istrumenti di legno e di ottone per cavarne le note più gaie a letizia di una folla brulicante, quando uno scapatello del vicino paesetto di Troia, che non nomino per non avvelenarne ora la pacifica vecchiaia, volle imprudentemente gittare in mezzo a quella ragunata uno sberleffe a bocca piena, atrocemente ingiurioso per i musicanti di Castelluccio Valmaggiore, che da più ore gonfiavano anch’ essi, i poverini, le ganasce in malo modo per eseguire, in onore della festa, il meglio che potevano, le più scelte sinfonie del loro repertorio. E quell’atto non bello compiuto da un signorotto, fu come segnale di rivolta: la folla si agitò, ruggì quasi belva stizzita, tentando di aver tra mano l’imprudente e ineducato giovincello per dargli una sonora lezione. Ma l’altro, agile di piede, sgaiattolò furbescamente da mezzo al fuoco e dileguossi. Molta gente paurosa aveva accresciute con le sue grida le proporzioni del tumulto, e nel generale scompiglio molte signore si videro mal-concie e peste, parecchie svenute. I musicanti, precipitatisi dall’orchestra, sembravano, coi loro istrumenti inalberati tra la folla, si accingessero a suonare in altra guisa, non più per essa, ma su di essa; — insomma un fuggi-fuggi non si potette evitare, per lo che la festa, col massimo danno del flirt di tante gio¬vani coppie, divorate dalla passione e dalla rosura del cuore, rimase a dirittura strozzata. E, se rìpigliossi il giorno appresso, non lo fu con minore preoccupazione, giacché molta elettricità erasi addensata nell’ aria, e temevasene, per un nonnulla, uno scatto improvviso e formidabile. Eppure le voci furono più che le noci, tranne che nell’ ultimo giorno, quando a mezzanotte, mentre erano scoppiati nel largo Gesù e Maria gii ultimi petardi di un fuoco pirotecnico e una calca di gente rincasava, sbucò su per le vie un gruppo di schiamazzatori, frammischiati a parecchi dragoni della guarnigione, che, con grida di abbasso e di evviva, riesci a espandere in essa un panico indescrivibile. Ma se la festa non ebbe a soffrire che due semplici spunti di sollevamento popolare senza nessuno strascico immediato, nei dì consecutivi, per contrario, esso assunse ben diversa figura e manifestossi in forma più lata, nonché pericolosa di accidenti. Infatti, la sera del sedici agosto, verso due ore di notte, una folla di dimostranti si recò sotto il palazzo del comandante della provincia colonnello Rispoli, chiamandolo abbasso. E siccome questi trovavasi sulla strada, così, accortisene, lo accerchiarono e, con procedimento ultra-esecutivo, si dettero a batterlo di santa ragione, a tirarne le orecchie, a strappargli i baffi, a martirizzarlo, insomma, come un s. Sebastiano in stereotipa edizione, gridandogli con accento risoluto, che non ammetteva remora o dilazione, di dovere all’ istante liberare Foggia dell’ esoso peso della sua persona. L’intendente duca di Bagnoli, in apprendere tal fatto, ordinò fosse il Rispoli condotto alla sua presenza; il che fu eseguito dal maggiore comandante lo squadrone, il quale con buoni modi cercò di calmare i più riottosi, riuscendo così a liberare il malcapitato. Costui, passato rapidamente dalla morte alla vita, confessò all’intendente di avere egli, con imprevidenza, provocata la folla, ponendo agli arresti i dragoni che nella sera innanzi si erano uniti ai dimostranti, cosa che non era stata approvata neanche dal ministro, il quale con telegramma avea disposto di rimettere coloro in libertà. Egli quindi si vide, perciò, irremissibilmente spacciato, e promise senz’ altro di partire l’indomani. Infatti, il giorno dopo, tappatosi nella propria carrozza, con cavalli da posta uscì dal portone di casa Andreana in mezzo ad una salva di fischi, che si ripetettero lungo ij percorso sin fuori la città, ove vuoisi gli si abbia dato l’ultimo saluto con sassi, lanciatigli contra, e che caddero, per buona fortuna, sul soffietto della carrozza. La folla, eccitata vie più dalla vittoria riportata su costui, non si sciolse, e, compatta, rifece la via sin sotto i balconi del capo di uffizio dell’ intendenza Giuseppe Sellitti, di cui voleasi far lo stesso mal governo, ma la guardia nazionale, accorsa, arrestò i più facinorosi e mandò alle loro case gli schiamazzatori.
E, in mezzo a un sistematico crescendo di atti baldanzosi, di violenze e di tumulti, che irridevano ad ogni freno, e che annunziavano la rivoluzione alle porte, lo stesso duca di Bagnoli dovè pensare fosse giunto, anche per se, il giorno del redde rationem, e, lontano da qualunque accesso di necrofilia, che lo incitasse a gridare il cupio dissolvi del fanatismo cristiano, pensò meglio di mettere in salvo il proprio cuoio, in barba di coloro che avrebbero voluto fargli offesa. Nelle ore pomeridiane del 17 agosto ’60 ei, dunque, si allontanò da Foggia con la sua famiglia, prescegliendo, come prima tappa del suo viaggio, cui certo non volea dar l’aria di una fuga, Rovino, ove sostava per più giorni presso quel sotto-intendente Riola. Oh i topi abbandonavano spontaneamente il vascello, Che cominciava a fare acqua da ogni lato !…
A questo primo colpo di scena ne seguì un altro anche impressionante, e fu la istantanea chiusura del Corpo di guardia della gendarmeria reale, che àvea sede sotto il palazzo dell’ intendenza. Dicevasi eh’ essa dovesse partire, come infatti partì la sera del cinque settembre per Campagna di Eboli, ove accennavasi uno sbarco del generale Garibaldi.
E tutto questo disfarsi, da un momento all’altro, del vecchio mondo poliziesco additava ai foggiani il trionfo definitivo della santa causa della libertà anche per la loro contrada.
I comizii elettorali politici, intanto, che dovevano tenersi la domenica del diciannove agosto per la nomina dei deputati, furono, per ordine ministeriale, differiti al ventisei susseguente, e di qui rimandati al trenta di settembre, perchè il governo cullavasi tuttavia nella illusione di poter riaprire le Camere pel venti dell’ ottobre consecutivo.
E mentre cominciavano a partire da Foggia anche le truppe di presidio, richiamate a Napoli ove vi era urgente bisogno di armati, con un contrordine ad horas furono queste costrette invece a rimanere, in vista dei fatti di rivolta che, con un crescendo spaventevole, si andavano verificando in tutta la Capitanata. Ed ecco che si vede ritornare a precipizio da Sansevero quel consigliere d’intendenza, ff. da sotto-intendente per mancanza del titolare, il foggiano signor Giuseppe Della Rocca, perchè messo fuori di residenza da quei dimostranti insieme al vescovo della diocesi monsignor La Scala, il quale, in atto di partire per Lucerà, suo paese nativo, riportava un colpo di fucile in un braccio. Ecco che a Lucerà si ordina ai pp. gesuiti, addetti alla cura del liceo, di partire immantinente, e sì attenta alla vita di quel maggiore Candida con pugnalate e con sevizie di ogni genere. Ecco che a Bovino si assale la guardia nazionale e la si disarma, spandendo ovunque il terrore. Ecco che fin sul cucuzzolo della montagna di Panni si avverano, fra quei montanari, tumulti e violenze da non si dire, nonché a S. Marco in Lamis, dove dei poveri musici foggiani, recatisi colà per la festa del Carmine, subirono la sorte di quei pifferi ormai famosi, che andarono per suonare e rimasero suonati: — venne loro in mente di metter fuori una bandiera tricolore, e si buscarono, per questo, una gragnuola di sassi, che per fortuna non bucò loro la pelle.
Il duca di Bagnoli era caduto così, come suol dirsi, dalla padella nella brace, e, in cerca di respiro da Foggia, ebbe a trovarsi, suo malgrado, nel folto dell’ agitazione. Di qui cercò svignarsela, rifugiandosi a Napoli; ma da Napoli, dopo qualche giorno, lo si vide riapparire a Bovino, restituitosi forse quivi per ordine del Ministero, donde, per altro, con telegramma In data del ventitre agosto, richiamò da Foggia tutta la sua gente di servizio, segno codesto di non volervi più tornare. E nello stesso giorno ventitre agosto la guardia nazionale di Castelluccio Valmaggiore tradusse al carcere di Foggia il prete Annibale Reale e suo fratello, ch’eran figli entrambi di un personaggio ben noto sotto il nomignolo di Mago, principali fautori della sommossa di Bovino, annunziandosi che moltissimi altri arrestati in quella città dovessero ivi giungere da un istante all’altro.
L’intendente, non avendo punto intenzione di muoversi da Bovino per tornare a Foggia, mandava di là i suoi messaggi; e, stante la destituzione avvenuta del ff. segretario generale Farchi, delegò il consigliere d’intendenza signor Pietro De Luca ad assumere le funzioni di quella carica, funzioni che dal Ministero furono poi tramutate presto in nomina effettiva, cui seguirono, con telegramma del ventisette agosto, le funzioni altresì addirittura d’intendente, dato l’ostinato allontanamento del titolare dalla residenza. Il De Luca ne fu oltremodo compiaciuto, e, nell’assumere le funzioni dell’alto grado, rivolse un saluto in istampa a tutt’ i suoi amministrati della provincia, fidando, per l’ordine pubblico, nel loro ben noto patriottismo.
La nostra guardia nazionale si spendeva intanto da sua parte per ogni verso, con tatto e con prudenza, a mantenere non turbato l’ordine pubblico e a incoraggiare specialmente i timidi, che, in tali contingenze, sono i primi a turbarlo, fantasticando spesso su di un nonnulla e gridando all’allarme per pericoli talvolta insussistenti e immaginarii.
Ma i liberali non si stancavano di lavorare e di affrettare anche coi loro sforzi il dì della redenzione, per lo che Pietro Ite Plato e Giovan Battista Postiglione presero il volo, l’uno per Napoli e P altro per Bari, allo scopo di tener vive le comunicazioni con quei comitati rivoluzionarli, mentre a Foggia, fra gli altri, monsignor Gherardo Santaniello, l’ex-scolopio Gabriele Cicella e p. Angelico de’ riformati da Sannicandro, entrambi questi ultimi condannati ai ferri pei fatti del 1848, e graziati, poco tempo prima, della pena che stavano scontando; nonché un suddiacono del Comune di Greci, che avea gittata la veste sacerdotale alle ortiche e portava, per un certo senso di vanità, i capelli inanellati e sfioccati al di dietro sulla nuca, ucciso poi nella rivolta di Ariano, si agitavano giorno e notte, con grandi e con piccoli, con ricchi e con poveri, con 1′ aiuto altresì del comitato di Azione, alla formazione di un governo provvisorio.
Il comitato dell’ Ordine di Napoli, che voleva evitare tale proclamazione in Capitanata sotto gli auspicii del comitato di Azione che infatti avea proseliti sine fine, inviò a Foggia il giovane avvocato Cesare de Martinis, oriundo di Cerignola, per impedirlo a tutto costo. Egli vi venne infatti, munito di molte commendatizie e di ben duemila ducati, datigli dal marchese D’Afflitto per conto dei comitato dell’ Ordine, e, mercè un lavoro davvero formidabile, che dovette ivi affrontare, riuscì finalmente nel suo intento, e il governo provvisorio non fu più proclamato. I danari servirono a far sbandare dalle file del maresciallo Flores parecchi ufficiali e soldati, dopo che l’intera somma era stata offerta da Achille de Martinis, padre di Cesare e sindaco di Cerignola, al primo, che la respinse sdegnosamente, dichiarando che non avrebbe mai portate le armi contro i patrioti, ma che non avrebbe, ad un tempo, permesso lo sbandamento della colonna da lui comandata, che infatti condusse quasi intatta fino ad Ariano.
Ma disgraziatamente in Foggia dietro la borghesia intelligente, elegante, veramente liberale e generosa, quella che rende amabile, direi, financo il vizio, pur troppo rattrovavasi la democrazia scamiciata, e, dietro di questa, la demagogia nuda, la canaglia addirittura, la quale, all’ombra della rivoluzione invadente, avea rizzato il capo anch’essa per affermare un simulacro di dominio, a solo scopo di trarne profitto a vantaggio suo e a disonore del paese. Cominciò quindi ad imporsi per ogni dove, estorquendo danaro, sotto false promesse o si-mulate minacce ai gonzi e agi’ imbecilli. Respice quid moneant leges, quid curia mandet, pronunziava un dì Giovenale col frizzo della satira sulle labbra; ed è questo un consiglio a cui ci adagiamo facilmente, perchè utile respingere qualunque freno, sebbene la giustizia ne soffra. Però la sua giornata finì presto : imitò essa l’asino cumano, che stette tre giorni vestito con la pelle del leone e facea paura a tutti, ma quando nel quarto dì venne scoperto da un lupo, patì giustamente la pena degli abusi commessi. Sono depredazioni disgustose che nelle rivoluzioni avvengono di leggieri anche in quei paesi dove non vi sia un vero canagliume, come quello accennato innanzi, ma sem-plicemente una classe di oziosi e di vagabondi proclivi al male, perchè dedicati ad una vita di ventura; onde ben disse un antico sapiente che l’uomo occupato è tentato da un demone solo, ma che 1′ ozioso è bersaglio di mille.
A razza di gente somigliante, dunque, apparteneva un tale, che, sotto ogni aspetto, giova dirlo l’ innominabile ma che era ben noto a Foggia sotto il nomignolo di figlio di Antonietta l’ ombréllaia. Costui, atteggiandosi a liberale per un modo di dire, ma essendo invece un fangoso del più putrido pantano, aspettò che il ventisette di agosto fosse tornato il marchese Orazio Cimaglia da Manfredonia, ove era andato a prendere scampo con la sua famiglia dopo le brutte ore toccategli quella sera in Foggia, secondo narrammo, e gli si presentò spavaldo come colui che ne tenesse in pugno le sorti, per chiedergli, con sfrontatezza da ribaldo, la somma di sessanta ducati, sotto minaccia di farlo immantinente ripartire. Il povero gentiluomo, timido qual’ era, vistosi bloccato in casa, non seppe opporre resistenza alcuna, e accontentò completamente quel manigoldo, da cui credeva davvero dipendesse ormai la vita o la morte dei signori , consegnandogli la somma richiesta. Ma, saputosi ciò dalla guardia nazionale, il sedicente liberale venne tosto scovato e costretto a restituire il pingue bottino, nonché a disvelare i suoi compagni di ventura, i quali subirono all’ istante una visita domiciliare, e furono assicurati tutti e deferiti al potere giudiziario.
La provincia di Capitanata fin dal diciassette agosto, giorno in cui scoppiava la rivoluzione a Corleto, cominciò man mano a divenir di brace anch’ essa, e l’incendio divampò finalmente in tal guisa che la truppa, mandata per domarlo, dovette ritrarsi a mezza via, ed il Flores, questo sincero ed antico appassionato di Casa Borbone, da Bari per raggiungere Ariano, ch’era tutta sollevata per volersi anche colà creare un governo provvisorio, dovette deviare con la sua colonna per Ordona e per altri paeselli sino a Bovino, donde solo potè proseguire a marcia forzata, su per la strada consolare. Ei non solo temeva a ragione le ostilità della cittadinanza foggiana, ma bensì dei dragoni, colà di presidio, che già erano stati guadagnati alla causa della libertà, tanto che questi, per voglia anch’essi di evitare un possibile conflitto, e ignari che il maresciallo avesse pensato da sé di evitare Foggia, si allontanarono quel dì dalla città, facendo credere che partissero per la volta di Salerno, ciò che non era affatto vero, perchè riducevansi invece a Candela.
Gli stemmi del Borbone dai gigli di argento erano già annientati ovunque, e un forte battaglione di volontarii, capitanati da Antonio Gargea, un condannato politico, uscito allora allora dalla galera per l’ultimo indulto sovrano, correva alle spalle del Flores per combattere la reazione in provincia di Avellino.
Ma ecco che la fulgida stella d’Italia appare finalmente sull’ orizzonte delle nostre provincie. Ecco che Francesco II, abbandonato dai suoi più fidi, risolve di lasciar Napoli in forza di una capitolazione diplomatica, com’ ebbe a dire egli stesso, e di ritrarsi a Gaeta per la difesa dei suoi dritti. Ecco che con un proclama al popolo, destituito ormai d’ogni’palpito per la Casa Borbone, dà egli l’ultimo addio, pur mostrando di avere speranza di ritornare sul trono dei suoi maggiori, se un dì, vicino o lontano, la giustizia di Dio lo avesse mai permesso. Ecco che Liborio Romano, lo stesso giorno in cui Francesco esce da Napoli, spedisce, in nome del Ministero, un indirizzo al dittatore delle due Sicilie, trasmettendo nelle mani di # lui il potere del suo re, ch’egli stesso detronizzava, e lo invita ad entrare in Napoli per salutarlo redentore d’Italia. Peccato, si esclamò da taluno, che nella storia dei popoli il Tabor non preceda il Calvario, bensì venga dopo molti Calvarii. L’ora della trasfigurazione, insomma, giunse finalmente, ed allora le vesti addivennero non già candide come neve alpina, ma rosse come di vendicato sangue; e questa trasfigurazione fu ed è simboleggiata in un nome: Garibaldi!
Nel mezzodì del sette settembre questi, senza apparato di truppe, ma soltanto in compagnia di Cosenz e di cinque ufficiali dello stato maggiore, entra alla pur fine nella bella Partenope, ove nei castelli e nelle caserme vi erano ancora i soldati borbonici, come, alla Granguardia, i bavaresi.
E là, sul balcone centrale del palazzo della Foristeria, là vien baciato dal generale Mariano d’Ayala, che gli dice : « Questo bacio è il bacio di cinquecentomila abitanti».
Ma in quel bacio, ch’era simbolo di gratitudine e di fede, in quel bacio ben si confondevano con le labbra dei napole¬oni le labbra di altri mille e mille di tutte le città sorelle, quali schiavi disciolti da pesanti catene, che, con gli occhi pregni di gioia, venivano a prostrarsi innanzi alla luce irra-diatrice di nuova vita.
Oh Foggia allora, la nostra città, sì avvilita, sì bistrat¬tata, sì ammiserita, non fu l’ultima, tra le altre, in mandare al dittatore il suo caldo bacio di entusiasmo e di amore, essa che pur rappresentava il capoluogo di una regione, orgogliosa di avere, in tempi non men tirannici e feroci, fecondata nel suo materno grembo la mente sovrana di Pietro Giannone, il quale, sfidando ogni giogo da riempire di sé l’universo, concepiva con liberi sensi quei due. monumenti di stupefaciente sapienza, e che vivranno quando il mondo lontano: la Storia civile del regno di Napoli ed il Triregno. E la si vide delirante nella grande maggioranza dei suoi figli, delle sue donne, dei suoi sacerdoti. Pòchi di essi non ebbero a fregiarsi del simpatico nastro tricolore, pochi xìi essi non ebbero ad emettere dai loro petti il fatidico grido : « Viva Giuseppe Garibaldi ! Viva Vitto¬rio Emmanuele.! », che unanime elevavasj come un inno dal glauco mare alle vette rocciose. Come per incanto si strinsero in idillico amplesso e patrizii e borghesi e operai e contadini e sin preti e frati, e tutti tutti, con fasce dai colori nazionali a tracòllo o alla cintola, si videro in giro per la città, festanti al santo giorno di libertà e di riscatto. Ed ecco, tra’ primi, tra’ postanti, convinti e inflessibili liberali foggiani, i cui nomi è inutile più qui ripetere, essendo ormai già noti, ecco dallo stesso grembo del clero Gherardo Santaniello, in una carrozza protetta dal tricolore, quasi sconvolto dalla piena dell’entu¬siasmo, cui seguono i sacerdoti Scelsa, Padalino, Rotundo, Zam-marano, Del Giudice e i pp. scolopii, che inalberano con ànimo lieto anch’essi il labaro tricolore come emblema di vita nuova, guadagnata a prezzo di sangue, vita, preparata, dischiusa, sorrisa pur da Colui che tutto muove. E questi non sono i soli, che là, nell’ atto che altri dimostranti si raccolgono sotto le misere finestrette degli alcanterini, chiedendo a squarciagola di voler vedere sventolare sul silente cenobio il trionfante simbolo del riscatto, là il p. Massimo, in mezzo al serto dei suoi religiosi, anch’essi plaudenti, tolse dal coro, in mancanza di un drappo tricolore, il crocifisso, e, fattosi alla veranda con questo santo vessillo di amore tra mano, dominando con la sua voce ogni clamore dalla via, esclamò, fra l’unanime commozione : « ecco, o fratelli, la nostra bandiera, quella che redense i popoli della terra ; è con essa che vi benedico ».
E mentre, tra gli stemmi abbassati del Borbone, il più gran fermento dominava la piazza, ritornarono, il nove di settembre, da Candela i due squadroni dei dragoni, già in precedenza guadagnati alla santa causa, e che, ad evitare il Flores e la colonna dei suoi fidi, marcianti da Bari su Avellino, si erano per prudenza allontanati nei giorni scorsi dalla città, e Foggia seppe rendere a codesti spontanei soldati della nuova fede il dovuto omaggio, decretando loro il trionfo.
XV.
Il dì 11 di settembre 1860 pervennero a Foggia i primi decreti del dittatore. Egli, che avea rivolto nel primo momento il suo pensiero alla Marina, in testimonio della sua fede verso Vittorio Emmanuele, decretando che le navi da guerra, appartenenti alle due Sicilie, fossero aggregate alla squadra del re d’ Italia sotto il comando dell’ammiraglio Persano, formò presto, pel reggimento dello Stato, il nuovo Ministero con Liborio Romano alla presidenza, e mise Andrea Colonna a capo della rappresentanza civica napoletana, di cui fu chiamato a far parte altresì il nostro Saverio Altamura, scampato dalla morte per opera del conte di Aquila, che lo avea fatto fuggire, e rimasto sino allora in esilio, donde era finalmente ritornato.
Ma, dopo ciò, i primi decreti pubblicatisi in Foggia ed affissi alle cantonate per universale scienza e governo, emessi in data del nove settembre, furono i seguenti : Che gli editti, le sentenze ed ogni atto pubblico e notarile s’intitolassero nel nome di Vittorio Emmanuele II, re d’Italia; — Che i sigilli dello Stato fossero muniti dello stemma di Casa Savoia; — Che i funzionarii, tranne pochi licenziati, rimanessero ai loro pòsti, a condizione soltanto che facciano adesione al nuovo regime ; — Che non possano cumularsi diversi impieghi nella stessa persona, dandosi all’ uopo cinque giorni agl’interessati per la scelta di quello che si voglia conservare; — Che si riconosce e si fa proprio del nuovo Stato il debito pubblico, come si riconosce del pari il Banco e la Cassa di sconto; — Che lo Statuto del regno sardo va promulgato come legge fondamentale del nuovo Stato d’Italia.
A questi decreti di carattere unificatore tennero dietro molti altri, tra’quali quelli riguardanti: l’abolizione dell’Ordine dei gesuiti; la inversione dei beni delle mense vescovili ed arcivescovili in nazionali; l’abolizione del lotto qual giuoco immorale, facendosene continuare però l’immoralità fino al prossimo primo gennaio; — l’interdizione delle sepolture gentilizie;— la liberazione dei piccoli pegni fino alla concorrenza di tre ducati ; — la istituzione dei giurati nei giudizii criminali ; ed altri di minor conto, che, in verità, produssero, al semplice annunzio, la più soddisfacente impressione in tutti coloro, che mostravano da tempo immemorabile di aver sete di leggi inspirate a ragioni di giustizia e di umanità.
Ma quando il nostro Luigi Zuppetta, riscattato al suo lungo esilio, tornò il sedici di settembre in Napoli, e volle il ven¬tuno seguente vedere al palazzo d’Angri il dittatore, presen-tandoglisì a capo d’una deputazione, composta di uomini pe’ quali il passato rispondeva all’avvenire, e gli parlò con lealtà e franchezza intorno alle insidie che gli tendeva la camarilla cavourriana, Garibaldi ne rimase sorpreso e compiaciuto a segno che si decise di decretare la caduta del Ministero e di affidare a lui l’incarico di ricomporlo. Il Zuppetta declinò l’onorevole mandato, adducendo all’uopo le sue buone ragioni; e fu allora che al posto del Romano, — la cui aura di popolarità era già di molto scemata (1), perchè se può piacere a tutti
(1) A queir epoca, per irridere al Romano, si andava cantando, per le vie di Napoli :
II ministro D. Liborio
Coti FARINA, FORTE e MELE Fé’ il governo provvisorio
Per Vittorio Emmanuele.
L’epigramma era racchiuso nelle tre parole, che avevano un senso anfibologico, ri¬cordando Farina, l’antico prefetto di polizia, Forte, il patriota Carmine Antonio, e Mele, un delegato di P. S. assai intimo di lui,—un arcobaleno insomma.
il tradimento, certo non piace il traditore, il quale, presto o tardi, cade sempre nel disgusto e nell’oblio — venne prescelto Raffaele Conforti, nell’ intendimento però che il Zuppetta facesse parte della nuova combinazione come semplice ministro. Ma anche a questo egli si rifiutò, preferendo di rimanere, con rara modestia, semplice spirito animatore del partito di azione, trasformatosi poscia, col fondersi con quello dell’ordine, nel grande comitato unitario nazionale, voluto da Garibaldi, e che rese non pochi servigi alla nazione. Che anzi, in prosieguo, ei finì col rinunziare persino al mandato politico, reiteratamente affidatogli dal collegio di Sansevero, per dedicarsi, invece, alla scuola, ove, servendomi della frase nobilissima di Enrico Pessina, « visse con i giovani nello spirito vivo, ringiovanito di quella santa fraternità dell’ animo, che ne fa della scuola un tempio perennemente vivo di fede e di amore».
Il detronizzato re di Napoli volle fare, intanto, l’ultimo suo sforzo con i suoi cinquantamila uomini dietro il Volturno per riprendere il trono perduto ; ma allora giovani d’ogni parte corsero ad arruolarsi sotto le bandiere garibaldine, e Foggia fu destinata a centro di arruolamento. All’uopo si era installato un ufficio con a capo un maggiore, venuto appositamente da Napoli; e, sebbene lo spettacolo dei parenti, che si vedevano abbandonati dai loro cari, era triste e lacrimoso, pure tanti giovani baldi ed arditi espandevano intorno, col loro entusiasmo, una nota gaia e festosa. A dar loro alloggio non bastarono le caserme ; sicché si dovette cedere dal municipio il palazzo di s. Domenico, sede del seminario diocesano, «he per le ferie autunnali trovavasi libero e vuoto. Ciò, in vero, spiacque non poco agl’intransigenti, che per lo meno gridarono allo scandalo quando, fra l’altro, ne videro ai balconi affacciarsi non solo i garibaldini, ma, una volta tra essi, una femmina da trapazzo, tal Filomena Pepe, ben nota ai nottamboli del luogo.
Nelle prime ore del ventotto settembre altri settecento volontari del litorale calabrese e pugliese, sbarcati a Manfredonia, fecero, in completo assetto di guerra, un’entrata veramente clamorosa in Foggia, perchè furono accolti sin fuori 1′ abitato da una calca di gente, che si serrò loro d’intorno lungo il tragitto sino al quartiere, quasi in preda a delirio. Con essi giunsero parecchi sacerdoti, che sulle nere vesti talari indossa vano del pari le camicie rosse; e, tra questi, spiccava un francescano dalla lunga barba e da’ mustacchi nerissimi, che sulla tunica garibaldina serbava ancora stretto ai lombi il cingolo del poverello di Assisi, a cui erano assicurati un paio di pistole e il cangiarro. Questi, prima di ripartire per alla volta di Napoli con i suoi compagni d’arme, volle recarsi al tempio della Icone, ove celebrò messa.
Con decreto del diciassette settembre fu nominato il nuovo intendente, che assumeva allora il nome di governatore, nella persona di Giuseppe Ricciardi, conte dei Camaldoli ; ma, per quanto i foggiani esultassero nel vedere elevato a tale ufficio un loro stimato concittadino, che sì per i precedenti politici, che per i meriti personali meritava la fiducia del dittatore, pure dovettero dappoi rassegnarsi alla delusione, apprendendo che il Ricciardi non aveva accettato. Sicché continuò a rimanere tuttavia in carica il consigliere De Luca, zelantissimo sempre nel disimpegno di così delicate funzioni. E fu lui che comunicava al pubblico foggiano il diciassette settembre il decreto del dittatore, con cui veniva diminuito il prezzo del sale da grana otto a grana sei il rotolo; fu lui che mandò appor siti corrieri in tutt’ i paesi della provincia per la pronta esecuzione di esso. Fu lui altresì, in adempimento di superiori disposizioni per evitare possibili moti mazziniani e garibaldini, tendenti alla non annessione del Napoletano al resto d’Italia se non condizionata alla redenzione di Roma, proibiva, con manifesto a stampa, gli assembramenti di popolo sulle vie, non potendo riunirsi se non appena in cinque persone, e proibiva altresì ogni ulteriore esposizione di lumi e di bandiere ai balconi e alle finestre, come ogni schiamazzo o dimostrazione, sotto pena d’immediato arresto pei contravventori, oltre alle altre da comminarsi dalla giustizia militare. Per lo che fin dalla sera del diciassette settembre, dopo che il p. Domenico da Sannicandro ebbe arringato pure una volta al popolo foggiano in forma estremamente rivoluzionaria, si eseguiva a rigore la suddetta decretazione, raddoppiandosi le pattuglie per le vie e dalla guardia nazionale e dai dragoni a cavallo.
Il dì ventisei di settembre, dopo che la milizia nazionale, come già avevano fatto tutt’ i funzionarli residenti in Foggia, ebbe prestato, al largo Gesù e Mari», giuramento di fedeltà a Vittorio Emmanuele innanzi al colonnello del reggimento dei dragoni, che fungeva provvisoriamente da comandante della provincia, giunse il nuovo governatore, signor Gaetano Del Giudice da Piedimonte di Alife. Molti gentiluomini, in eleganti equipaggi, furono ad incontrarlo sin fuori le porte della città di unita alla rappresentanza comunale, coi quali il governatore, venuto da Napoli in compagnia del sindaco, volle, prima di condursi al palazzo del governo, visitare il tempio della Icona-etere, come avevano sempre fatto i suoi antecessori, e dove fu ricevuto da tre dignitarii del Capitolo all’ uopo deputati. Lo stesso giorno giunse altresì il segretario generale signor Costantino Aolisio, marchese di Garigliano ; sicché, la sera, tutte insieme queste autorità, con altre ulteriori, e civili e militari, furono a banchetto presso il nuovo capo della provincia.
L’ annessione delle Marche e dell’ Umbria era già un fatto compiuto, e Vittorio Emmanuele, prima di passare il Tronto e di marciare col Devincenzi e col Tommasi verso gli Abruzzi, aveva diretto da Ancona agi’ italiani questo proclama :
« La caduta del governo di Napoli conferma quello che il mio cuore sapeva, cioè quanto sia necessario ai re l’amore, ai governi la stima dei popoli. Nelle due Sicilie il nuovo reggimento s’inaugura col mio nome. Ma alcuni atti diedero a temere che non bene s’interpetrasse quella politica che dal mio nome è rappresentata. Tutta Italia ha temuto che all’ ombra di una gloriosa popolarità, di una probità antica, tentasse di riannodarsi una frazione pronta a sacrificare il vicino trionfo nazionale alla chimera di un ambizioso fanatismo. Tutti gl’italiani si sono rivolti a me perchè scongiurassi questo pericolo. Era mio obbligo di farlo, perchè nell’ attuale condizione di cose non sarebbe moderazione, non sarebbe senno, ma fiacchezza ed imprudenza il non assumere con mano franca la condizione del moto nazionale, del quale sono responsabile innanzi all’ Europa. Ho fatto entrare i miei soldati nelle Marche e nell’ Umbria, disperdendo quell’ accozzaglia di gente di ogni paese e di ogni lingua, che qui s’ era raccolta, nuova e strana, forma d’intervento straniero, e la peggiore di tutte. Io ho pro¬clamato l’Italia degl’ italiani, e non permetterò mai che l’Italia diventi il nido di sette cosmopolite, che ci si raccolgono a tramare i disegni o della reazione o della demagogia universale. »
La notizia ai foggiani dell’ annessione delle Marche e dell’ Umbria, con la comunicazione di questo proclama, fu il primo atto solenne che il governatore Del Giudice ebbe a compiere il dì ventinove settembre, nell’ esercizio del suo nuovo ministerio, e che provocò nella cittadinanza la più sincera manifestazione di gaudio, erompendo spontaneo da ogni petto 1′ entusiastico grido di Viva il re galantuomo.La dimane doveva intanto festeggiarsi ufficialmente tale avvenimento, per lo che il Del Giudice fu sollecito, fin dalgiorno innanzi, di darne conoscenza al vescovo monsignor Frascolla, che trovavasi ad Andria, invitandolo a venire in residenza, o per lo meno ad autorizzare il Capitolo a prestars iper tale funzione. Ma il vescovo, in mezzo alla generale sorpresa, gli rispose recisamente di non potere affatto aderire a tale domanda, ma che anzi facea voto che i preti, i quali per avventura prendessero parte a tale funzione, sarebbero stati immantinente sospesi a divinis, e che i chierici avrebbero perduto il colletto, come del pari la chiesa, che fosse prescelta ed adibita a tale scopo, sarebbe rimasta issofatto interdetta. Irritatosi di ciò il governatore, dovè battere altra via per raggiungere l’intento e, misosi perciò di accordo col sindaco,dispose che la festa per la vittoria dell’ annessione delle Marche e dell’ Umbria, nonché per la pubblica benedizione da farsi alla bandiera nazionale, già sventolante da un capo all’ altro d’Italia su fortezze di principi caduti e detronizzati, si tenesse nella chiesa di s. Domenico, appartenente al seminario, la quale,se mai fosse stata interdetta, sarebbe rimasta chiusa al vescovo medesimo, e si officiasse quivi altresì, anzi che dal tricorno, dai , frati cappuccini, non soggetti per nulla alla giurisdizione di lui. Ed il dì trenta di settembre, con ogni solennità e con concorso di autorità e di pubblico, la sacra funzione ebbe luogo secondo erasi stabilito. Celebrò il p. Giammaria da S. Marco la Catola, con l’assistenza di p. Urbano e di p. Michele Maria da Sansevero, il primo dei quali pronunziò anche un discorso eloquentissimo, inspirato a sensi di schietto e profondo patriottismo. Furono estratti quattro maritaggi, di ducati trenta ognuno, per altrettante fanciulle del popolo, mentre già al palazzo comunale venivano distribuiti mille pani ai poveri e quindici vestiti a lavorieri, che mostravano quasi nude le carni. La bella festa terminò con sfarzose luminarie e con inni patriottici, suonati dalle musiche cittadine.
E quando poi il primo re d’Italia, passato il Rubicone meridionale, il Tronto, entrava negli Abruzzi tra gli osanna di quelle buone e generose popolazioni, e, traversate sul suo cavallo arabo, nelle sembianze di vecchio amico, le città di Teramo, di Chieti, di Solmona, d’Isernia, di Venafro, s’incontrava a Teano con Giuseppe Garibaldi per dare sul Volturno l’ultimo crollo alla dinastia borbonica, a Foggia il governatore Del Giudice, levandosi in piedi a teatro, nel suo palchetto di seconda fila, in mezzo al silenzio generale lesse il telegramma originale che gli comunicava tale fausta notizia, alle cui ultime parole scoppiò tale un uragano di applausi e di grida esultanti, che lo spettacolo non potette più aver fine.
L’Italia era fatta e non rimaneva che la consacrazione ufficiale per parte dei popoli tutti col plebiscito, allorché incominciò un periodo di reazione ad opera di coloro che erano ancora rimasti ligi all’ antico reame, specialmente in Capitanata, ove insorsero Orsara, Greci, Biccari, Rodi, Vico, Roseto, Orta, Accadia, Bovino, e, con vera ferocia, S. Marco in Lamis e S. Giovanni Rotondo, tanto che parecchi drappelli della guardia nazionale di Foggia dovettero in un primo momento accorrere in questi due ultimi paesi del Gargano per sedare la rivolta, essendosi osato fìnanco di disarmare colà le guardie locali.
Il governatore, vigile custode dell’ordine pubblico, si centuplicava da mane a sera per dare disposizioni al riguardo, e per far sì che le diverse sommosse fossero soffocate nel loro, inizio ; per lo che in ognuno di questi focolari si riuscì ad arrestare i più audaci, che a frotte furono menati a Foggia e tradotti al carcere centrale, mentre, d’ altra parte, giungevano ad un tempo dal Piemonte reggimenti su reggimenti, che con i loro cannoni, sbarcati a Manfredonia, andavano a Napoli, inneggiando ai novelli albori.
Accentuatasi in un secondo momento la reazione in modo incredibile a S. Marco in Lamis e a S. Giovanni Rotondo, il governatore fu costretto a mandare colà un buon nerbo di bersaglieri e di volontarii garibaldini, muniti di obici, fatti venire appositamente dal castello di Barletta, per domare così pure una volta le due cittadine ribelli. Per facilitare i partenti si fecero in Foggia e dintorni complete razzie di carretti, di carrozze e di cavalli, per lo che essa ebbe presto ad assumere, nelle sue vie, spoglie e silenti, le sembianze di una città morta.
L’eco delle stragi, degl’incendi!, degli eccidii, commessi dai montanari reazionarii contro i liberali e la pubblica forza, non tardò a giungere nel capoluogo, e molti cominciarono allora veramente a trepidare sulla sorte dei loro cari, che in gran numero trovavansi colà a combattere sotto la simpatica ed elettrizzante camicia rossa. Il sangue corse a rivoli per le strade aspre e scoscese, disseminandosi ovunque la morte più straziante ed orrorosa. Vuoisi che a S. Giovanni i rivoltosi abbiano fucilati ventiquattro loro concittadini di specchiata probità, con averli prima imprigionati e poi, a traverso i cancelli, con più sicuro bersaglio, li abbiano crivellati di ferite. E in tutti due i paesi, non appena giunsero da Foggia i bersaglieri e i garibaldini, la ferocia montanara ebbe a manifestarsi anche mercè l’ausilio dei vecchi e delle donne, che gittavano su di essi, dalle finestre e dai balconi delle loro case, sassi, suppellettili e fin vasi e caldaie di olio bollente. Di tale rivolta ricordo ancora i minuti particolari, che appresi io stesso da testimoni oculari, e che ripeterò qui di volo.Infatti il piccolo paese — mi si diceva — era in uno stato da mettere veramente i brividi, e salì in furore per causa di un decreto del ministro Cavour, riguardante gli sbandati dell’ esercito borbonico, i quali avrebbero dovuto riprendere servizio in quello italiano. Ciò avea destato profondo malumore in molti giovani, i quali non volevano a tutto costo indossare la nuova divisa militare. E parecchi di essi appartenevano a famiglie nobili e ricche del luogo, ai quali si era unito un tal Francesco Cascavilla, figlio di un notaio, tipo strano ed avventato, già sotto-ufficiale dei Borboni in Sicilia, e che del pari non intendeva riprendere le armi in servizio del paese. L’arresto fatto dalla polizia di uno di codesti sbandati, che, infermo, giaceva a letto, fu come la favilla che suscitò il gran fuoco : i giovani tutti scapparono dal paese in campagna, dove la guardia nazionale venne a dar loro la caccia. Ma una domenica, rientrarono alla spicciolata in S. Giovanni, dandosi la posta nella chiesa maggiore, dove stava per celebrarsi la messa, frammischiandosi ai contadini, ch’erano ivi assiepati. Riconosciuti il Cascavilla e gli altri fuggiaschi dai loro concittadini, si cominciò ad espandere nella chiesa un mormorio come di tempesta vicina, che mise in apprensione il sacerdote, il quale avea cominciato a celebrare e si meravigliava come i fedeli assistessero quel dì con poca devozione al sacrificio della messa. Ma quando egli ebbe per la prima volta, con un Domine vobiscum a volgersi inverso la folla, sentì corrersi un brividio giù per le reni, scoprendo a sé vicino, inviluppato e mezzo nascosto in un gran mantello a ruota, il Cascavilla, che doveva certo tramare qualche cosa d’inusitato e di sinistro. Alla fine della lettura dell’ evangelio, costui si aperse al pubblico, e, levando in alto una mano, gridò : « Sacerdote, intuona il Te Deum in onore del nostro re Francesco II ». Il povero prete ebbe a provare come l’impressione di una mannaia sul collo, e allibì, mentre allibivano con lui tutt’ i fedeli, i quali sorsero in piedi, non sapendo che cosa avvenisse. Dopo un minuto di silenzio sepolcrale il Cascavilla ripetè l’intimazione con voce più forte e con puntare contro il prete la canna di un fucile. Fu questo l’argomento decisivo, pel quale il sacerdote celebrante, senza più voltarsi addietro, intuonò il Te Deum, cui, suggestionato, rispose in coro tutto il popolo che trovavasi in chiesa. Usciti di là, i contadini corsero ad armarsi chi di falce, chi di scure, chi di fucile, e tutti, con un sol pensiero, dettero addosso alla guardia nazionale, che venne disarmata e messa al bando dal paese. Fatto ciò, si dettero a prendere di assalto le case dei signori, i quali, ligati come agnellini da macello, furono trascinati al carcere, donde liberarono lo sbandato che, giorni prima, vi era stato rinchiuso dalla polizia. Sorsero allora, da per ogni dove, ritratti di Francesco II, che si rizzarono al posto di quelli del re Vittorio Emmanuele e dei rr. di Savoia, e davanti vi si accessero torchi e candele a cera. La reazione dilagò in un baleno per ogni classe, nessuna esclusa, e tutti s’improvvisarono difensori del paese, contro cui già vedevansi lanciati da Foggia bersaglieri e garibaldini ad assediarlo. Preti e frati erano intanto confusi in gran copia con gli assedianti, e tra questi ebbe a scorgersi un certo frate Domenico, agostiniano, che dall’esterno delle mura additava ai cittadini le piaghe sanguinanti di un grosso Cristo che inalberava, esortandoli in nome di Lui ad aprir loro le porte, e promettendo amnistia e perdono. La resistenza di quei montanari durò per ben otto giorni; ma, annientate finalmente le porte, ancor più feroce fu la lotta per le vie, dalle finestre, nelle case, presso le botteghe: — S. Giovanni Rotondo era diventato un inferno. E fu allora che avvenne nel carcere una carneficina, come già dicemmo, in persona di quei signori, che erano stati ivi trascinati, e che, sentendo il paese già nelle mani della forza, aveano ripreso lena col tirare un colpo di rivoltella contro uno dei rivoltosi. I lamenti dei feriti e lo strazio dei moribondi aggiungevano terrore a terrore, mentre il loro sangue innocente scorreva per le vie quasi chiedendo vendetta. E fu allora che frate Domenico entrava con la croce in mano, gridando : « pace, pace, pace !.. »
La rivolta, con grande sacrifizio di vittime, fu finalmente sedata in quei due bellicosi paesi del Gargano, sospingendosi anche questa volta nelle carceri di Foggia buona parte della selvaggia schiera, quella che non aveva più trovato posto nelle prigioni locali. E qui è d’uopo dire che in tale occasione fu buccinato che il popolo di S. Marco in Lamis abbia ceduto alle armi con un certo convenio, di pagarsi cioè ducati seimila come spese di guerra per una metà dai proprietarii e per una metà dal clero, restandone esonerati tutti gli altri cittadini.
Saputasi dal governatore la resa di S. Marco e di S. Giovanni, ei volle partire tosto in compagnia del procuratore generale, venuto appositamente da Lucerà, e di due ufficiali della guardia nazionale alla volta di S. Giovanni, per costituire colà il consiglio di guerra e procedere ai relativi giudizii. All’ uopo furono destinati due ufficiali della guardia nazionale di Foggia, avvocati Giuseppe Raho ed Alfonso Festa, come difensori ufficiosi di tutti gì’ imputati.
Dopo pochi giorni il Consiglio di guerra espletò il suo compito, pronunziando tredici condanne a morte col mezzo della fucilazione da eseguirsi nel termine di dieci ore, sei condanne alla pena di diciotto anni di ferri, oltre al solidale rifacimento, per tutti codesti diciannove, dei danni e delle spese del giudizio, nonché alla malleveria, per i sei ultimi, di ducati mille durante otto anni, mentre moltissimi altri rivoltosi furono ritenuti in carcere per più ampia istruzione del processo, da compiersi tra sei mesi.
XVI.
Il plebiscito per le provincie continentali dell’ Italia meridionale fu fissato dal dittatore pel giorno ventuno di ottobre. Il popolo, riunito in comizii, doveva accettare o rigettare, con un sì o con un no, questa formola che gli veniva proposta : Il popolo vuole l’ Italia una ed indivisibile sotto lo scettro del re costituzionale Vittorio Emmanuele e suoi legittimi discendenti e, a questo proposito, è bene far notare che tale formola fu dovuta all’ Associazione Unitaria nazionale, inspirata appunto dal nostro Luigi Zuppetta, il quale, a salvare la dignità del paese, impediva che si adottasse invece la formola di annessione incondizionata al Piemonte, voluta dal Pallavicino e dai cavourriani in genere, da cui traspariva il concetto che. le provincie tutte italiane si piemontizassero, mentre il Piemonte, primeggiando fra tutte, non veniva a italianizzarsi.
Il voto, dunque, col semplice monosillabo affermativo o negativo sarebbe stato dato a mezzo di una scheda stampata e raccolta in tutti i Comuni da apposite Giunte, composte del sindaco, del Decurionato e dell’ufficiale comandante della guardia nazionale.
All’ uopo fin dal 17 ottobre ’60 furono, affisse al pubblico in Foggia le liste di coloro, dagli anni ventuno in sopra, che avrebbero dovuto intervenire la domenica successiva nella chiesa di s. Domenico, destinata appunto come sede del comizio pel plebiscito. E, nelle sere del diciotto e del diciannove, il p. Boccaccini delle scuole pie prese a spiegare alle masse, in due diverse pubbliche sale, il valore di quel sì, che doeasi per voto generale deporre nell’ urna, e che già da parecchi giorni si vedea dalle moltitudini portare impresso, a lettere cubitali, su cartellini attaccati ai berretti e ai cappelli.
Il giorno della votazione in s. Domenico, a norma delle istruzioni regolamentari, presiedeva il comizio il sindaco di Foggia, marchese Saverio Salerni di Rose, assistito dal Decurionato, prendendo posto innanzi ad un grosso tavolo, suvvi, del quale eran deposte tre cassette di legno : in una vi erano le schede col sì ; in un’ altra quelle col no ; e, in mezzo ad entrambe, vedevasi collocata la terza cassetta vuota, in cui ognuno che entrava nella sala, munito di tessera, deponeva o l’ una o l’altra scheda, che veniva togliendo dalle rispettive cassette. L’operazione, durata sin quasi la mezzanotte, fu ripresa l’indomani, quand’ebbe fine; ma la cassetta dei no rimase totalmente vergine, perchè nessuno osò porvi entro la mano, neanche—ed è quanto dire — gli ecclesiastici, ch’eran quasi al completo, se ne togli il ff. vicario del vescovo, Antonio Romito, che avea dichiarato dì astenersi dal voto.
All’ apertura di tutte le cassette dei diversi Comuni della provincia, avvenuta, secondo altro decreto del dittatore, il ventinove di ottobre alla presenza del governatore e con l’intervento di tutt’ i sindaci e comandanti delle guardie nazionali locali, nonché del presidente e del procuratore generale della Corte criminale, e, a compiuto scrutinio, venne constatato, ad orgoglio della nostra contrada, la unanimità del voto affermativo, meno pei Comuni di Poggio Imperiale e di Lesina, ove soli trenta voti circa, per ciascuno di essi, furono favorevoli, mentre gli altri riescivano contrarli. Insomma il risultato della votazione di tutta la provincia, spedito a Napoli al presidente della Corte suprema di giustizia a norma del decreto del dittatore, fu di voti 54256 affermativi e di 996 negativi, mancando solamente i voti di S. Marco in Lamis e di S. Giovanni Rotondo, ove quei cittadini si rifiutarono addirittura di votare. Magni-fico contingente codesto, dato dalla Capitanata al generale plebiscito, che nella sua totalità ebbe a raggiungere il numero di 1303064 voti affermativi e di soli 10312 negativi.
Foggia esultò per tale risultato, e manifestò questa sua intima e sincera soddisfazione a mezzodì pubbliche dimostrazioni, cui parteciparono anche parecchie gentili signore foggiane, che presero graziosamente a sventolare bandiere tricolori sulle piazze, al grido entusiastico di « viva Vittorio Emmanuele, viva l’Italia una e indipendente », tra le quali mi piace additare in queste pagine, a titolo di onore, le signore Marianna Gissi De Chiara e Lucia Salerai Rosati, consorte del sindaco marchese di Rose. Venne così, mercè loro, ad allargarsi sul grigio uniforme delle politiche dimostrazioni il lume di un sorriso, che sempre allieta e consola. E Foggia contemplò questo spettacolo di non bugiarda esultanza delle classi più scelte cittadine, come colei che contempla in una festa sontuosa l’adorna, gaia e schietta bellezza dei suoi giovani figli.
Gli ultimi spaldi della fortezza di Capua erano finalmente caduti come fulminati dal piombo italiano, e, occupatasi la piazza, ben settemila soldati ne uscirono, deponendo per sempre quelle armi, che avevano adoperate in difesa di una Casa, già da tempo condannata ad inabissare. Tale impresa di suprema importanza venne annunziata da Napoli con telegramma al governatore Del Giudice, che ne dette, con manifesti a stampa, sollecita comunicazione ai suoi amministrati. Il popolo foggiano, affasciatosi con affetto spontaneo alla grande massa dei garibaldini, che formicolavano dappertutto, e preceduto dalla banda municipale cittadina, con bandiere tricolori tra mano, circolò tutto il dì per la città, riempendo ogni angolo delle sue grida di gioia. JP. Urbano da S. Marco in Lamis, frate cappuccino, asceso su d’una panca in piazza Portareale, fece ivi sostare il corteo, e, con parola infiammata, eccitò gli animi in commentare poeticamente quest’ ultima vittoria delle armi italiane.
E l’entusiasmo dei foggiani non ebbe più limite quando si vide dappoi affìsso sulle mura della città l’ ulteriore proclama che Vittorio Emmanuele indirizzava da Sessa al popolo napoletano prima di entrare nella loro metropoli, proclama che la storia incise a caratteri di oro nelle sue eterne pagine, e che fa fremere di viva commozione anche i tardi nepoti. « Il suffragio universale mi dà la potestà sovrana di queste nobili Provincie — ivi si leggeva.—Accetto l’alto decreto della volontà nazionale non per ambizione di regno, ma per coscienza d’italiano. Crescono i miei, crescono i doveri di tutt’i figli d’Italia, e son più che mai necessarie la sincera concordia, l’abnegazione costante. Tutt’i partiti si debbono inchinare innanzi alla maestà dell’Italia, che Dio vuole libera e indipendente ».
Il primo re d’Italia, così manifestando i suoi intimi sentimenti d’italianità e di benessere sociale, entrava in Napoli alle dieci del mattino del 7 novembre 1860, avente a fianco in carrozza Giuseppe Garibaldi nella sua tradizionale camicia fiammante, e varcava la soglia di quel palazzo, eh’ era stato; sino allora fucina di odii e di sopraffazioni disumane. Là il dittatore gli presentava i plebisciti delle due Sicilie, là il ministro Conforti gli soggiungeva riverente : « Il popolo napoletano, raccolto nei comizii, ad immensa maggioranza, Sire, vi ha proclamato suo re. Nove milioni d’italiani si uniscono alle altre Provincie, rette da V. M. con tanta sapienza, ond’ è avvenuta la vostra solenne promessa che l’Italia deve essere degl’ italiani ». Là il re, con una forte stretta di mano a Garibaldi e a Conforti, suggellò la sua fede all’unità italiana, alla consacrazione del diritto nuovo, che additavasi dalla volontà del popolo.
Foggia, ad onta di un tempo piovoso e di un vento assai molesto, solennizzò lo stesso dì il grande avvenimento con pompa solenne nella cattedrale, ove monsignor Gherardo Santaniello, il dicitore modello, l’ arbiter elegantiarum, pronunziava uno dei suoi discorsi, pregni di dottrina e di fascino artistico , che mandò in visibilio l’ uditorio (1), mentre in città il popolo d’ogni ceto arse, in qualsiasi forma, i suoi turiboli al comune tripudio. Il governatore fece appello ai sindaci di Foggia, di Lucerà, di Sansevero, di Bovino, di Cerignola, di Manfredonia e di Troia, nonché ai due Capitoli ecclesiastici delle due prime città perchè una loro rappresentanza si unisse a lui allo scopo di presentarsi in Napoli a S. M. il re e rendergli l’omaggio della Capitanata per la sua elevazione al trono d’Italia.
Infatti la notte del tredici novembre partirono a quella volta il governatore Del Giudice, il sindaco di Foggia marchese Saverio Salerni di Rose, il teologo monsignor Gherardo Santaniello, in rappresentanza del Capitolo della diocesi, il presidente del tribunale di commercio cav. Cacace, e, con essi, i sindaci di Lucerà, di Cerignola, di Sansevero, di Manfredonia, di Bovino e di Troia. Fecero poi ritorno alla spicciolata dopo parecchi giorni, soddisfattissimi tutti della lieta mis-
(1) Gherardo Santaniello, dopo qualche tempo, messosi in uggia palese col Capitolo di Poggia, abbandonò il posto e si ridusse a Napoli, ove si dedicò totalmente alla predicazione e suscitò fanatismo ovunque ebbe a far risuonare la sua parola. Si legge nella Storia delle Bue Sicilie del De’ Sivo, a pag. 465, che il dì dell’ Assunta salì il pergamo a S.” M.« di Capua, e che nel suo sermone ebbe a paragonare l’Assunta all’ Italia, spiegando che quella ebbe a sostenitore un Giuseppe, questa un altro Giuseppe; quella portò un Emmanuele che redense l’ umanità dalla schiavitù, questa un, altro Emmanuele che avea redento l’ ex-reame dalla schiavitù dei Borboni. — A Napoli ebbe momenti di grande notorietà, predicando a preferenza nella chiesa di s. Francesco di Paola. Ma vuoisi che abbia poi abiurato, trasformandosi in pastore evangelico della Chiesa Valdese, in unione di Pietro Cavazzi. “Ed egli morì in Napoli, giovanissimo ancora, nell’ età di anni quarantotto, il 13 dicembre 1866, attaccato, a quanto pare, di colera fra’ pochi casi di quel giorno.
missione adempita e del cordiale accoglimento avuto. Il governatore e il sindaco di Rose furono gli ultimi a tornare, perchè si trattennero a Napoli tutto l’intero mese : essi rientrarono in residenza il dì primo di novembre.
Ma se nella provincia intera sursero, come già vedemmo, e continuarono, a quando a quando, a deplorarsi parecchi focolari pericolosissimi di reazione, causa di eccidii inenarrabili, a Foggia la cittadinanza, tranne rari nantes rimasti ancora fedeli ad una dinastia sì mostruosa maestra d’inganni, fu nobilmente e dignitosamente pari a Partenope, accettando senza lordure di sangue e di saccheggio il nuovo regime. Né quando Francesco II, in leggere la lettera del suo fedigrafo ministro Liborio Romano, che invitavalo ad allontanarsi da Napoli in vista delle straordinarie condizioni del paese, aspettandosi poi dal tempo e da Dio il trionfo del dritto, giurava vendetta, con rivolgere a Luigi Napoleone quelle famose parole : Sono risoluto a non scendere dal trono senza combattere, e difenderò il regno e farò appello alla giustizia dell’ Europa, non vi fu anima viva in Foggia che se ne sia commosso e che abbia riunite pure una volta tutte le sue forze estreme per correre all’ ultimo appello del moribondo re. Anche i pochi suoi fedeli tosto lo dimenticarono, e non spremettero una lagrima dal ciglio allorché lo sentirono definitivamente partito da Gaeta il quindici di febbraio sulla Manetta per la via dell’ esilio.L’adesione unanime, invece, e spontanea che Foggia, sitibonda di libertà, manifestò a mezzo del plebiscito, le dette diritto fin d’ allora ad assidersi, tra le città italiane, nei primi seggi del patriottico Olimpo. E gloria ne vada perciò al suo nome !…
Il governatore Gaetano Del Giudice, intanto, il 22 dicembre ’60 fu collocato a riposo, venendo nominato in sua vece il signor Giuseppe Beltrani, proprietario di Trani, sindaco allora di quel Comune, è, nel 1848, sotto-intendente di Barletta , il quale però, in seguito, ebbe a rifiutare l’ onore di tale carica. Il Del Giudice, prima di separarsi dai suoi amministrati, volse il pensiero ai poverelli, e, nella occasione del prossimo natale di quell’ anno, volle che, in sua unione, un’ apposita Commissione, composta del sindaco e di tre gentiluoluomini della città (1), andasse attorno per i proprietarii foggiani allo scopo di raccogliere, in prò di quelli, sovvenzioni sì in danaro che in suppellettili, in vesti, in biancheria, e financo in semplice pane. Detta Commissione girò instancabilmente per due giorni, e raccolse dalla carità pubblica quanto di meglio si poteva. Infatti il mattino del ventiquattro dicembre essa, contemporaneamente, dal palazzo comunale e dall’orfanotrofio, fece larga distribuzione, ai poveri, di letti, di vesti, di pane e di danaro in circa ducati quattrocento, lenendosi così, almeno pel momento, la loro triste sorte, di che fu data lode infinita alla iniziativa del governatore Del Giudice, che volle così dare a Foggia il suo addio. E la notte del 15 gennaio ’61 egli partì definitivamente per Napoli.
L’imminenza della convocazione dei comizii per la elezione dei deputati al primo Parlamento italiano fece riunire a Napoli in comitato le persone più eminenti e i liberali più noti allo scopo di regolare il movimento in tutte le provincie continentali dell’ ex-reame di Napoli, e fare in modo che fossero eletti i veri patrioti o anche i migliori per ingegno, per . capacità scientifica o letteraria, per cospicuo lignaggio, degni e meritevoli dell’onorevole mandato. Alto concetto codesto, cui dovremmo inspirarci anche noi nella scelta dei nostri rappresentanti di oggidì, quando invece sulla parola d’ un salumaio o di altro somaro qualsiasi, che si dia l’aria di grande elettore, s’inneggia di sovente all’apoteosi delle mediocrità, di cui stanche ormai dovrebbero mostrarsi le moltitudini per finalmente rivendicare gli altari agli Iddìi.
Era surto dunque in Napoli un Circolo elettorale, sedente nelle sale del municipio a Monteoliveto, il di cui presidente era Carlo Poerio e vice-presidente Pier Silvestro Leopardi. Esso nel 17 gennaio ’61 pubblicava un manifesto, col quale raccomandava i nomi dei relativi candidati per tutte le provincie, che man mano specificava, e per la Capitanata raccomandava:
‘ (1) I tre prescelti furono i signori Ferdinando Rosati, 2.» eletto, Antonio Bianco e Lorenzo Scillìtani.
a Lucerà Gaetano de Peppo, a Sansevero Carlo Fraccacreta (1), a Bovino Pietro De Plato, a Cerignola Nicola Tondi, a Sannicandro Michele De Sangro, principe di Sansevero, a Manfredonia Domenico Varo e a Foggia Giuseppe Ricciardi. I precedenti di ciascuno dei candidati, nonché il merito, il valore personale o il nome di un casato rispettabile e rispettato induceva il Circolo a raccomandarli perchè fossero prescelti a rappresentanti del paese.
E infatti a Foggia la raccomandazione del comitato di Napoli non poteva non riuscire gradita, essendo il nome del Ricciardi pur troppo caro a tutti ; sicché non impegnossi quivi qualsivoglia lotta, non osando alcuno di combatterne il nome.
Fin dal ventitre gennaio erano rimaste affìsse al pubblico le liste degli elettori, invitandosi ciascuno di essi a ritirare dalla segreteria comunale la relativa tessera di riconoscimento; e la domenica consecutiva furono riuniti i comizii in due grandi sale del palazzo della dogana. Gli elettori vi accorsero numerosi, divisi in due sezioni, di cui una presieduta dal sindaco e l’altra dal secondo eletto. La votazione e il relativo scrutinio durarono sino a due ore della sera, quando pervennero altresì i risultati delle due frazioni di s Troia e di S. Marco in Lamis. Fatto il computo finale e complessivo dei voti, trovossi eletto a deputato con larghissimo suffragio Giuseppe Ricciardi, conte dei Camaldoli; e la sua proclamazione fu fatta il ventinove gennaio successivo.
(1) Questo Circolo osteggiò la candidatura di Luigi Zuppetta per le sue idee molto avanzate ; ma, ciò non ostante, egli venne eletto a deputato di Sansevero a grandissima maggioranza, dopo di avere indirizzata agli elettori la seguente lettera nobilissima ed austera :
Voi mi designaste come uno dei deputati al primo Parlamento italiano ; ed io sono in debito di sapersene grado. Ma se la vostra scelta potesse cadere sopra qualche altro soggetto, ve ne saprei grado molto più ; che, logoro dai lunghi patimenti e franto dalle torture di non corto esiglio, non troverei disaggradevole il tenermi lontano dalla tempestosa palestra parlamentare. Nondimeno se, a mio contro genio, la nomina avesse luogo per irremovibile volontà degli elettori,
Non farei per stanchezza il gran rifiuto.
All’ appello della patria non sono stato mai sordo. A quello tra voi, che non ha reputato superfluo il domandare a me la dichiarazione di fede politica, potrei rispondere che non ha d’uopo di discendere a dichiarasene ehi non elevasi di per sé stesso a candidato. Ma pure, siccome su questa bisogna non fa mestieri di scrivere a dilungo, voglio appagare il desiderio del richiedente :
Io sarò domani quel che oggi; e sono oggi quel che ieri.
- Zuppetta.
Questi ringraziò da Napoli i suoi conterranei dell’ onorevole mandato affidatogli, e promise che, in tempo non lontano, sarebbe venuto dì persona a stringere loro la mano. Infatti il venticinque ottobre egli mantenne il suo impegno, recandosi a Foggia tra i suoi amici ed elettori, dei quali molti vennero ad incontrarlo sino ad Ariano, come il marchese Saverio Salerai di Rose, Gaetano e Giovan Battista Postiglione, Luigi Ricca, Antonio de Maria, Giulio Libetta, Antonio Garelli e Lorenzo Scillitani. Nella carrozza di quest’ ultimo, verso ventun’ora entrò in Foggia, circondato da una folla di popolo, che si pigiava, che si urtava da ogni lato come cavalloni dintorno alla nave che s’inoltra nel più folto della burrasca, e che volle staccarne i cavalli e portarlo quasi in trionfo per le vie con l’impeto di mille mani, in mezzo ad un mugghiare ancor più forte, più assordante di quello del mare, e donde spiccava il simpatico unanime grido, pregno di fede e di entusiasmo: « Viva Ricciardi, viva il nostro concittadino ». Il corteo fece sosta innanzi alla cattedrale, dove il Ricciardi volle discendere per visitarvi quel santuario, e dopo pochi istanti risaliva in carrozza per recarsi a casa del marchese di Rose, di cui sarebbe stato ospite gradito. A ventitre ore si piacque di passeggiare democraticamente a piedi per la città in compagnia di amici, fra i quali vi si trovarono lo stesso di Rose, Ferdinando Rosati, Antonio de Maria, il professore Francesco Ziccardi, e, lungo il tragitto, fu fatto segno dalla cittadinanza alle manifestazioni più larghe di riverenza e di simpatia.
Durante i due giorni di sua permanenza nel collegio fu il Ricciardi festeggiato in ogni guisa; ed anche in teatro fu data una serata in onore di lui, dove, però, ebbe luogo un piccolo spiacevole incidente, a causa di taluni versi quivi improvvisatigli, come omaggio, dal poeta leccese e professore delle scuole magistrali di Foggia, Salvatore Brunetti, i quali eccitarono talmente l’ uditorio, che lo spettacolo rimase interrotto senza potere più proseguire. Inconsultamente, anzi vuoisi instigato da parecchi avversarti del Ricciardi, quel delegato di P. S. Tommaso Tonti, anch’egli foggiano, procedette all’arresto del Brunetti come perturbatore dell’ordine pubblico; al che 1 liberali, indignati, uscirono in massa fuori del teatro per correre a protestare dal governatore contro l’abuso di autorità commesso dal funzionario di polizia. Quegli dette loro la chiesta soddisfazione col fare all’istante rilasciare libero il Brunetti. Un tale disappunto, per altro, nulla tolse alla grande spontaneità della dimostrazione di affetto fatta da Foggia al suo deputato, al figlio suo diletto, il quale, commosso pel ricevimento quivi avuto da ogni classe cittadina, prese commiato col promettere di ritornarvi presto, come infatti vi ritornò il 18 novembre 1865 per una sera sola, visitando la Società operaia, di cui era presidente onorario, e quindi restituissi a Napoli. In seguito alla partenza di lui venne riformato in Foggia il già esistente comitato liberale, cui, il quattro novembre successivo, fu messo a capo, qual presidente, il p. Urbano da S. Marco in Lamis, il noto tribuno cappuccino.
Alla costituzione del nuovo potere legislativo tenne dietro quella definitiva della milizia nazionale, avvenuta in Foggia nell’aprile di quell’anno con tirarsi a sorte, dopo la debita pubblicazione delle liste, i nomi svariati delle persone da formare due battaglioni, composti complessivamente di otto compagnie, e con prescegliersi i relativi ufficiali, tra cui venne assunto a colonnello il marchese Pietro De Luca. Essa però si ebbe un simulacro di vita, perchè venne Sciolta novellamente il 3 maggio 1862 a causa di varii inconvenienti verificatisi, e presto fu riorganizzata, risultando questa volta qual colonnello il signor Gaetano Postiglione, che prese possesso dell’ufficio il due luglio dello stesso anno. Ma — noi si crederebbe — neppure questa seconda ricostituzione riesci a dare alla guardia nazionale foggiana tanto iodo nelle vene, da assicurarle una vita ancor più robusta e duratura. Il 22 settembre 1862, dopo pochi mesi appena, venne dal generale Alfonso Lamarmora, regio commissario per le provincie napoletane e investito di pieni poteri, di n uovo disciolta ed annientata.
Una vera fatalità parea incombesse sulla sua sorte, fatalità che, naturalmente, riesciva a strapparle a brani ogni aureola ed ogni prestigio. Fu allora che con molta fede tentossi rifarla, come le altre, su base diversa, escludendosi dal nuovo Corpo i lavoratori a giornata, i garzoni, i salariati e tutti coloro che esercitassero arti o mestieri servili. E lo stesso Lamarmora volle venire di persona in Foggia il 30 maggio 1863 per prendere gli ultimi accordi col prefetto pel funzionamento di essa; che anzi, a serbare libertà di azione, non volle aver contatto qualsiasi con alcuno del luogo, e rifiutò di alloggiare presso privati, preferendo invece l’albergo di Apicella, che fecesi sgombrare da ogni altro forestiere, e che rimase interamente per lui. E, surti col novello battesimo i due nuovi battaglioni, fu chiamato a comandarli, qual colonnello, il signor Nicola Navarra, cui il prefetto De Ferrari partecipò la nomina graziosamente, il 2 giugno 1863, mercè un biglietto d’invito a pranzo presso di sé, e dove lo appellava col titolo di colonnello. Costui, gentiluomo del luogo e di carattere abbastanza energico, ne assumeva le funzioni il sette giugno di quell’ anno, e le mantenne onorevolmente sino al 1866, quando, in ancor giovane età, atroce morbo Io spense. Da questo periodo in poi il comando della guardia nazionale venne assunto dal signor Giovanni Barone, promosso da maggiore al grado di colonnello. In verità, ei disimpegnò con grande zelo ed amore il suo nuovo ed alto ufficio, che tenne dal dieci giugno di quell’anno sino al diciannove febbraio del Seguente, quando volontariamente si dimetteva. Ed ebbe, più che altro, a cuore che la guardia nazionale fosse alla pur fine tutta uniformemente vestita, secondo le prescrizioni regolamentari, come il suo prisco battaglione, e facesse bella mostra di sé nelle parate, che spesso si tenevano o per pubbliche feste o per riviste speciali, passate or da lui medesimo, ora dal maggiore generale Orsini, ispettore di un tal Corpo per la Capitanata.
E qui è d’uopo notare che fin dal 1864 costui, in una rivista fatta il trenta di ottobre, quando lo stesso Barone fungeva da semplice maggiore del 1° battaglione, ebbe a lodarsi della guardia nazionale di Foggia, a preferenza delle altre della provincia; ma ciò, in onor del vero, non dimostrava per nulla ch’essa fosse ben diversa dalla maggioranza delle altre milizie nazionali del regno, da sperare, nel dì del supremo giudizio per tutte, di salvarsi dal comun crollo. La sua non fu certo vera gloria, stante che le lodi, che spesso le si prodigarono, riflettevano non solo la inappuntabilità della divisa, perfettamente militare sin nel cappotto grigio, ch’era follia aspettarsi da quelle degli altri paesi della provincia, ma la buona scienza degli esercizii e delle manovre anco militari, come ebbe a significare il suddetto maggior generale Orsini in occasione di altra visita, avvenuta l’il di marzo 1867. Perchè essa, —è duro il dirlo— affetta degli stessi microbi deleterii, come tutte le altre del regno, nessun serio servigio, nei nuovi tempi, prestò mai in prò del paese.
Sta in fatto che il generale Lamarmora, secondo vedemmo, la disciolse dopo pochi mesi appena ch’era stata ricomposta; e ciò per due principali ragioni :
l.a perchè si era mostrata, in molte occasioni, poco dignitosa e corretta, come avvenne una volta, fra le altre, il 12 marzo ’62, contro i carabinieri locali, i quali, avendo arrestato un milite della detta guardia che avea ferito un altro della benemerita, videro ribellarsi un buon nucleo di nazionali, che il generale fu costretto a far caricare di santa ragione dalla cavalleria per rimetterlo a posto, mentre il r. giudice dovette spedire ben ventotto mandati di arresto contro i più riottosi;
2.a perchè all’epoca del brigantaggio, nel clou del bisogno, aveva essa preferito di restare in città per riserbarsì la pancia ai fichi in una vita patriarcale e senza rischi, e si era rifiutata quasi sempre di uscirne per combatterlo, com’era suo dovere e come aveano fatto molte altre della provincia, venendo meno così al precipuo scopo di garentire, oltre alla libertà, la vita e gli averi dei cittadini. Che anzi, una volta fra le tante, provócava essa addirittura un pubblico scandalo, quando, essendovi la urgente necessità di accorrere nei paesi di Ascoli e di Candela, dove i briganti avevano abbruciati vivi ben venti soldati ed un ufficiale, asserragliatisi in una casa di campagna per esaurimento di munizioni, i militi si denegarono in moda rude, fiero, reciso, e giunsero fin anco a spianare i fucili contro il proprio colonnello, che li incitava a partire, e che dovette salvarsi, dalle loro furie, prendendo il largo. Il che venne stigmatizzato con parole assai roventi in apposito proclama dal cav. Bossolo, comandante della provincia, mentre questi lodavasi invece delle altre guardie nazionali di Capitanata. L’ultima virtù di un milite, diceva il gran Bonaparte, è il coraggio, virtù facile e comune; le virtù cardinali sono: resistere alle fatiche ed alle privazioni, obbedire senza discutere. Ma la milizia nazionale, in genere, che non aveva nella sua maggioranza alcuna di queste virtù, né comuni né speciali, e che era in gran parte abituata allo sbadiglio e all’ozio sfibrante, non poteva, per necessità, essere buona a nulla. Oh quanti di loro avrebbero preferito, in talune critiche occasioni, di ripetere furbescamente il motto ingenuo di Costantino, il figlio di Paolo I di Russia: « Io non amo la guerra, perchè sciupa i soldati! ».
La stessa rappresentanza municipale di Foggia, nel 1869, in vista della inutilità e del peso che faceva sul bilancio cittadino la guardia nazionale, proponeva al Ministero dell’interno di ridurre l’intera legione ad un battaglione solo ; il che indusse, con miglior consiglio, il ministro, il dì otto giugno di quell’anno, a spazzarla addirittura e a dichiararla definitivamente sciolta, non trovando nulla al suo attivo e intravedendo tra le linee quali fossero le vere ragioni di quella proposta. Un tale provvedimento, in verità, dispiacque a molti della cittadinanza, come allo stesso colonnello Barone, il quale si bisticciò seriamente col sindaco dell’ epoca Lorenzo Scillitani per la presa iniziativa, e, con disdegno, volle dimettersi dal comando anche prima dell’ arrivo del decreto di scioglimento. Il che, disgraziatamente, forse costituì la causa precipua e remota del susseguente grave dissidio tra le due famiglie Barone e Scillitani, dichiaratosi apertamente, in seguito, ad occasione del debole pretesto di un carretto della prima, che una guardia municipale non volle far transitare un dì per la piazza mercantile, dichiarandolo in contravvenzione, cosa che lo Scillitani, in omaggio al regolamento di polizia urbana, ratificava ; dissidio che menò alla netta divisione di tutta la città in due fazioni, l’una contro l’altra armata, e che, da allora, non più scomparsa, danneggiò di gran lunga gl’interessi di essa e ne arrestò, fra l’altro, il rapido svolgimento del progresso civile.
Checché sia di ciò, la milizia nazionale di tutto il regno non avea corrisposto alla comune aspettativa, e trovavasi quindi d’ aver fatto il suo tempo. Essa avea pur troppo finito di alimentare la vanità di’coloro, cui, pur immollati d’ignoranza e privi di prestigio, inetti in ogni guisa a spendersi pel paese, non parea vero potessero cingersi il fianco d’una sciabola dalla lucente dragona e di ottenere da’ subalterni quel saluto, che, altrimenti, era follia sperare; come mostrò, per un esempio, a Foggia un bighellone arricchito, che, pur carco di anni come lo era di danaro, ebbe la velleità di aspirare ad un posto di ufficiale, che infatti ottenne. Con simili elementi quali utili servigi poteva aspettarsi tutto il regno dalla sua milizia nazionale ?… Sicché il giorno dell’ abolizione o meglio dell’oblio di essa potè dirsi, per la sua dignità, un giorno di vera riabilitazione.E, in forza dello stesso battesimo, che tutto redimiva al sole sfolgorante di libertà, venne del pari a Foggia rinnovata la rappresentanza provinciale mercè una nuova circoscrizione della provincia, nonché la rappresentanza comunale; per lo che mi piace qui ricordare che il presidente primo dei tempi nuovi, datosi al Consiglio provinciale di Capitanata, fu il marchese Luigi De Luca, come il primo sindaco della città fu Saverio Salerni marchese di Rose, che prestava giuramento il dì 11 agosto 1861.
Così Foggia, in grembo finalmente a generose e libere istituzioni, garentite ed applicate da uomini liberi, sperò, innanzi a tanto ossigeno vivificatore, di aver diritto anch’ essa, come le altre sorelle, ad un avvenire prospero e rigoglioso.
XVII.
Foggia, non appena ebbe aperte le luci alla libertà, fu gittata d’un colpo in preda a imprevvista ed immane sventura, a giorni cioè di palpiti, di paure, di strazii e di miserie per la istantanea apparizione, nelle sue campagne, del brigantaggio.
Nato dal seno delle sbandate orde borboniche, esso, con le sue funeste atrocità, fece additare Francesco II con l’appellativo orroroso di re dei briganti. E che sia stato così, lo confessarono gli stessi suoi proseliti quando vantavansi della reazione del popolo al nuovo ordine delle cose, e sputarono insulse sentenze, chiamando menzogna il plebiscito. « Quello che appellavano brigantaggio — scriveva infatti un di costoro, il De’ Sivo, nella sua Storia delle Due Sicilie, — era guerra, e la più terribile che mai popolo facesse a dominatori ingiusti (sic), perchè lor toglieva sangue, moneta e riputazione. Essa suonava orrenda per Europa, ma quelli che a possesso non a fama guardavano, lasciavano dire; e anzi eglino stessi talvolta novelle spaventose ed esagerate di loro scelleratezze diffondevano. Dei paesi arsi ingrandivano le rovine, acciò le popolazioni spaurissero; però di sangue e minacce e iniquità facevano pompa esosa; e sortivano lo effetto, che i cittadini e i montanari di accordo si studiavano di tener la guerra fuori dei paesi, per non dar pretesto a saccheggi e devastazioni. Era dunque una furia di zuffe spicciolate, campo ogni valle, parapetto ogni macerie, agguato ogni fratta. Le bande a minuzzoli, pronte ai movimenti, a dividersi, a raccogliersi, a celarsi, a tornar di fianco e a tergo improvvise, vivevano nei territorii natii, ove ogni albero sapevano, di leggieri trovavano viveri e munizioni, con vantaggio assalivano, senza rischio si scansavano, tagliavano i telegrafi e le strade, infestavano i passi, rapivano vettovaglie e bagagli, e, padroni delle vette, scorto da lungi il nemico, percussavanlo e sparivano. Però le soldatesche italiche, sebbene in centomila, e altrettante in nazionali e Corpi franchi, non bastavano a coprire il reame ecc. Quella guerra riusciva a sfogo di rabbia, a sanguinosa protesta, a sperpero di vite e sostanze di governanti e governati. Ma vi si aggiungeva il brigantaggio comune, che molti tristi, con Francesco in bocca, trescavano in quella grande anarchia, e sfruttavano le simpatie delle popolazioni, guerreggiando per sé». Nobile, in vero, e bella confessione codesta !… E come suggello di siffatte autentiche vanterie reazionarie, fa d’uopo del pari ricordare l’audace proclama fatto ai popoli delle due Sicilie il 30 settembre 1862 dal celebre capo-brigante Chiavone, quando li chiamava in arme contro lo straniero-ladrone, dicendo, tra l’altro : « Ora non son solo : Abruzzo, Puglia, Principati, Basilicata e Calabria si levano a percuotere gl’insanguinati distruttori, i fucilatori d’inermi, gli eretici saccheggiatori di chiese, derisori dei santi e di Dio. Tutto il reame con veementissima ira combatte ; e le ossa degli avi nostri, frementi dalle tombe,, vanno gridando: fuori lo straniero! All’arme! ogni città, ogni borgo o casolare vegga i suoi figli alzare le braccia per la patria. Uno sforzo universale da ogni banda dia sopra a questi vandali piemontesi. Noi combattiamo pel suolo natio, per gli altari, per le mogli e figli nostri. Si vinca o si muoia. S’usi ogni arme: spade, fucili, mazze, bastoni, e sino le pietre degli Appennini sono arme nelle mani d’un popolo rivendicatore di libertà. Mostriamoci degni degli antenati, degni di Francesco II, di questo figlio d’ una santa, propugnatóre dei nostri dritti. Portiamolo sulle braccia nostre alla riconquista del reame ; rialziamo la patria ed il trono, e si abbiano le sette sovvertitrici della società l’ultimo abbattimento su questa terra dei vulcani. All’ armi !»
E, se ciò non bastasse, ricorderei altresì che i briganti, capitanati dal famoso Pilone, allo scontro di Terzigno perdettero una bandiera che portava la scritta : Viva Francesco II, Viva Maria Sofia; e che sin si ebbero dai giornali dell’epoca parole assai atroci e mordenti non solo lo spodestato re, che trovavasi rifugiato a Roma, ma lo stesso Pio IX ed i francesi, perchè tutti insieme alimentarono essi in Italia il brigantaggio.
Brigantaggio, che mise a Foggia — siccome dicevo — lo scompiglio in tutte le classi cittadine, brigantaggio, che non dette tregua ad alcuno per anni interi ed ininterrotti, senza che vi fosse stato mai mezzo per vederlo domato e distrutto. Il governo non lasciò, in vero, d’impensierirsene e d’impartire ognidì istruzioni tassative e severe ai governatori, che invano però centuplicavano, al riguardo, la loro azione. Il generale Cialdini volle contro di esso agire a modo di guerra, e il 22 luglio 1862, con proclama da Lecce, ordinava che i briganti, presi con l’arme alla mano e gli evasi dalle galere fossero immediatamente fucilati. Volle gittare del pari il terrore un Focino, generale comandante in Capitanata, intimando, una volta specialmente, agli abitanti di Volturino, che erede va fautori e manutengoli di essi, che se fossero tornati i briganti nei pressi di quelle campagne, egli avrebbe senza pietà incendiatele loro case.
E vi fu pure, all’uopo, un’ inchiesta parlamentare, espletatasi da apposita Commissione, composta dei deputati Sirtori, Bixio, Romeo, Massari, Saffi, Morelli, Castagnola, Argentina, Ciccone e Pellati, che si recarono personalmente a Foggia, a Cerignola, a Sansevero e in altri luoghi, infestati da tale orrenda genia, onde rendersi conto de visu delle ragioni per la persistenza di tanta sciagura e prescegliere i provvedimenti a-datti a combatterla. In conseguenza di che il relatore Giuseppe Massari faceva osservare, nella sua relazione alla Camera, che le vere cause della soverchia persistenza del brigantaggio erano, più che altre, le predisponenti, fra le quali primeggiavano la condizione sociale e lo stato economico del contadino, il quale, nelle contrade dove il brigantaggio mostravasi più intenso,trovavasi in un’anormalità da far paura. « Tanta vigoria e tanto squallore — ei diceva — sono naturale apparecchio al brigantaggio. La vita del brigante abbonda di attrattive per il povero contadino, il quale, ponendola a confronto con la vita stentata e misera che egli è condannato a menare, non inferisce di certo, dal paragone, conseguenze propizie all’ordine sociale. Il contrasto è terribile, e non è da meravigliare se, nel maggior numero di casi, il fascino della tentazione a male operare sia irresistibile ».
Ma, anche accertatene le cagioni, alla buona diagnosi non rispose punto la terapeutica, perchè tutto riuscì vano a fugarne il flagello, tutto. Caddero perciò in disgrazia prefetti e generali, vennero deposti parecchi funzionarii, accusati e gli uni e gli altri d’inettitudine o di poco zelo ed energia, e furono mandati spesso al macello compagnie antere di soldati, sopraffatti sempre da quei tristi Con agguati e con insidie. Il brigantaggio s’impossessò della provincia di Capitanata come d’un suo reame ; e le numerose comitive, sì a piedi che a cavallo, seminavano ogni dì ovunque, con un’audacia senza pari, stragi e morte. I proprietarii subivano ricatti su ricatti senza poter emettere un grido, sotto pena di vedersi incendiate le messi, distrutti gli oliveti e le vigne, sgozzate le greggi; — era d’uopo quindi fare di necessità virtù, giungendosi fino a vettovagliare da essi, all’occasione, quei malnati e dar loro asilo sicuro per scongiurare mali maggiori. E fu per questo che parecchi signori della provincia dovettero allora subire la grave umiliazione di essere accusati come favoreggiatori e trascinati alle carceri per rispondere, innanzi alla giustizia punitrice, di questo loro reato, che per forza maggiore i più di essi aveano dovuto commettere. Ma neanche lo sfollamento dei falsi o veri manutengoli riuscì a fare per lo meno diminuire le proporzioni del brigantaggio, che esso perdurò, con una tenacia da mettere raccapriccio, per anni lunghissimi e a dispetto di tutti e di tutto, fino a che non furono migliorate le condizioni della viabilità in Capitanata con la sistemazione di una rete ferroviaria, e non ebbe ad impallidire col tempo l’azione vendicatrice dei malefici detriti rea-^©narii. E il dì che il brigantaggio potè dirsi disparito totalmente dal Tavoliere, quel dì rappresenta il crollo finale del grave pondo della tirannia borbonica.
lì Giornale patrio, di cui tenni parola innanzi, e che si occupa minutamente di tanta disavventura, ben riporta nelle sue pagine episodii tristi e raccapriccianti che si verificarono in questo malaugurato periodo. E rilevasi bensì da esso come sin dal febbraio 1861, con l’insolentire di alcuni braccianti su di una via di campagna, quasi alle porte di Foggia, contro un uffiziale della truppa che vi transitava solo, a cavallo e a grande distanza da una compagnia di soldati che lo seguiva, imponendogli di gridare viva Francesco II, muoia Vittorio Emmanuele, e al cui rifiuto gli furono addosso come ossessi, imbrandendo zappe e picconi, si ebbero i prodromi della più sfacciata reazione borbonica, che già da parecchio andava di latente fecondandosi nelle nostre contrade, e che nelle altre già avevano apertamente assunta la figura delle aggressioni, delle grassazioni, degli assassinii…, di un’azione brigantesca, insomma, nel senso più lato. Con un crescendo spaventevole, da gruppi di dieci, di venti, di trenta si raggiunse il numero di centinaia e centinaia di armati, che, a piedi e a cavallo, si vedevano, muniti di uniformi, marciare tuttodì addirittura militarmente e fin preceduti da fanfara musicale, aventi a duci uomini ferocissimi, assetati di sangue, e che ora assumevano il nome di capitano ora quello di tenenti, portando ai loro fianchi, con sfrontata spavalderia, puranche delle donne in divise da ufficiali e armate insino ai denti, da cui venivano coadiuvati nel comando.
E imbrattò, per conseguenza, della fama del suo nome esecrato le fosche pagine della storia della delinquenza un Angelo Maria Lo Zumpo, uno dei più audaci, che osò travolgere maledettamente, all’ombra della sua aureola sanguinaria, perfino un giovane dì scienza, un tal Nicola Perifano, foggiano, che esercitava con successo la professione di medico in Sansevero, e che, con vero accecamento, volle seguirlo; quell’An¬elo Maria Lo Zumpo, che sconvolse per lungo tempo le cam-agne garganiche, e che, sorpreso finalmente il 28 giugno 1862 sotto le falde di S. Marco in Lamis, veniva il dì appresso, nello stesso sito, con altri suoi compagni fucilato. E con costui, e forse più di costui, seminò il terrore Michele Caruso, la cui comitiva, forte dì ben dugento persone, era discesa dalla Basilicata a infestare il nostro Tavoliere, e di cui faceva parte quel Giuseppe Crettinelli di Castelnuovo, dal nomignolo di Coppolarossa, che si rese autore di ben ottantatre omicidii, oltre a diversi altri assassinii, e che fu fucilato in Foggia presso il parco comunale il 12 dicembre 1863, pochi giorni prima che lo stesso Caruso fosse alla sua volta arrestato, in compagnia della sua druda, a Molinara, in quel di Benevento, ove una stessa sorte lo aspettava. É non furono men feroci, in oltre, un Crocco! uno Schiavone, un Rinaldi, ch’ebbero scontri sanguinosi con le milizie nazionali e con la truppa, e che furono autori di torture e di turpitudini odiose ed esecrabili ; e con loro quel Pagliacciello, insidiato da una spia, il 25 aprile 1862, nella masseria Sammarco tra Orta ed Ordona e ammazzato ad Ascoli come un cane rabbioso; e, per ultimo, quel Vitullo, foggiano, costituitosi spontaneamente il 25 settembre 1863, e che il Consiglio di guerra di Foggia condannava, il ventinove ottobre consecutivo, a quindici anni di lavori forzati.
Tutti costoro, a capo di forti bande, non temettero un momento solo le persecuzioni di quanti furono scaglionati contro di loro, pur sapendo di avere a fronte generali provetti, che usavano di ogni strategia per distruggerli, e che disponevano di fucili e fin di cannoni, senza risparmio di sorta, generali che rispondevano ai nomi di un Focino, di un Pinelli, di un Dodo, di un Bossolo, di un Regis di Mondovì, di un Mazè de la Roche. Ogni macchia ed ogni bosco era loro sicuro asilo ; e i cavalli corridori di che erano forniti, sottratti in gran parte alle migliori razze della Capitanata, li portavano con fulminea rapidità, come per incanto, da un sito all’altro, perfettamente opposti, da dar loro le sembianze di altrettante furie d’Averno anzi che di uomini, e da accrescere, per conseguenza, le difficoltà in combatterli. Il bosco dell’ Incoronata, a sei miglia da Foggia, potea dirsi il loro quartiere generale, donde poi correvano, da una parte, fin su l’Appennino, seminando delle loro stragi le contrade vicine, e facendo, a preferenza, del vallo di Bovino il passo più temibile e pericoloso per chi dovesse transitarvi, e, dall’altra, salivano con una tenacità temeraria, fin sulle vette più aspre o anche più dolci e ridenti del promontorio garganico.
Non vi era più esempio che la messaggiera postale arrivasse regolarmente a compiere i suoi viaggi ora per Napoli, ora per le marine, senza essere assalita da quei furfanti e messa al sacco o al fuoco; ed era ormai diventato normale il sentire ch’essa fosse rimasta a mezzo la via per esserne stati asportati i cavalli, o per essere rimasti uccisi corriere e postiglioni.
Oh quante volte la si vide tornare indietro a Foggia dopo appena poche ore che n’era uscita, e con le cassette completamente vuotate, e con i viaggiatori spogli e nudi fin della foglia di fico; oh quante volte il becchino, più che il fattorino di posta, dovè avvicinarsi allo sportello per trarne, in cambio della valigia, ammassi informi, quasi poltiglie di cadaveri. E con la messaggiera postale tuttodì si vedevano ritornare da’ loro poderi e fin dalle vigne e dagli orti più vicini all’ abitato quegli agiati industriosi, tremanti come giunchi al vento, per essere stati inseguiti sulla strada regia da orde vandaliche; e quanti di loro avean lasciato per via, raggiunti dal piombo micidiale, qua un loro caro col cranio fracassato, là un altro ancora con gli arti recisi, e con essere, talvolta, essi stessi piagati a morte o mutilati. Non vi era sera che non si vedesse in Foggia illuminare l’orizzonte, comedi orrorose aurore boreali, da incendii interminabili in distesa che annunziavano la distruzione di campi interi ed opulenti di biade. Non vi era giorno, come già accennammo, che biglietti su biglietti di ricatti non giungessero in ciascuna di quelle famiglie patrizie, delle quali ora il capo, ora uno dei componenti trovayasi in ostaggio; sicché, non rispondendosi adeguatamente sull’istante, si andava incontro ad irreparabile rovina. Ben ebbe a sperimentare la loro codarda vendetta Lorenzo Scillitani quando il 19 agosto 1862 si vide fatto un rogo dei pagliai, delle case rurali e dei ricetti, nonché vandalicamente scannate nella sua masseria, a quattro miglia da Foggia, ben duecento pecore merinas pregiatissime, verso le quali egli avea tenuta speciale cura pel miglioramento delle greggi e delle lane, e la cui ultima notizia, meno che per il danno, per lo sfregio alla sua industria lo annientò a terra svenuto.
Il terrore si era sparso per ogni angolo della provincia, e tutto, per conseguenza, finì per languire : le industrie abbandonate, le arti inerte, le professioni avvilite, e la miseria divenuta oltre ogni dire gigante. E quando nell’anno 1862, pei fatti di Aspromonte, si mise Foggia in istato di assedio, e si diede ordine, il ventinove agosto, di tener chiuse, durante questo periodo, le masserie, le poste ed ogni stabilimento» industriale, e di non più panificarsi nelle panetterie di campagna per togliere così l’agio ai briganti di andar colà quotidianamente a provvedersi di pane, s’iniziò un nuovo calvario pei proprietarli, costretti per tal modo, d’ora in poi, e messi alla tortura da costoro affinchè gliene mandassero essi dalla città, col rìschio e pericolo di compromettersi con la giustizia. E di che cosa non doveano, per paura, codesti disgraziati fornire quei manigoldi, che li aveano ridotti peggio che schiavi al loro volere? Forse non vi fu chi abbia mandato pur vitto intero e vestimenti e biancherie, e abbia fatto per loro fin confezionare centinaia di stivali con gambali per salvarsi da maggiori estorsioni? E non furono forse arrestati, fra gli altri, due signori di molta reputazione e assai noti del Gargano, il 30 febbraio 1862 con grande scandalo de’buoni montanari, per avere non solo soccorsi quei tristi, ma dati loro in gran copia viveri e ricetto? Fu infatti sorpresa dalla truppa la masseria di loro proprietà, nella quale era approntata per quei ribaldi una mensa sontuosa e circa venti letti, dove tranquillamente passavano le notti in dolce riposo. Oh la condizione creatasi all’universale era delle più scabrose, delle più difficili, delle più insostenibili!..
Né ristettero in oltre quei malnati dall’invadere altresì paesi e villaggi per suscitarvi ovunque ribellioni e rivolte, e ben Viesti, Rodi, Vico, S. Marco in Lamis, sullo stesso promontorio, ebbero a risentire le funeste conseguenze di tanta temerità, che scene di sangue, non mai verificatesi per lo innanzi, si avverarono tra le loro mura quando le guardie nazionali locali e la truppa, inviata da Foggia, opposero loro soda e fiera resistenza. E ne risentirono del pari i villaggi di Ordona e di Stornarella, ove il 18 maggio 1861 una folta di armati a cavallo, gridando « viva Francesco II, riuscì a mettere lo scompiglio in quei poveri abitanti, che si chiusero tremanti a verga nelle loro case, in qualcuna delle quali, penetrato un pugno dei più audaci, commise stragi e turpitudini nefande, vigliacche, inenarrabili. E, in forza di tale doloroso precedente, il 18 aprile 1862, essendo avvenuto, sotto Ascoli, uno scontro tra una comitiva di più centinaia di briganti e pochi lancieri, che trovavansi colà in colonna mobile, ed essendo stati costoro, pel loro numero esiguo, costretti a chiedere asilo a Stornarella, fin dove vennero inseguiti, quegli abitanti, ad evitare che i briganti per la seconda volta entrassero in paese e facessero man bassa di tutti e di tutto, preferirono mostrarsi inumani coi profughi e li ricacciarono fuori a viva forza, dannandoli così ad un sicuro massacro. Infatti, venticinque lancieri rima¬sero barbaramente uccisi, e non vi fu un solo di loro che fosse sopravvissuto. E si osò financo minacciare d’invasione la stessa città di Foggia, dove, il 17 gennaio 1862, fu sì enorme l’ all’arme in ogni classe, che si dovettero battere i tamburi a ge-nerale per chiamare in armi truppa, guardia nazionale e gli stessi privati, a comune difesa. Ma l’invasione, per buona fortuna, rimase allo stato di semplice minaccia, sicché la calma potette presto ripigliare il suo posto nell’animo di ognuno e ammorzare il fuoco delle accese fantasie.
Le carceri, come pur dicemmo, si popolavano, intanto, tuttodì di spie e di manutengoli, mentre, a quando a quando, si assisteva al terrificante spettacolo delle fucilazioni ad horas presso il parco comunale o sulla spianata della villa, ordinata dal Consiglio di guerra, o si accorreva al Piano della croce, ov’ erano trasportati dalle campagne i cadaveri dei briganti uccisi, ivi esposti, come a la morgue, per possibili riconoscimenti. Fu così che si ebbe talvolta la non grata sorpresa di scoprire nelle sembianze sconvolte dalla morte e già in via di dissoluzione, quella di un qualche traviato concittadino fog-giano ; fu così che, il dì 8 luglio 1862, si ravvisava, con dolore universale, nei miserabili avanzi di un bandito, che aveva assalita con altri la messaggiera postale e ch’era rimasto freddato da un colpo di pistola dei carabinieri di scorta, un Paolo Tarantino, giovane a diciotto anni, aitante della persona, figlio di Vincenzo, guardiano del vicino fondo di Castiglione ed uomo onesto a tutta prova, che fu ad un pelo per morirne di vergogna e di crepacuore.
E di tanti altri tristi ed orrorosi episodii di sangue, che gittarono per un periodo di cinque lunghissimi anni lo squallore’nelle moltitudini di Capitanata, ben vale la pena di rilevarne ancora qualcuno, spigolando tuttavia nelle affollate pagine del noto Diario.
E ricorderò, infatti, che, nelle ore pomeridiane del 29 di ottobre 1861, quaranta briganti a cavallo assalirono a sei miglia da Foggia, presso iLbosco dell’Incoronata, due carrozze che tornavano in città da una masseria, con entrovi il signor Felice Zicari, suo figlio sacerdote ed un altro figliuoletto di te-neri anni, un capitano, un maggiore-chirurgo dei lancieri e un cappellano di reggimento, tutti tre piemontesi. Fattili discendere sulla via, chiesero loro il danaro che portavano, al che il Zicari mise fuori dieci piastre, che erano le sole che si avevano. Furono allora trascinati tutti nella chiesa del santuario, ove fu ordinato ai soli Zicari, scompigliati dalla paura, di sostare ivi dentro, mentre menavano seco, invece, i tre piemontesi. Il cappellano, prevedendo la già prossima fine, volle confessarsi in articulo mortis con l’allampanato collega, e prepararsi così all’estremo viaggio. Infatti, venuti all’aperto, furono tutti tre quei disgraziati messi in fila, e, con l’essersi strappati loro violentemente di dosso gli uniformi, si ridussero in veste adamitica. Spinti poscia innanzi coi calci dei fucili e con pugni e pedate fino al così detto rione del Cervaro vecchio, vennero quivi freddati con una ben nudrita scarica di fucileria. I tre Zicari, a notte alta, fecero ritorno a piedi in Foggia, dove il racconto di così fatta strage, riempì di terrore la cittadinanza intera. I tre cadaveri, raccolti nel luogo indicato, furono, tra la massima generale mestizia, trasportati pel momento all’ ospedale di s. Giovanni di Dio, e il dì appresso si fecero loro solenni funerali, cui presero parte tutte le autorità civili e militari, nonché il popolo tutto, senza distinzione di classe, che versò lagrime sincere per le povere vittime. Ma la ferocia di quei tristi sorpassava ogni confine quando il nove novembre consecutivo, avendo gli ufficiali dei lancieri voluto inviare a Torino il cadavere dell’ucciso capitano per farlo ivi tumulare nel sarcofago di famiglia, il funebre convoglio, ad opera di spie, venne sorpreso dai briganti presso Giardinetto, e, strappatene le misere spoglie ivi deposte, le dannarono senza pietà al rogo.
E ricorderò che, il 26 marzo 1862, restava bloccato da somigliante masnada nella posta denominata Pozzo Af segno, in tenimento di Troia, un sacerdote troiano, tal Francesco Cibelli, venuto per celebrare messa in una di quelle cappelle rurali in ricorrenza della festa dell’Annunziata. Ivi i briganti gli dissero, con cera brusca e con gran cipiglio, che sapevano tenesse egli in paese la bandiera tricolore sventolante sui balconi della sua casa, perchè liberale ed unitario; il che costituiva colpa sì enorme da fargli meritare pena ben severa ed atroce. Lo dispogliarono, quindi, delle vesti, facendone una fiammata, e lo legarono al tronco di un albero, ove lo lasciarono per diverse ore esposto al ludibrio, ai punzecchiamenti, ai sozzi insulti dei più temerarii e selvaggi, dopo di che, satolli del martirio morale e materiale inflittogli, gli tirarono alle spalle pa= recchie fucilate e lo gittarono semivivo su’ carboni crepitanti.
E ricorderò altro cruento sacrifizio in persona di un Michele Preziosa, un povero guardiano del mio avolo materno, Giacomo Curato di Troia, che, sospettato di aver messa in sull’avviso la forza pubblica per voler snidare da un certo sito di campagna un gruppo di quei malnati, venne sgozzato come un agnello in vicinanza di Montarato il 21 agosto 1862, e pur esso, dibattendosi tuttora tra la vita e la morte, fu messo ad arrostirsi come un pesce in padella.
Ricorderò del pari l’ eccidio avvenuto il 21 settembre 1862 tra Ascoli e Candela, dove si trovarono di fronte sessanta briganti e soli venti soldati di fanteria con un ufficiale. Un a mischia accanita venne impegnata tra loro, mischia che i soldati, ad un certo punto, non potettero più sostenere per avere esaurite tutte le cartucce. Si vide allora dagli ultimi la necessità di asserragliarsi in una casa rurale di quei pressi per sfuggire, almeno pei momento, alle furie degli avversarli; ma codesti tristi li ebbero così, invece, a loro completa discrezione, che di quel giocattolo di fortezza, appiccatovi intorno il fuoco con le fascine, ne fecero in un attimo un forno crematorio. Oh il triste, l’ orrendo spettacolo di morte !…
Ed era tale la preoccupazione e lo allarme per cotali maledetti, che quasi può dirsi li si vedeva in ogni angolo con la fantasia anche quando materialmente non vi fossero, come ca¬itò il 24 aprile 1862 in una masseria in contrada di Sansevero, dove furono scambiati per briganti a bivacco diciotto infelici tosatori di pecore, che, sul mezzogiorno seduti a terra, all’ora della ricreazione,mangiavano un tozzo di pane. Sorpresi quivi violentemente da una colonna di soldati, non ebbero tempo a farsi riconoscere e caddero miseramente tutti sotto il piombo micidiale.
L’uragano tremendo, dunque, che travagliò di gran lunga Foggia e la sua provincia per anni interi, e che costò l’ olocausto di sostanze e di esistenze infinite, incommensurabili, venne molto lentamente a dileguarsi; sicché potè dirsi disparito del tutto non prima dell’ anno di grazia 1866, — uragano che, al solo ricordo, sollevando un sentimento di orrore e d’indignazione fin nei tardi nepoti, fa tremare tuttavia, dopo ben quarantasei anni, le vene i polsi, e che ormai la storia registra nei suoi volumi, a caratteri di brace, come postuma vergogna di Casa Borbone.
XVIII.
Le rivoluzioni, o che si facciano col berretto frigio o all’ ombra del vessillo dei re, travolgono sempre sempre nella marea invadente; limacciosa e distruttrice anche chi nulla ebbe mai da rimproverare a sé stesso, divenuto preda in un baleno di errori, di sospetti, nonché di nequizie e di vendette perso-nali di Vandali improvvisati, ed entra così, senza volerlo, nel demanio della storia politica d’ un paese con la veste di martire, mentre, altrimenti, l’umanità, per questo, non si sarebbe forse neanche accorto di lui per tutt’ i secoli avvenire.
A Foggia, infatti, come in ogni altro luogo del Napoletano, mentre verificavansi àncora nelle classi infime scatti di reazione, furono nei primi periodi di bollore segnati nigro lapillo molti pacifici cittadini, che avevano commesso il peccato di non essere discesi in piazza tra le prime file a gridare l’ osanna o il crucifige, ed avevano preferita la tranquillità e la pace del domestico focolare, aspettando inerti, se non fidenti, che la rivoluzione o la evoluzione avesse descritto il suo ciclo fatale, per inchinarsi anch’ essi, a fatto compiuto, come cittadini obbedienti alla volontà della maggioranza del paese, in-spiratrice e creatrice del nuovo ordine sociale. Forse per taluno ciò non dipese neanche affatto da libero e consciente volere, ma da flaceidità dell’organismo: schiacciato per tanto tempo da tirannia, asfissiato in ogni suo ideale, divenuto ogni giorno più infemminito, non aveva egli saputo rifortificare il suo animo e calcinare gli ossi rammolliti per tornare uomo, dopo di aver dovuto persino rinunziare a parlar come tale; e quindi avea finito per rassegnarsi ad essere al cospetto di tutti un Narsete senza spada, parimente ossequioso ad imperatrice e a goti. Ed a tutti questi vanno aggiunti coloro che per le cariche e per gli uffìcii pubblici, occupati sotto 1! antico reame, dovettero assolutamente esser presi di mira come nemici delle nuove istituzioni, mentre forse oh quanti di loro, intimamente, aspettavano l’ora della comune riscossa. E intanto non seppero né potettero addimostrarlo o perchè si avevano anch’essi un animo assai tapino e senza iniziative, o perchè temevano di compromettersi sul serio, e, con sé stessi, di compromettere l’avvenire e la sussistenza delle rispettive famiglie. Non parlo poi di coloro che indossavano veste talare, pei quali, mercè partito preso, non fu mai ammesso il beneficium inventarti. Sicché un semplice pretesto dette di sovente facile adito per taluni ad una visita domiciliare, per altri ad un mandato di arresto o financo ad un’ assegnazione di domicilio coatto, a norma della legge del 1.° maggio 1866, sancita per infrenare coloro che si temevano avversi alla politica italiana ; per la qual cosa colui, che non ebbe santi per sé in paradiso, troppo rimase malconcio, se non franto. Ma l’amore alla libertà non è monopolio di alcuna professione, né di alcun ceto. La patria giganteggia appunto perchè l’amarla ed anche l’immolarsi per lei costituisce un dritto comune, un comun vanto di tutt’ i suoi figli l’escludere quindi a priori un ceto, un’ età, un paese, una classe sociale da questa gara di amore e di sacrificio è roba da sconsigliati, che vanno confusi e smentiti dalle pagine imparziali della storia e dal nostro glorioso martirologio politico, registrandosi tra’giustiziati in Napoli, dal giugno 1799 al settembre 1800, ben tredici tra preti e frati. (1)
Noi altri del Mezzogiorno siam fatti così : -amiamo per natura l’iperbolismo nel giudizio, l’iperestesia nel criterio : tutto, tutto ci piace di vedere a traverso lenti d’ingrandimento. Come chi da una pesca fradicia stimi infradiciato un intero canestro di pesche, così, allo scorgere di un peccatore, diciamo volentieri che sieno peccatori tutti, o per un peccatore, che e’ infiamma di acerbo sdegno e che pur forse non macchiayasi che di semplice colpa veniale, dimentichiamo, con grande facilità e disinvoltura, mille giusti !..
E in Foggia il lungo elenco di codesti perseguitati fu completato con nomi di persone appartenenti a diverse
(1) Questi tredici patrioti rispondono ai nomi di : Giuseppe Belloni, minore osser¬vante, Michele Natale da Casapulla, vescovo di Vico Equense, Nicola De Meo dei pp. crociferi, Nicola Palomba di Avigliano, Gaetano Morgera da Forio d’Ischia, Vincenzo Troisi, prete dei Vergini, Severo Caputo, olivetano di s.» Anna dei Lombardi, Ignazio Falconieri e Giusepee Guardati, benedettino.
classi sociali, di cui parecchi, specialmente, erano circondati della pubblica estimazione, tanto che niuno, dal sodo e non preoccupato criterio, avrebbe potuto mai antivedere la sorte non bella che dovea loro toccare.
E non può andar dimenticata, innanzi tutto, l’aggressione brutale, Compiutasi a danno dei frati cappuccini in un maniaco accesso di furore e di singolare, inesplicabile vendetta partigiana, per la quale si videro “molti di essi scacciati dal loro sacro asilo a dirittura come tanti lebbrosi, resisi indegni di più appartenervi. E ciò per inchinare, senza alcuna specie di controllo, un frate, già mezzo sfratato, quel p. Urbano da S. Marco in Lamis, che noi vedemmo tra i più accesi tribuni della rivoluzione, e che si era recato, nel 4 febbraio 1861, dal sotto-governatore marchese d’ Aulisio, funzionante da governatore per 1′ assenza del titolare, e che dopo appena due giorni cadde anch’egli in disgrazia della piazza e destituito, a dolersi di fantastiche percosse ricevute dai suoi ex-colleghi conventuali per rancore politico. Fu allora che il d’Aulisio credette non riscaldarsi troppo per tali querele e le comunicò invece al regio giudice, allora assente, rappresentato in quel momento da un vice-giudice, che rivestiva ad un tempo la divisa di ufficiale della guardia nazionale. Non parve v«ro a costui, libero pensatore, di potere affermare illico la sua autorità, sicché, deponendo la toga e imbrandendo la spada, ordinava che un drappello di guardie lo seguisse’al convento per gettarvi entro alle pacifiche mura Io scompiglio ed il terrore. A mezzogiorno, infatti, i frati che stavano per andare tranquillamente a refettorio, si videro assaliti da un nugolo di armati, nonché da una turba densa e rumorosa, e fatti segno in un attimo ai più aspri insulti, alle più volgari contumelie. Acciuffati taluni come i più capitali avversarli del p. Urbano, furono a furia di ceffoni, di pugni e di calci messi fuori del convento, e, quindi, chi a piedi fin con la bisaccia in ispalla, chi in vettura, quei miseri zoccolanti furono inviati, pesti e malconci, ai loro paesi. D’altra parte quei che potettero sottrarsi alle violenze, presi da sgomento, fuggirono a gambe levate, tra cui l’ex-provinciale, tale Stefano Cusano, che andò, più morto che vivo, a rifugiarsi nella chiesa del Salvatore. Ma mentre i frati di qua e di là si allontanavano, gementi e desolati, dal loro sacro nido, quivi i militi nazionali, stanchi per la grande opera compiuta, e solleticati da un odore provocante che usciva di cucina, mossero gl’ingordi ad occupare i vedovi posti alle mense del refettorio, ove si rifocillarono di saporiti manicaretti, annaffiati da vin garbo. Dopo di che fu dato ordine di forzare la porta della cella del p. Stefano, e di eseguire una perquisizione nel suo scrignetto privato, che misero sossopra, e da cui sequestrarono circa cento ottanta ducati in spiccioli di oro e di argento, frutto di personali economie come oratore sacro e come provinciale dell’Ordine, ma che si disse invece, con malizia, fosse danaro accumulato per fomentare una reazione all’attuale regime sociale; il che, poi, su formale istanza del paziente al procura¬ore generale in Lucerà, non venne affatto provato. La gazzarra di quel giorno ebbe intanto un finale ancora più grottesco, giacché vuoisi che i banchettanti del refettorio, prima di andar via, abbiano voluto far capolino nella ben nudrita dispensa del convento, asportandone, come tenero ricordo, delle provvigioni da enfiar l’epa, e non tralasciando altresì molti e molti fiaschi di quel nettare gagliardo, che non avea guastata fino allora la santità dei frati, e che d’ora in poi avrebbe apportato invece ad altri sanità ed allegrezza.
E non v’ha dimenticato altresì che dal convento dei cappuccini il 6 febbraio ’61 si passò dalla stessa turba focosa a cantare canzonacce da trivio sotto le finestre delle claustrali, e quindi si riuscì a pervenire sin sull’usciale del conservatorio di s.a Teresa per ottenere che un’ orfana di vita esemplare, quivi ricoverata (1), ne fosse espulsa e rimandata al suo paese nativo, perchè sostenevasi eh’ ella tenesse un certo carteggio col suo padre spirituale, tal frate Francesco, anch’esso cappuccino, cui raccomandava sempre di pregare Iddio nelle sue orazioni per la pace e pel ritorno del passato re Francesco II. Né ai dinieghi, né alle proteste, né alle lagrime della povera reclusa si volle credere e cedere dalla folla Imbestiata, tanto che, a sottrarla alle torture morali del momento nonché ad un penoso viaggio, la baronessa Caracciolo, una veneranda patrizia del luogo, si offriva a torla con sé, scongiurando così ogni ulteriore follia.
Ma le persecuzioni alle singole persone per ipotetiche cause politiche furono innumerevoli. Infatti, nella notte del 14 aprile ’61, sospettandosi che, di accordo col vescovo, si volesse promuovere una reazione clerico-borbonica, subirono una visita domiciliare i sacerdoti Antonio Russo, Achille Altamura e Antonio Rubino. Dopo aver frugate però nelle loro carte e messine sossopra i ripostigli più intimi, nulla di criminoso vi si rin-venne. E fu, inoltre, il 15 di gennaio ’62, arrestato nella propria casa il consigliere d’intendenza Antonio Cortese, sospettato anch’ egli di aver congiurato con reazionarii e specialmente con un tal Vincenzo Buono, che, alla sua volta, avea del pari compromessi i signori Gaetano e Arcangelo de Peppo, Giuseppe Modula, Gennaro de Cesare, Gabriele Garofalo, Egidio Francescone e Pasquale Contini, che furono tutti, perciò, tratti in arresto in Foggia la notte del trenta dello stesso mese ed anno, imputati di tentativo di sovversione dell’attuale ordine politico-sociale. Però dopo essere rimasti per due mesi in carcere, furono, il primo di aprile, rimessi in libertà Cortese, Modula, Garofalo, Francescone e Contini per non trovarsi luogo a procedimento penale contro di loro, mentre gli altri tre furono rinviati a giudizio correzionale innanzi al giudice regio di Foggia.
E subirono del pari, in diversi momenti consecutivi, altre perquisizioni, altre visite domiciliari i sacerdoti Gaetano Zammarano, Antonio e Michele Russo, nonché i signori Gaetano Della Rocca, Francesco Saverio e Domenico Freda, senza che un accenno qualsiasi di colpabilità da parte loro abbia potuto ciò mai autorizzare.
Ma si raggiunse addirittura il climax nella persona del vescovo della diocesi, monsignor Bernardino Maria Frascolla, mercè non poche propalazioni e denunzie anonime. Contro costui però, a dir vero, potea dirsi esistesse almeno un certo addentellato in sospettarlo di poco attaccamento alle libere istituzioni, e ciò per i suoi precedenti ostili al riconoscimento dello statu quo, sebbene, in fondo in fondo, poi mancasse giuridicamente ogni prova che al pensiero abbia tenuto dietro talvolta un’azione qualsiasi, e che quest’azione abbia assunta la figura d’un fatto delittuoso, di un formale attentato alle libere istituzioni. In seguito ad un’ inchiesta governativa, infatti, quando vi mise un pò lo zampino principalmente quel Gherardo Santaniello, che era stato dal Frascolla elevato un dì alla dignità di canonico teologo del Capitolo e a rettore del seminario, venne formulata l’accusa specifica di avere colui comunicato al clero istruzioni avute dal Vaticano intorno al plebiscito; e questo fu elevato a tal grado di colpa da farlo immolare, senza misericordia, alle odiose Erinnidi. Il suo spirito battagliero per la fede, la sua profonda dottrina, l’oratoria non comune, che lo facevano additare come il Bossuet delle nostre contrade, non valsero a guadagnargli le attenuanti in un fatto, di cui, se vi fosse stata pur la parvenza della verità, non sarebbe stato mai responsabile per non avere avuta libertà di volere, ma per avere agito, invece, sotto coazione dell’autorità vaticana, cui non poteva ribellarsi. Né valsero quelle doti veramente singolari a mitigare l’acerbità felina dei suoi avversarli o a disarmarne completamente la mano. La persecuzione dei tempi, come dissi, irrompeva ciecamente e a preferenza sul tricorno o sul capo di tutti gli ecclesiastici come ceto, quasi fossero considerati, per assioma, ostili al progresso della nazione. « Contro lui, — scriveva in difesa del Frascolla un dotto prelato, nostro concittadino, che alla sua volta ebbe pure a subire delle mene politiche con la carcere e con l’ esilio senza l’ombra del peccato, vò dire Pasquale Fuiani, onore della cattedra e del pergamo,—prima della censura dei tribunali, si armò la calunnia, potente ausiliatrice dei malvagi, tenebroso lavoro capace di demolire, al cospetto del popolo, il buon nome irreprensibile di coloro che al potere camminano pel sentiero della, giustizia. La calunnia, acquattandosi tra le ombre d’un libellista anonimo, dipinse il vescovo nemico della libertà politica, sollecito soltanto a fondere la lana al gregge, corruttore della morale, simoniaco e peggio; e ciò corroborato da fatti, attinti alla officina della megera. Checché ne sia, l’anonimo libello, all’assalto improvviso, scosse la massa della cittadinanza e rese muto il clero, benché indignato dalla proterva audacia. Tutti però dovevano esser cani muti, non valenti a dar fuori un latrato ? A sostener la guerra mi esposi io solo a difendere una causa giusta, sospinto altresì dal mio carattere propenso alla polemica, inspirata dalla scuola di filosofìa, sdegnoso di ogni vile ingiuria al merito e all’ingegno, e stretto al vescovo in quei momenti di abbandono e di timidezza (1) ». Ma a nullavalse, come dicemmo, per la pubblica opinione e pel magistrato anche la parola disinteressata spesa in suo prò da uomini eminenti, a nulla valse la difesa degli onesti e dei probi. Bernardino Maria Frascolla non potè esimersi dalla responsabilità di avere imposto a confessori, suoi subordinati, di negare, nell’ occasione del precetto pasquale dell’ anno 1862, in contraddizione delle disposizioni del governo ma in conformità della bolla pontificia, V assoluzione a quanti votarono pel plebiscito. Per il che ebbe a compromettersi altresì il canonico-penitenziere Vincenzo Cbiulli, che sì fatta assoluzione avea negata ad un cotale che corse a riempirne il mondo, e che riuscì a farlo trascinare al carcere nella notte del 21 aprile ’62, donde ne usciva appena dopo tre giorni con libertà provvisoria.
Il Frascolla, arrestato il ventisette dello stesso anno in Andria, sua patria, ove trovavasi pel momento, giunse, con una scorta di quaranta lancieri a cavallo, il ventinove consecutivo in Foggia, ove rimase in s. Domenico custodito dalla forza pubblica fino al giorno ventiquattro maggio,quando fu menato a Lucerà pel giudizio,comune al Chiulli.Dopo diversi differimenti, avveratisi durante circa tre mesi per mancanza di testimoni e per varie eccezioni di rito proposte dalle parti, si toccò finalmente la riva il 30 settembre 1862. Il dibattimento riuscì importantissimo per concorso di pubblico e per le svariate questioni giuridiche accampatesi dalla difesa; ma Bernardino Frascolla fu alfine colpito da una sentenza di tre anni di prigionia e di ducati quattromila e cinquecento di multa, e, contempo-raneamente, Vincenzo Chiulli riportava la pena afflittiva di un anno, nonché quella pecuniaria di ducati seicento. Tale sentenza fu resa esecutiva il 1.° febbraio 1863, avendo la Corte suprema di giustizia rigettato in Napoli il relativo ricorso prodotto dai condannati. Il Frascolla dovette, intanto, senza misericordia alcuna, il 9 di maggio 1863, partire per Como, luogo di sua espiazione, mentre, per contrario, il Chiulli, con decreto sovrano, partecipatogli il tredici di luglio, veniva graziato da ogni pena.
Ma le persecuzioni non ebbero ancora tregua, che novelle visite domiciliari e novelli arresti vennero perpetrati il 27 marzo 1863 in danno dei sacerdoti Antonio Rubino, Giuseppe Parisi e Pasquale Fuiani, quale ultimo nel suo libro dei Quattro decennio, dopo aver ricordati con raccapriccio i travagli subiti per lo passato, spiegava l’attuale odioso provvedimento col dire che mentre il governo, rappresentato dai prefetti successivi della provincia, ebbe riguardi verso di lui, gli avversari! politici, invece, ordivano trame, perchè si fosse inflitto un qualsiasi castigo a chi difese il vescovo, lasciando alla stampa anonima stringere vuota l’ ugna. L’occasione infatti non tardò a presentarsi, imperocché fu lanciato al pubblico un opuscolo a stampa dal titolo Una protesta municipale ed una protesta popolare, senza data, senza firma e senza indicazione di tipografia, che censurava e confutava un voto municipale del marzo 1862, deliberatosi dal sindaco Scillitani e da venti consiglieri per la caduta del potere temporale del pontefice (1), e gli avversarli, profittando dell’ ombra dell’ anonimo, rinfocolarono il sospetto che quell’ opuscolo fosse opera dei fidi seguaci del vescovo. Per lo che i tre che si mostrarono più apertamente impavidi ammiratori del carattere del vescovo, cioè Antonio Rubino, Giuseppe Parisi e lui, primi nelle file dei giovani preti, si videro, alla sprovvista, assaliti da una visita domiciliare, perquisiti negli scrigni e senz’ altro menati in carcere. La soddisfazione si ottenne così dagli avversarli, ma essi non se ne dolsero punto ; e, sotto l’usbergo della coscienza di sentirsi puri, passavano il tempo alla men triste tra le chiuse pareti, quando il governo, per mezzo del giudice istruttore, in men di un mese, andò a salutare i voluti rei politici, dicendo : « Siete pur liberi, perchè non v’ è luogo a procedimento sull’ accusa vostra ».
E si aspettò la legge Crispi del 1.° maggio 1866, con la quale istituivasi il domicilio coatto, per dare addosso senza pietà a tutti coloro che già trovavansi designati a non dover rimanere tranquilli nelle proprie case, e furono, per conseguenza, inviati il pro-vicario Antonio Zicari a Torino, Gaetano Della Rocca a Napoli, Francesco Celentano a Chieti, Carlo Giannini ad Ancona, così come vennero esiliati del pari i sacerdoti Giu¬seppe Pilone, Michele Russo, Giuseppe Parisi e lo stesso
(1) I venti consiglieri furono : Pasquale Saggese, Vincenzo Campanella, Raffaele ‘ Nannarone, Michele Parisi, Luigi Ricca, Gaetano Longo, Giuseppe Raho, Liborio Del Conte, Saverio Salerni di Rose, Vincenzo Capozzi, Vincenzo Caposeno, Antonio Bianco, Eugenio Cito, Giambattista Cicelìa, Giuseppe Nicola Cavallucci, Gaetano Postiglione, Giuseppe De >*isi, Tommaso Mucelli, Antonio Carelli e Aurelio Mele.
Pasqnale Fuiani, che non lasciò di stigmatizzare questo novello atto di sopraffazione nel succennato scritto, col dire : «Fu allora che si sancì la legge del domicilio coatto a infrenare coloro che erano creduti avversi alla politica del governo ita¬liano. Eh ! tra costoro si potevano risparmiare i fidi del vescovo Frascolla, il quale languiva nel castello di Como, reo politico ?… Dei tre, uno non era più, improvvisamente morto per una caduta dal legno in campagna, rapido correndo per non mancare al suo dovere nella processione del Corpus Domini. Ahi lugubre ricordo di miseranda sventura !.. Gli altri due subirono la seconda volta il carcere. Questo, a dire il vero, fu inaspettato per me, perchè dopo la disgrazia avvenuta in famiglia per la morte di mio fratello maggiore, io mi ero sobbarcato interamente alla educazione degli orfani nipoti, e, affaticato di più nella occupazione delle scuole, dimenticai affatto la politica. Onde spensierato e nulla sospettando, io in un giorno mi recai a Sansevero per una gita di piacere in casa di un mio amico, di cui tenevo nel mio piccolo istituto un figlio. In quel giorno, dopo pranzo, fui là arrestato e menato in carcere. 11 giorno dopo, pertanto, fui visitato dal sotto-pre¬fetto, il quale, meravigliato dissemi : — Come ! qui lei, professore ? — Ed io a lui : — Io non so ben ridir come c’entrai ! — E dopo, facendomi delle interrogazioni in politica e attin-gendone risposte sincere, schiettamente si dolse dello sbaglio preso in prefettura. Incontanente ne informò il prefetto Scelsi, il quale, dopo accurata e coscienziosa inchiesta, convinto del nobile compito che a vantaggio della gioventù io, estraneo ad ogni intrigo, esercitava nel paese, correggendo l’errore politico, telegrafò mi si desse la libertà ! E, contento di aver tenuto con me un colloquio in prefettura, ei ben volentieri mi mandò libero a Napoli senza sorveglianza di sorta, illudendo così innanzi agli avversarli l’ordito domicilio coatto ». In seguito, intanto, di un decreto di amnistia del novembre 1863, mercè il quale abolivasi l’azione penale per tutt’ i delitti commessi fino alla data del detto decreto, riguardanti reati politici, di stampa e contravvenzioni a regolamenti speciali, il Frascolla riacquistava la libertà; ma egli ritornò alla sua diocesi non prima del 24 novembre 18(56, quando venne ospitato in casa dell’ arciprete Zicari, perchè l’ episcopio trovavasi addetto a dimora del maggiore dei carabinieri Bernardo Della Corte ed a quartiere di essi militi, e che potette rioccupare appena il vegnente 2 dicembre 1867. Il povero prelato avea però contratto a Como un gravissimo malanno ai bronchi, che fu mal curato, e che non lo lasciò più mai. Fu quindi per questo che, dopo il suo ritorno, durante circa tre anni egli si alternò sempre fra letto e lettuccio, e dovette spesso chiedere alle aure salutari native un pò di ossigeno più puro e vivificante per la sua esistenza che pur troppo correva a disfarsi. Fu per questo, finalmente, che nell’ anno 1869, con un tale organismo sì indebolito e stanco, non seppe opporre resistenza alcuna ad altro violento morbo, un favo al collo, sopravvenutogli in Roma, ove trovavasi pel Concilio ecumenico, sicché dovette a quello, in pochi giorni, fatalmente soggiacere. Bernardino Maria Frascolla morì, nel cinquantesimo anno di vita e tredicesimo di dignità vescovile, alle dieci antimeridiane del 30 dicembre 1869, bene-etto dal pontefice Pio IX, che si recò due volte al capezzale del suo letto di agonie, e la scomparsa di lui fu di sincero e grave cordoglio per quanti ebbero ad ammirarne, fuori di ogni ambiente politico, le qualità peregrine come filosofo ed oratore.
« Ma, oltre alle persecuzioni, agli arresti, ai domicilii coatti, ai processi, provocati contro tanti nostri concittadini, ad opera specialmente di anonimi denunziatori, la plebe, instigata ed inconsciente, non tralasciò, d’ altra parte, occasione per dare sfogo ai suoi istinti brutali, e fin da tempo era riuscita a dominare la piazza a detrimento della comune tranquillità e decenza. E mentre, infatti, il 15 settembre ’60 la rappresentanza municipale, gì’ impiegati d’ ogni ramo e la maggioranza dei veri liberali di Foggia avean mandati indirizzi entusiastici al dittatore in Napoli, taluni audaci avean preferito invece di recarsi alla cattedrale e di capovolgere ivi con violenza e per isfregio la sedia episcopale, come suolsi praticare in caso di morte del vescovo, non ostante che i custodi, accorsi, vi si fossero con violenza opposti. La qual cosa fu riferita presto al vicario, funzionante da capo ecclesiastico, il quale fece sul momento ricomporre il solio come prima. Tale disposizione, è da figurarselo, provocò un ribollimento d’ira in quei tristi, i quali corsero a reclamare dal sindaco marchese di Rose, sperando di trovar braccio forte in tanta cattiveria. Ma quegli, invece, qual supremo moderatore dei troppo accesi suoi amministrati, fece loro notare con bei modi la sconvenienza dell’ atto commesso, e li rimandò con le pive nel sacco e la coda tra le gambe.
Ma non acquetatasi la plebe a quel primo tentativo fallito, a violenze aggiunse ormai ulteriori violenze, rimaste sempre per ogni verso infrenate. E ad avere, in altro momento, uno sfogo selvaggio qualsisia, la si vide per diverse sere turbinare in piazza Portareale, ove il p. Domenico da Sannicandro, frate dei riformati, si dette a rinfocolare maggiormente gli animi con un sermone da ossesso, pronunziato dalla banchina di sotto al palazzo Piliasi ; e la sera vegnente, imbaldanzito del primo tribunizio successo, saliva su d’ una panca a Capo di piazza, insinuando loro che e a volersi ottenere per davvero l’unità italiana dovea promuoversi una rivolta contro le spie. E spie erano, a suo dire, tutti coloro che simulavano indifferenza in politica, e che si smaltivano come gente dabbene. Era contro di costoro, dunque, che bisognava — conchiudeva il frate — portar guerra ad oltranza per distruggerli, per irremissibilmente disperderli. A tale sciocca.ed insensata conclusione un grido solo uscì da mille fauci come ruggito di affamato leone, e la fiumana spaventévole di quei corpi umani si mosse in un at¬timo, e mille pugni si levarono in alto, armati di mazze, di roncole e di pietre, minacciando rovina e sterminio. Ricominciò quindi la ributtante gazzarra, indegna d’ un popolo civile, con imprendersi a vomitare contumelie a dritta ed a manca, senza aver più riguardo per chicchessia, e a fracassare i vetri ai balconi e alle finestre delle case di parecchi signori, fra’quali vi capitarono, a preferenza, due egregi consiglieri della intendenza, due perfetti gentiluomini, i signori Vincenzo Celentano e Antonio Sorrentini, nonché il povero arciprete Santoro, che non aveva altra colpa se non quella, di portare un cognome, comune per ragione di legami di sangue al noto sotto-intendente di Barletta, un funzionario destituito in omaggio alla pubblica opinione. La turba feroce invase fin le silenti e tranquille stanze di costui in via Bruno, che si ridussero, in un attimo, sotto la grandine di colpi indemoniati un ammasso desolante di rottami.
Il ff. governatore marchese Pietro De Luca cercò di fare infrenare gli sconsigliati dalla truppa ivi sguinzagliata, ma la plebe mostrò sulle prime di non voler cedere a niuno, ma di volere invece continuare ad oltranza nell’opera sua dissennata. Un allarme propagossi allora in tutta la città, e si udì d’ogni parte uno sbatacchio di porte e d’invetriate, quasi che si volessero tutti barricare nelle proprie case contro un branco di fiere, scappate dal serraglio, e che si aggirasse per le strade in cerca di preda.
Le impressioni però prodotte dal pepato scilinguagnolo dell’imprudente frate ebbero, per fortuna, a impallidire man mano e a dileguarsi; sicché presto ritornò la calma nelle file della plebe, che volle però, come suo ultimo scatto esplosivo, intimare a tre oratori sacri della città, al Santaniello, al Zicari e al De Stasio, sotto minaccia di chissà qualcosa, dì non pro¬nunziare per quell’anno alcun quaresimale nelle chiese foggiane. E così l’insulto di spia, lanciato a torto contro i migliori a solo scopo di denigrazione, ebbe a ritornare in gola del suo autore con una celerità eh’ egli stesso non potea prevedere. In seguito di che Vincenzo Celentano volle, disdegnoso, dimettersi da consigliere d’intendenza, mentre Antonio Sorrentini rimaneva in disponibilità; e, in loro vece, furono nominati, nel gennaio di queir anno, l’avvocato Pietro De Plato, abruzzese, e Raffaele Granata, lucerino.
XIX.
Foggia sotto il nuovo regime non ebbe certo quello slancio morale e materiale che aspetta vasi, avuto riguardo alla sua qualità di capoluogo di una provincia importantissima del Mezzogiorno d’Italia, qual’è la Capitanata. E, per vero, in tutte le manifestazioni di pubblico progresso essa rimase sempre in coda alle altre primarie città sorelle, che sin dal primo dì si avvantaggiarono non poco delle libere istituzioni. Eppure non ebbero a mancarle volontà e forza per trasformarsi, per elevarsi ancora più sul suo seggio, irradiata dal benefico raggio di civiltà e di redenzione. Una fatalità nuova, imperscru¬tabile, misteriosa la tenne quasi sempre in abbandono; non un sorriso da parte del governo, non un segno di predilezione o almeno di riparazione ad ingiustizie patite, per talune delle quali essa non potè acquetarsi, come già vedemmo, e non lo potrà mai e poi mai per l’avvenire.
E sarebbe stato davvero atto doveroso di equità e di giustizia il restituire finalmente al capoluogo il suo tribunale, e riconoscerne l’antico e indiscusso diritto, quando, ricomponendosi nell’anno 1861 le circoscrizioni delle Provincie meridionali, specialmente per l’aggregazione avvenuta di diversi Comuni di Terra di lavoro, di Avellino e di Capitanata alla nuova provincia di Benevento, si venivano a stabilire per ciascuna le relative sedi giudiziarie. E sperò Foggia allora, seriamente sperò dal governo d’Italia la riparazione dovutale da tempo (suum cuique!), illusa, ora più che mai, che la legge non fosse più la “suprema volontà d’un despota, ma il portato di una retta ed intelligente coscienza nazionale, rispecchiante della saggia ed antica massima : iustitia de coelo prospexit. E con essa sperò la sua legale rappresentanza amministrativa, che emanava a tale scopo unanimi deliberati e fervidi voti al governo, e sperarono quarantuno altri municipii della provincia, che inviarono all’uopo nel 1861 formale istanza al Parlamento s.ubalpino, dove l’ on. Giuseppe Ricciardi, nella tornata del diciotto giugno di queir anno, si fece a commentarla con queste frasi pur troppo incisive: «Essendo deputato di Foggia, la Camera mi permetterà di aggiungere qualche parola su questa petizione. Essa si raccomanda all’attenzione vostra per quattro titoli : Primieramente, siccome disse l’onorevole relatore, perchè si trova appoggiata da trentotto delle principali comunità di Capitanata, alle quali ultimamente sonsi aggiunte tre altre, cosicché vi sono quarantuno Comuni che la propongono. In secondo luogo Foggia è una città centrale, assai importante per la sua popolazione di trentamila abitanti, (1) mentre Lucera ne ha appena dodicimila. In terzo luogo vi dirò che la legge organica è affatto in favore di Foggia: — non vi sono nell’ ex-reame di Napoli se non tre eccezioni a questa legge, cioè Trani, Santamaria e Lucera, nelle tre Provincie di Bari, di Terra di Lavoro e di Capitanata, ove la residenza dell’ autorità giudiziaria non è la stessa di quella del governatore, il che è causa di varii gravi inconvenienti per le popolazioni. Infine, restituendo i tribunali al capoluogo amministrativo di queste provincie, si farebbe un risparmio annuo di lire dugentomila, il che certamente non è da disprezzarsi. Per tutte queste ragioni io appoggio le conclusióni della Commissione pel rinvio della petizione agli ufficii della Camera ».
Oh ardimentose e folli speranze !… il gran vento della vita nuova, spirante intorno d’ogni lato, già dissolvevasi come nuvola per la povera Foggia, che pure una volta ne rimaneva delusa, ad onta degli sforzi fatti per riconquistare il suo più grande diritto. Dimostrazioni succedettero allora a dimostrazioni, deliberazioni a deliberazioni consiliari municipali, telegrammi a telegrammi, compilati dal ff. governatore Giustini e diretti al Ministero, mentre infinite, inesauribili polemiche si addensarono tra foggiani e lucermi in vista della riforma, alle quali volle prender parte, in difesa di Foggia, il chiaro scrittore Giuseppe De Leonardis di Serracapriola, segretario dell’ amministrazione dei beni nazionali, confutando un’anonima epistola lucerina in data del 20 marzo ’61, colma d’insolenze e di contumelie all’ indirizzo del capoluogo, con un opuscolo, ricco di documenti, tratti dall’archivio provinciale, e che gli guadagnò, in gratitudine, la cittadinanza onoraria foggiana .
Ripiombò, quindi, Foggia nel prisco abbandono, ormai convinta che la ingiustizia degli uomini abbia pur troppo interminabili tentacoli da sfuggire a qualsiasi mano generosa che voglia tentare di annientarla. E ripiombò essa più angosciosa di prima, come chi sappia non già di dover morire a giorno fisso, a scadenza determinata, ma, più duramente ancora, di non poter mai vivere, e di doversi invecchiare senza speme, in eterno disio !… Che se assai più tardi, nell’ anno 1885, il primo presidente della Corte di appello di Trani, con sua speciale ordinanza, convocava il Circolo straordinario di Assise a Foggia, anziché in Lucera, ciò fu quasi un brutto scherzo del momento, una vera ironia, perchè, mentre i foggiani, con grandi sacrifizii pecuniarii e col più gran fervore del sindaco marchese Giacomo Celentano, lo avevano dotato, nell’ ex-monastero di s.a Chiara, di una sede veramente degna, videro l’anno appresso, con maggiore disinganno, rinserrati per sempre i battenti di quelle porte a causa di ostili e di clandestine influenze. Innanzi a tale miserando spettacolo d’ingiustizie e di favoritismi, indefiniti e indefinibili, dica ognuno da sé se convenga meglio farla da Democrito o da Eraclito !…
E si ebbe Foggia, è vero, una stazione di ferrovie importantissima, una delle prime forse in Italia, ma ciò non fu certo dovuto alle simpatie del governo e quindi alla volontà e alla mano dell’ uomo, sibbene alla sua positura topografica, per trovarsi essa, al dir del Freccia, collocata come un ombelico in mezzo al Tavoliere, non altrimenti che della capitale del mondo cantò l’Ariosto :
Siede Parigi in una gran pianura, Nell’ ombelico a Francia, ansi nel core.
Foggia è venuta acquistando una rete immensa di ferrovie , da diventar davvero l’emula dei più grandi centri. Da Foggia, infatti, può dirsi si parta ormai direttamente quasi per tutte le città italiane, e da tutte si arrivi. Il novero delle linee grosse e piccole, che vi mettono capo, è addirittura infinito. E come centro naturale di tanti sbocchi che la collegano ai quattro punti cardinali della penisola, la sua importanza commerciale relativamente a grani, a vini, a formaggi, a lane, oh quanto maggiormente avrebbe dovuto andar migliorata, da poter divenire, senza gonfiatura alcuna, il più
{1) Un primo tronco ferroviario, Foggia-Pescara, fu iniziato dalla Compagnia Bastogi – fin dal 21 ottobre 1861 ; e quindi appena il 5 agosto 1863 si vide giungere da Manfre¬donia, provveniente da Ancona, la prima locomotiva portante il n.° 271, che, pel suo peso di dugentosessanta cantala, ebbe a trasportarsi col mezzo di quaranta buoi del signor Raffaele. Nannarone, cui fu dato un prèmio di ducati ottocento. Tale tronco fu inau¬gurato il 10 novembre 1863, quando la Compagnia BastOgi offerse, per 1′ occasione, nel teatro ai suoi impiegati un pranzo di trecento coperti, provveduto dal noto Donzelli di Jfapoli, con la spesa di ducati settemila. Poscia, prolungatosi questo tronco fino ad Ancona, venne esso aperto al pubblico il 25 aprile 1864. Consecutivamente s’inaugura¬rono poi : il tronco Foggia-Barletta nel 29 maggio 1864, quello Foggia-Trani nel 10 agosto 1864, l’altro Foggia-Bovino nel 7 dicembre 1866, e così via, sino al completamento Anale di tutta la importante rete ora esistente.
colossale emporio delle Puglie. Ma neanche questo è avvenuto finora, né credo, per sua disgrazia, stia per avvenire. Resti ancor vivo per altro, come aroma soave, l’ augurio che le fu fatto dal Gregorovius, nei suoi Ricordi di viaggio attraverso le Puglie, che ritorni essa la grande città agli antichi fasti di un tempo ormai lontano da noi, e venga su con rapido moto, destinata com’ è ad un avvenire sempre più considerevole.
Che se Foggia, in oltre, dopo la prima installazione di un uffizio telegrafico elettrico, avvenuta il 3 di ottobre 1858, ot¬tenne altresì una direzione compartimentale, questa le fu ritolta presto senza pietà, che il 15 dicembre 1863 un real decreto disponeva eh’ essa passasse a Bari, sito più centrale nelle Puglie, al pari di Cosenza, che dovè cederla a Reggio. Si tentò di reagire allora, si protestò, si pregò da tutte le classi cittadine, cercando in qualsiasi modo di scongiurare quest’ altro strappo al civico manto, ma tutto riuscì vano.
E, con la direzione compartimentale de’ telegrafi, Foggia perdette il Consiglio di prefettura per le materie contenziose, a causa della sua abolizione, Consiglio che estendeva la sua giurisdizione in sei provincie, formando per la nostra città un tribunale di occasione, ottenutosi, quasi in rimpiazzo dell’ antico tribunale della dogana, fin dal 1820 da Ferdinando I, come seconda Camera giuridica al Consiglio d’intendenza per gli affari contenziosi, relativi al Tavoliere di Puglia.
Col contenzioso del Consiglio di prefettura, disparì, dappoi, anche il tribunale di commercio, che erasi ottenuto da Ferdinando I fin dal 10 dicembre 1817, con facoltà ai giudici di vestir la toga ; tribunale che, in pochissime udienze, nel suo primo mese di attuazione, emise ben circa cento sentenze, senza che fosse stato in qualsiasi altra guisa rimpiazzato da checchessia; mentre a Bari, per converso, che ebbe a trovarsi nelle stesse condizioni, si credette necessario, a sostituire il perduto tribunale di commercio, d’instituire a dirittura una nuova sezione di tribunale ordinario, senza punto turbare con alcuna deminutio quello di Trani.
E perdette Foggia, altresì, la direzione delle gabelle, come del pari quella del demanio e delle tasse, che dal 1.° ottobre 1867 furono entrambe destinate l’una a Bari e l’ altra a Lecce. E indarno il sindaco, con tre consiglieri municipali, partiva il tre settembre di quell’anno alla volta di Firenze, allora capitale del regno, per ottenere possibilmente la revoca del duplice decreto : — essi ne ritornarono dopo tre giorni, il mattino del sei settembre, con le pive nel sacco e con la delusione nel cuore. Sicché la sera del primo di ottobre pur di queste due direzioni non rimaneva nella nostra città che il semplice ricordo.
inoltre Foggia stette ad un pelo per perdere il suo orfanotrofio, che un deliberato inconsulto di quel Consiglio provinciale, emesso in seguito ad una maggioranza di quattordici voti su ventitre votanti, voti dati, naturalmente, da’ consiglieri suburbani, nella tornata del 27 maggio 1870, col compiacimento del prefetto Malusardi, che osò, sull’ oggetto, financo di prendere nell’ aula la parola, provocava un decreto in data del diciotto settembre dello stesso anno, previo avviso favorevole del Consiglio di Stato, con cui si dispose il traslocamento di esso nel bosco di Deliceto, in quell’ ex-convento dei pp. liguorini. E ciò con l’intendimento di trasformarlo ab imis, quasi in onta ai titoli di fondazione, che rimontavano all’ anno 1832, e contro i dritti del Comune di Foggia, il quale aveva erogate ingenti somme per concorrere alla erezione di esso. E si deve all’indignazione di tutto un popolo, sollevatosi davvero col viso d’arme, e alla fierezza del consesso cìvico con a capo il sindaco Scillitani, che si dimise in massa nella seduta del sette di ottobre come segno di alta protesta, se Foggia quest’ onta novella non abbia sofferta.
Eppure vide essa moltiplicarsi tra le sue mura le scuole elementari popolari, quelle per cui in ogni tempo i despoti impiegarono ogni cura a tener lontane,come gl’insetti divoratori si sforzano di spegnere la pianta prima che venga in erba ed in fiore, e ciò per mantenere nelle masse invulnerato il posto all’ ignoranza, sola ed unica condizione possibile per poterle dominare a loro talento. Queste scuole però, in fondo, come nota il chiaro professore Antonio Lo Re, per effetto della , stessa loro organizzazione, non hanno poi presso di noi procurato che uno scarso profitto ai piccoli delle classi umili, mancando in esse « il soffio vivo e rigeneratore delle anime », tal che la scuola dell’alfabeto ben potrebbe chiamarsi scuola elettorale, anzi che educativa (1).
Ebbene, se da una parte essa vide pullulare le scuole elementari , dall’ altra dovè rassegnarsi a perdere le sue brave scuole universitarie, che costituivano per sé indiscutibile lu¬stro e decoro, anche di fronte agli altri capoluoghi che n’erano privi ; — quelle scuole universitarie, che erano state davvero per i giovani di Capitanata una grande palestra, ove non solo venivano ad elevare lo spirito alle alte e pure regioni della scienza, ma a trarne solo e non dubbio profìtto intellettivo, seguendo così un indirizzo oh quanto più preferibile dell’attuale, com’ ebbe a notare più tardi lo stesso Ruggiero Bonghi, indirizzo che rendea possibile alla borghesia di divenire professionista nella propria città o nel luogo più prossimo ad essa, presto, coi minori studii possibili e col minore dispendio. Esse perdurarono appena tre anni o poco più, dalla installazione avvenuta, come vedemmo, nel 3 luglio 1859 e sino a dopo il 1862, quando ad opera dei nuovi ordinamenti universitarli e alla nuova legge della pubblica istruzione vennero soppresse ed abolite ; mentre, posteriormente, nel novembre del 1864, lo stesso municipio di Foggia — vedi fatalità — per un certo dispetto al sindaco o a chi per esso, soppresse da sé, con gran dolore della cittadinanza, l’antica cattedra di agricoltura, esonerandone il degno titolare, e destinando l’onorario di lui in prò del comitato-medico locale.
Con le scuole universitarie, mercè decreto del dodici di ottobre, venne spazzato il collegio delle scuole pie, di cui fece parte quel Niccolò Borrelli, che, nato a Foggia da un mandriano, vestì l’abito del Calasanzio, e, profondo filosofo giobertiano, si elevò ai pinnacoli del tempio delle lettere da divenire amico ammirato e stimato dei più celebri dell’epoca, e che, dopo di avere avuto fra i suoi primi discepoli, a s. Carlo delle Mortelle in Napoli, Ruggiero Bonghi, fu prescelto nel 1857 a precettore dei figli di Ferdinando di Borbone in luogo dello sco-lopio p. Pompeo Vita di Torre Santa Susanna, il quale impazziva dal rimorso di avere infiacchito il principe ereditario con gli scrupoli e le paure religiose. Prese il posto, intanto, di esso collegio l’attuale liceo pareggiato, sotto il nome dell’illustre patriota e concittadino Vincenzo Lanza, e di cui fu primo preside, indimenticabile e indimenticato, il chiarissimo scolopio Ambrogio Marcangelo da Troia.
Alle scuole elementari popolari, sì maschili che femminili, sì diurne che serali, al ginnasio, al liceo-Lanza ben vennero, per semplice ragione di legge regolatrice del regno e non già per speciale concessione, ad aggiungersi, qual tesoro di pubblica istruzione e di educazione, le scuole magistrali, l’asilo infantile, le scuole tecniche (1), e un fiorente istituto educativo per civili fanciulle, affidato alle cure d’intelligenti suore, dopo che per alcun tempo ne avea rette le sorti, in modo ammirevole, una donna pregevolissima, che rispondeva al nome di madame Fleury. E il cui bello ed elegante edilìzio venne appositamente eretto, ad iniziativa del governatore Del Giudice, su di un suolo occupato una volta da sedici casupole indecenti, che vennero abbattute il 5 dicembre 1860, erogandosi dai fondi della Beneficenza pubblica, su gl’interessi diversi sino a queir epoca, nonché decorrenti tuttavia, del vistoso capitale della fabbrica dell’ orfanotrofio per una lite pendente, ducati cinquemila seicento trenta e settantacinque per lo acquisto delle suindicate casupole, e circa ducati quarantamila per la nuova costruzione.
E sebbene Foggia abbia, in epoca posteriore, ottenuto persino un Comizio agrario d’indiscutibile utilità (2), mercè il quale, istruendosi universalmente e razionalmente le masse nella coltivazione della terra, vanno estirpate le radici principali dell’abbandono dei campi, pure vide deperire di febbre lenta una delle
(1) Ls scuole magistrali maschili furono inaugurate il 17 luglio 1861 , cui seguirono il 3 giugno 1862, le scuole per le maestre delle fanciulle. L’apertura dell’ asilo infantile ebbe luogo il 27 gennaio 1862 al palazzo Civitella, mentre quella delle scuole tecniche 11 1.» dicembre 1866 nell’orfanotrofio provinciale.
(2) Il Comizio agrario s’installò in Foggia il 25 marzo 1868, con l’intervento dei rappresentanti di tutt’ i Comuni della provincia, quando si procedette alla nomina di Gaetano Della Rocca a presidente, di Raffaele Nannarone a vice-presidente, di Enrico Barone a segretario, e di Felice La Stella, Canese, Frattarolo e Tortora ad assessori.
sue più belle instituzioni, senza che nulla si sia mai fatto per sottrarla dall’ oblio, senza che nulla lo stesso governo abbia speso dal suo canto per salvarla dalla morte, vo’ dire : la Società economica di Capitanata.
Eppure questa Società, di cui fecero parte in ogni epoca chiari ed illustri nostri concittadini e comprovinciali, era surta un giorno a somiglianza dei gruppi delle remote Società dell’ occidente o del patronato dei tempi di mezzo, e potea dirsi la sintesi della civiltà antica innestata alla civiltà moderna. Moltissime erano le sue benemerenze, e, in grazia di esse, non poteva, né doveva andar distrutta. Benemerita verso l’industria olivaria, perchè, fu essa la prima che promise, in evo remoto, il premio di ducati venti a quanti avessero piantati ed assicurati per tre anni trecento fusti di ulivi, e il premio di d ucati quaranta a coloro che ne avessero piantati e assicu¬rati cinquecento per tre anni, e ne distribuiva dappoi ai proprietarii, gratuitamente, ben quattromila piedi. Benemerita pel perfezionamento dato alle semenze, dei grani, pei suoi studii sperimentali in difenderli dalla golpe, dal bufone, dall’ orobanca; per l’incremento dato alla coltura dei grani orientali, dei grani settantivi, dell’ opicino, della canape, del lino, delle barbabietole, dei fagiuoli del Capo di Buona Speranza, del giuggiolene, della robbia, nonché alle piantagioni dei prati artificiali con la distribuzione gratuita dei varii semi. Benemerita per l’impulso dato nel 1835 all’arte della seta, perchè per essa il governo dell’ epoca istituì dei premii fino a ducati centoventi per coloro che avessero offerte libbre cento di seta, ricavata da filugelli educati con foglia propria, tanto che dal 1835 al 1843 si videro sorgere in Capitanata, come per incanto, ben dugento cinquantamila alberi di gelso, e furono installate delle filande nelF ospizio della Maddalena in Foggia, ove si riusciva a raggiungere il 75 % nella filatura dei bozzoli. Benemerita per essere stata la prima, o forse l’unica, a introdurre in Italia le mucche e i tori svizzeri per migliorare le razze bovine, e le capre della valle di Mambrì, di cui tanto si giovarono il Gargano e il Valfortore, nonché gli arieti e le pecore di Sassonia e di Ungheria, votando un premio di ducati cento per coloro che propagassero lo innesto del merinos con le lane nostrali. Benemerita pel profondo esame dei fenomeni mete-reologici, e specialmente della grandine, facendo sorgere a tale scopo, con grande utilità pratica, un apposito gabinetto a Foggia. Benemerita per i suoi studii costanti i ed amorevoli di mineralogia ora sulla tarba papiracea del contado di Alberonà,ora sul solfato di ferro dei pressi di Castelnuovo, ora su’marmied alabastri del Gargano, per lo che si appresero solo per operadi essa le diverse proprietà e varietà del marmogiallo, delgiallo-antico, del pezzino-giallo, del carniccio-fiorito, del nerodi valle di Voltore, del rosso-fiorato di Calderato, del nero-antico di Torre di Fortore, del bardiglio-chiaro di S. Giovanni,del rosso-antico di Montealto, della breccia-persichina delle faldedi Càstelprignano, dell’ alabastro-bianco di Montemeliscio, dellalavagna di Valle di Fortore, che, lavorati, si adoperarono, or gli uni or gli altri, pel monastero degli ex-pp. Celestini in Sansevero, per le vasche della villa di Foggia, per la bella tavola esistente un tempo nella prima sala del museo di Portici, eper le famose colonne del palazzo di Caserta, per quanto ne assicurano il Galanti, il Fraccacreta ed il Manicone. Questa è storia e splendida storia; ma pur troppo era storia assai antica…, e dpvea perciò andare dimenticata, condannandosi a morte, senza rimpianti, un istituto, di cui Foggia, nel gran cimitero delle sue memorie, forse non trovò posto a segnare pei vegnenti neppure il nome (1). k
Ed a causa del gran movimento di truppe, cominciatosi a verificare per diverse ragioni di pubblico interesse, nonché per generale soppressione del monachismo in tutto il regno, di quel monachismo che si credette contrario, in tesi assoluta , ai bisogni ed alle tendenze della società moderna, quale aperto nemico della patria e della libertà, Foggia videsi prima assottigliare e quindi scomparire man mano tutt’ i suoi antichi e tradizionali monasteri di uomini e di donne, ultimo rifugio degli spiriti anemici o pletorici, fino a restarne senza. Sia stato ciò un bene o un male non è qui il luogo di discuterne. È certo però che gli uomini politici del tempo si divi¬sero in due falangi, l’ una contro l’altra armata, sostenendo opinioni e criterii sulla questione, perfettamente opposti e contrarli .
Procedutosi per conseguenza, come di regola, fin dal di 8 febbraio 1862 all’ inventario dei beni mobili ed immobili di quanti si erano per vocazione o per disinganni votati alla vita contemplativa, e ciò da un’ apposita Commissione, delegatasi dall’ amministrazione generale della Cassa ecclesiastica di Na¬poli, a norma del decreto del 17 febbraio 1861 (1), ed avveratasi, ad espletamento finale, la consegna dei relativi titoli al ricevitore del registro e bollo, successivamente prendendosi a continuo pretesto la deficienza dei quartieri per le truppe, senza punto preoccuparsi se queste restassero permanentemente di guarnigione in città o fossero quivi per semplice transito, da lasciar presto quei locali vuoti e deserti, cominciò, tra la generale commozione del popolino, il triste esodo di codesti religiosi nel luglio del 1862 coi frati cappuccini, che dovettero staccarsi perfino dalla loro chiesa antichissima e di gran pregio, trasformata poscia in istalla, cui seguirono, nel diciotto dicembre dello stesso anno, le monache dell’Annunziata, e poi, nel 28 aprile del 1863, i frati minori osservanti, cui tennero dietro, per ultimo, le monache chiariste, nel 2 giugno 1866, uscenti da un monastero che contava ben tre secoli di esistenza, come gli scolopii nel successivo novembre, ad onta che per costoro vi fosse l’eccezione di legge. Le sole monache del Salvatore,monastero fondato nell’anno 1700 dall’illustre napoletana suor Maria Celeste Crostarosa, dichiarata testé dalla Sacra Congregazione dei riti venerabile, furono quelle che vennero quivi sottratte dalla soppressione e restituite nella libera amministrazione delle proprie rendite, perchè ricono-sciute con apposito decreto, comunicato loro il 12 giugno 1862, come appartenenti all’ Ordine salesiano (2). I frati alcanterini, per contrario, subirono diverse vicende, con varia fortuna ; però, nel folto delle loro angustie, trovarono un valido protettore nel foggiano signor Matteo Barone, il quale fece fabbricare a sue spese e per loro uso e consumo due camerette nel giardino del convento, accanto alla chiesa, per lo che essi, pur cedendo tutto il locale ai soldati, potettero restringersi in quelle celle di proprietà privata, nonché in altro bugigattolo dappresso alla sagrestia, per potere officiare nel coro ed accudire ai servizii religiosi della loro chiesa. Eppure costoro con la limitrofa congrega del Carmine, nel 15 settembre 1864, a causa dell’ arrivo di un numeroso reggimento di cavalleggieri di Lodi, pel quale si pretendevano spaziosi locali, atti a deposito di casermaggio, stettero ad un pelo per perdere le loro chiese rispettive, che solo una sommossa popolare ‘imponentissima riuscì a salvare, inducendo il municipio, mercè i buon i ufficii del prefetto Gadda, a cedere, in loro vece, l’unica chiesa di s. Domenico.
Dalla evacuazione definitiva dei frati dai diversi conventi foggiani la nostra biblioteca comunale fu la sóla che ebbe ad usufruire notevolissimi vantaggi, biblioteca che, se può dirsi un moscerino di fronte alle migliaia disseminate per l’Italia e fuori, non lascia di essere anch’ essa uno dei tanti preziosi arsenali dello spirito, che spargono di mistici fiori le memorie del vero, del buono e del bello, e che confondono ed annientano la stupidità e l’ ignoranza.
Surta nel palazzo municipale il dì 30 maggio 1834, in seguito a rescritto sovrano del 19 giugno 1833, si ebbe in mente così di vederla collocata quasi su’ ruderi dell’ antica reggia dello avevo Federico II, che ebbe cura di raccogliere egli pure, ai suoi tempi, pergamene e volumi, mediante il concorso del suo fido ministro Pier Delle Vigne, che ne tenne del cuore ambo le chiavi, e in quel sito medesimo dove, l’ anno 1223, quegli avea fatto incidere nel marmo il decreto che nominava la sua diletta città di Foggia inclita, regale ed imperiai sede. E, munita sulle prime di pochi volumi, acquistati dal Comune, si ebbe, dopo alquanti mesi, vistoso incremento di «pere antiche e di ottime edizioni per un dono fattole, dal signor Gaetano Varo di Troia di tutta la sua libreria, del cui atto munifico ebbe a meritare lo speciale compiacimento del re Ferdinando II, che volle, in ricompensa, esimere, per questo, la casa di lui dagli alloggi militari, e accordare alla sua famiglia la prefe. renza nella elezione dei futuri bibliotecarii, qualora in alcun membro di questa concorressero le qualità a tale ufficio richieste. Ma essa si avvantaggiò di gran lunga delle diverse opulenti librerie delle Corporazioni religiose locali, concessele dal governo. Infatti si ebbe dai pp. cappuccini mille dugentotre volumi, che prima vennero ivi depositati e poscia le furono donati con decreto del guardasigilli, comuni cato al municipio dal prefetto della provincia in data del 17 settembre 1862. E si ebbe del pari dai pp. alcanterini altri mille quattrocento ses-santuno volumi, donati con decreto dello stesso ministro in data 19 settembre 1863 ; dai pp. minori osservanti altri cento-otto, concessi al municipio con decreto del ministro dei culti in data 28 aprile 1864 ; e, finalmente, altri mille quattrocentocinque dai pp. delle scuole pie. E si avvantaggiò, inoltre, anche nei locali, per essere stata trasportata il 1867 dalle’ poche stanze del palazzo municipale, che occupava sin dall’ epoca di sua fondazione, nelle larghe camerate dell’ abolito monastero di questi ultimi in s. Gaetano, bene ordinata nei suoi dodicimila volumi, elencati in due appositi cataloghi, sì per ordine alfabetico che per materia, a cura del bibliotecario del tempo signor Giuseppe Villani Marchesani, e in ventitre manoscritti, di cui qualcuno autografo, nonché fornita di nuovi, eleganti ed artistici scaffali sotto la direzione di un uomo geniale, dall’ ingegno vivo, elettrico, multiforme, che lasciava di sé, anche come musicista, assai buona memoria, l’architetto Gaetano Briganti
Per lo che codesto altare di sapienza, codesto panteon dei tesori del pensiero forma ormai il decoro e il lustro di Foggia, rispetto alle .tante altre città che ne sono prive ; e ben si nu¬tre intima fiducia ohe la rappresentanza civica, d’ogni colore e d’ogni tempo, voglia tenerne a cuore le sorti, addimostrando alle giovani generazioni, col fecondarne sempre un maggiore incremento, ch’essa non lascia tuttodì di disgravare con ogni sacrifizio la nostra contrada del peso più grave che la terra possa premere, al dir di Diogene, l’ignoranza, e che la vita del pensiero, pur troppo la sola degna dell’ uomo, sia tra noi, come nei centri più intellettuali e civili, la coronata trionfatrice.
XX.
Al palazzo della dogana, centro della vita politica ed amministrativa di Foggia, vi fu nei nuovi tempi un rapido succedersi di funzionari! nel governo della cosa pubblica dopo che il primo governatore Gaetano Del Giudice venne collocato a riposo, e dopo la parentesi delle funzioni tenutesi dal con-sigliere De Luca. Ma, a traverso di tale cinematografia, la cittadinanza foggiana cominciò a sentirsi, se non altro, garentita dai movimenti insensati della piazza.
E, infatti, nel 16 marzo 1861, giunse in Foggia il nuovo governatore di Capitanata conte Cesare Bardesono, giovane a trent’anni o poco più, pieno di vigore e di energia, atto a reprimere la baldanza ed il mal costume di quanti, profittando di un momentaneo disordine, cercavano di pescare nel torbido per mera bravata o per profitto.
Non appena dopo pochi giorni dall’arrivo di lui si videro per la prima volta in città venti carabinieri a cavallo, che fecero impressione brillantissima sulle masse per la loro alta statura, per l’eleganza severa dell’uniforme, per i loro cappelli a punta, piumati in rosso e turchino, nonché le prime guardie di sicurezza pubblica, che cominciarono a battere le vie, di giorno e di notte, quando, specialmente, procedevano al fermo di tutti coloro che destavan sospetti o per essere gente di male affare o per essere armati senza regolare licenza. Ciò, com’era da prevedersi, non piacque troppo ai facinorosi, i quali fecero loro dal primo giorno il viso arcigno, minacciando il finimondo se il sistema iniziatosi delle pattuglie non si fosse presto dismesso; che anzi ne presentarono, con meravigliosa improntitudine, reclami e denunzie al governatore. Questi, dal canto suo, si mostrò all’altezza del mandato, col fare intendere apertamente ch’ei trovatasi in Foggia non per prodigare favori a chicchessia, ma per far rispettare le leggi, come per prevenire disordini e reati. Tale dignitosa risposta dovè riuscire « savor di forte agrume » per quella gente, che nella sera del 24 maggio ’61 ricorse invece a mezzi violenti col contrastare in piazza Portareale materialmente alle guardie di girare per la città in servizio di perlustrazione. Per domare gli audaci fu messa sotto le armi la truppa, la quale, venuta subito in piazza, riuscì dopo i tre rituali squilli di tromba, con un vivace attacco alla baionetta, a sbaragliare la folla minacciosa, in seguito di che si vide cadere, ferito in una coscia, uno dei ribelli, mentre tutti si sperdettero per le vie ed i vicoli adiacenti, gridando a squarciagola: « Chiudetevi, chiudetevi ! » Le botteghe furono sbarrate con la rapidità del fulmine, perchè tutti erano stati presi dal panico; e gli stessi militi nazionali — incredibile a dirsi ! —, che avrebbero dovuto dar braccio forte alla truppa, abbandonarono anch’essi da tapini il Corpo di guardia, con generale scandalo e stupore. Il conte Bardesono, granitico nei suoi propositi e scevro da preoccupazioni, non appena vide sedata la rivolta, indifferente come se nulla fosse avvenuto, uscì a passeggio per le vie della città.
E, siccome in altre sere consecutive si cercò dalla plebe di tornare all’assalto con audacia più viva ed efficace, appiccando financo il fuoco al fabbricato di s. Domenico, ove risiedevano i carabinieri, il detto governatore rinsaldava vie più ogni mezzo di repressione, e invitava persino il procuratore, generale della Corte criminale di Lucerà a recarsi in Foggia per quivi iniziare procedimento penale contro gli ostinati perturbatori dell’ordine pubblico. Ordinava altresì che si moltiplicassero le pattuglie per la città anche con soldati della truppa, facoltati a. far fuoco alle prime avvisaglie ostili da parte di qualsivoglia persona.
I processi cominciarono a fioccare con i relativi arresti degl’insidiatori dell’ordine pubblico, tra’ quali capitò persino un custode delle carceri centrali (quis custodit custodem ?), che, ad accrescere ribelli e ribellioni, avea dato permesso ai detenuti di fabbricarsi da sé armi micidiali, come stiletti e pugnali, da servirsene anch’essi, all’occasione, contro carabinieri e guardie; permesso concesso, naturalmente, a prezzo di corruzione, giacché sin da quando esiste il mondo esiste il sottomano per la gente avida, che non si contenta della semplice paga, sottomano che oggidì, per ogni semplice ed anche innocente agevolazione o sin per nulla, è divenuto consuetudinario, quasi come se fosse dovuto per tariffa o per sottinteso, come il pour-boire al cocchiere parigino.
Tutto questo apparato di rigore produsse, qual bromuro, i suoi effetti salutari sul sistema nervoso di tanti sconsigliati, con che si ottenne, in pochi giorni, la desiderata pacificazione.
Ma non appena riguadagnata totalmente la calma e la tranquillità in Foggia, ridestavansi politicamente e in senso diverso, sulle vette del Gargano, le popolazioni di Vico e di Ca-gnano, ove una turba di reazionarii, con bandiere bianche e con grida di evviva a Francesco II, erano andati in chiesa a cantare il Te JDeum; e, dopo avere in oltre osato di tirare, come pazzi da catena, fucilate contro la effigie del re Vittorio Emmanuele, aveano proclamato, nel nome del primo, un governo provvisorio.
Il conte Bardesono, senza perdersi di animo, con una com¬pagnia di soldati, il 14 aprile ’61, partiva a quella volta. Sedata anche qui la rivolta, ne ritornava dopo dieci giorni in Foggia, chiamatovi con telegramma da quel segretario gener rale, perchè correva voce che migliaia di reazionarii venissero dalla Basilicata ad invadere la Capitanata per gettarvi lo scompiglio. Ma la voce parve infondata; ciò non ostante si richiamò in Foggia molta truppa, che fu sparsa, qua e là, su pel Tavoliere con l’intendimento di tranquillare tutt’i piccoli paesi circostanti, che si erano messi in un giusto allarme.
Ma, ad onta dello zelo e della energia mostrata in ogni evento, il conte Cesare Bardesono non rimase in Foggia che appena cinque mesi, giacché il 6 di settembre ’61 ei venne no¬minato intendente generale di Pesaro e surrogato in Capitanata dal cavaliere Alessandro Strada, cui dette la consegna dell’ufficio il dieci consecutivo, quando definitivamente lasciava la nostra città in mezzo al generale cordoglio.
Ma il povero Strada, che assunse dappoi il nome di prer fetto, si trovò a dover combattere il brigantaggio, surto come per incanto, secondo già vedemmo, e divenuto spaventevole per le sue mastodontiche proporzioni ; e perciò, nuovo com’era della provincia, non potette certo corrispondere all’aspettativa del Ministero, che lo ritenne, per conseguenza, indolente e forse anche inadatto a rimanere tuttavia al palazzo della dogana. E di questa indolenza ebbe un dì, con profondo suo dolore e col massimo scandalo in città, a sopportare acerbo rimprovero da parte di un suo subordinato, il consigliere di prefettura signor Pietro De Plato. Il quale, nel 1.° gennaio ’62, recatosi da lui per informarlo di un ricatto subito da parte dei briganti, insieme con un tal Michele Sigismondo di Roccaraso, nei loro rispettivi poderi in territorio di Manfredonia, uscì in frasi violentissime all’ indirizzo di lui, rimproverandogli tutta la noncu¬ranza e fiacchezza ch’egli addimostrava di fronte all’addensarsi del brigantaggio, contro il quale urgeva invece il contrapporsi di altre tempre che non la sua. II prefetto Strada, vistosi aggredito in sì malo modo, non seppe fare altro, in un primo momento, che indicargli l’uscita; ina, vedendo che quegli elevava il tono dei rabbuffi e delle villanie, scosse con forza il campanello, e al camerière che si presentò sulla soglia dette ordine di chiamare due carabinieri e di fare arrestare l’insubordinato. Ma, non essendo costoro arrivati in tempo, il De Plato ebbe campo di allontanarsi, continuando sempre a sbrai-tare e a vomitare insulti all’indirizzo di lui.
E magra soddisfazione si ebbe l’oltraggiato funzionario dal Ministero, in seguito a ben grave rapporto mandatogli, che la destituzione del De Plato dalla carica di consigliere, verificatasi per telegramma, non rialzò certo il suo prestigio, ormai demolito anche di fronte al governo, che nulla teneva segnato all’attivo di lui.
Dopo sette mesi appena da che Alessandro Strada veniva destinato a Foggia, fu traslocato a Ferrara, lasciando, per altro, dietro di sé memoria di gentiluomo perfetto e di persona socievole al sommo grado, per aver date signorilmente moltissi¬me serate danzanti nelle belle sale del palazzo prefettizio.
E il sei di aprile ecco un nuovo prefetto, di antica cono¬scenza, nella persona di Gaetano Del Giudice di Piedimonte di Alife, destinato, secondo il decreto del ventisette marzo di quell’anno, « a compiere le funzioni di prefetto senz’assegnamento », perchè, essendo egli deputato alla Camera elettiva, non poteva assumere alcuno incarico governativo retribuito. Egli, ricevuto da cittadini ed amici con affettuosi riguardi, si rivolse con pro¬clama ai suoi antichi amministrati, promettendo loro di spendere ogni sua attività nell’adempimento dell’alto e delicato ufficio affidatogli dal governo del re, e specialmente nella lotta contro il brigantaggio, da cui, con dolore, vedeva abbastanza oppressa la Capitanata intera.
Ma costui — è giocoforza dirlo — non dette questa volta di sé gran prova. Il brigantaggio continuava ad infierire ancora più, mentre la mano del nuovo capo della provincia non avea fatto sentire in alcuna guisa il suo peso, né aveva indicata alcuna direttiva diversa dal suo antecessore per poterlo annientare o per lo meno sminuire; che anzi finì per esser preso in beffe dagli stessi briganti, i quali, nel dì 20 aprile ’62, ebbero l’audacia di mandare anche a lui un pepato ricatto. L’essere o il non essere, insomma, di lui al palazzo della dogana era perfettamente lo stesso: l’azione militare procedeva da sé e si esplicava anche senza alcuna efficacia, né più né meno secondo si era sino allora praticato. Eppure tante promesse si eran fatte e tante speranze si erano carezzate per un avvenire migliore!… Che anzi vi fu un periodo di tempo, e fu l’ultimo pel Del Giudice, di assoluta inazione, quando pel fatto doloroso verifica¬tosi ad Aspromonte^ essendosi propagata un’agitazione in tutto il continente, e, per essa, sollevatasi del pari Foggia mercè dimostrazioni che succedevansi senza posa, inneggianti tutte, contro il volere del governo, all’azione garibaldina, il commissario straordinario per le provincie napoletane, Alfonso Lamarmora, metteva la nostra Capitanata sin dal 26 agosto ’62, al pari delle altre, in istato d’assedio, durato fino al diciotto novembre di quell’anno; in forza di che ogni potere sì politico che militare venne accentrato nel comandante generale della provincia. Fu questi, per conseguenza, che assunse issofatto e di dritto la suprema direzione della lotta contro il brigantaggio, spoglian¬done totalmente il prefetto, il quale ne rimase così a dirittura tagliato fuori.
E non ebbe bisogno d’interrogarlo neppure, allorché dal primo giorno si fece ad emanare disposizioni energiche contro coloro che protegessero quei ribaldi, mercè somministrazioni di armi, di munizioni, di viveri e in qualsivoglia altro modo, e allorché ordinava altresì la chiusura delle panetterie rurali e di ogni più piccolo locale campestre, che per avventura potesse addivenire loro comodo e sicuro ricetto.
Di lui si ricorda soltanto di aver data, con lodevole intendimento, una festa da ballo eminentemente democratica, invi¬tandovi persone di ogni classe, perchè si fossero affratellate tra loro, sotto un regime che non riconosceva più caste. Il Ministero, dunque, in vista degli scarsi servigi dal Del Giudice resi alla provincia di Capitanata, gli tolse nel 6 settembre ’62 l’incarico affidatogli un dì con fiducia ed entusiasmo, e lo mandò via da Foggia, senza dargli altra destinazione, a causa della sua qualità di deputato, che non permetteva l’assumere, come dicemmo, funzioni retribuite.
TI cinematografo, intanto, prefettizio continuò ancora con la stessa celerità e senza soffermarsi mai, che, l’ istesso dì in cui partiva il Del Giudice, giungeva da Manfredonia, ove era sbarcato la sera innanzi da Ancona, provveniente dal Piemonte, il nuovo prefetto avv. cav. Giuseppe De Ferrari, funzionario anch’ egli di fama eccellente, il quale si era fatto notare non poco, nello stesso ufficio, a Palermo ed a Lecce.
Costui, certamente, non- mutò d’un tratto la faccia delle cose, ma mostrò almeno di avere il coraggio di sapere affrontare, in momenti difficili, pur troppo scabrose posizioni, con l’intento costante e lodevolissimo di affermare e di ribadire sempre più il principio autoritario; giacché quanta autorità può conservarsi da chi non sa altrimenti evitare i disordini, se non cedendo alla piazza e sopprimendo, per farle omaggio, la propria autorità? E si spese del pari con energia per dare un possibile crollo al brigantaggio, che aveva ormai conquistate in Capitanata le più solide e profonde radici.
A dare un saggio del suo carattere, ricorderò che nel mattino del 30 dicembre ’62, vestito egli dell’ uniforme, con a fianco il relativo spadino e con in testa il cappello a punta, accompagnato da due consiglieri di prefettura, si presentava di sorpresa nell’ufficio di delegazione della polizia, sita nello stesso palazzo prefettizio, e qui procedette a fìtta e scrupolosa visita in ogni angolo, rovistando le scrivanie, gli scaffali ed i più intimi ripostigli del delegato capo e degli altri quattro sotto-delegati, nonché ad una perquisizione sulle loro stesse persone, dopo di che si condusse alle diverse loro case per ripetere colà le identiche materiali investigazioni, delle quali non ebbe a trapelarsi dagli estranei verun particolare. I cinque funzionarii di polizia, però, d’un colpo furono sospesi dall’ufficio. Succes¬sivamente la sera istessa ei delegava altro consigliere di prefettura per una visita domiciliare presso un ex-eonsigliere d’intendenza, un noto impiegato della prefettura ed un avvocato non foggiano, che risultò negativa solo pei due primi, mentre per il terzo, che pare nascondesse presso di sé qualche carta compromittente, si dispose lo arresto, sospettati tutti di avere relazioni clandestine coi briganti e di avere da loro persino ricevute forti somme di danaro. Ne mandò poi un vibrato rapporto al Ministero ; in seguito di che, il 28 gennaio consecutivo, il delegato-capo e i quattro sotto-delegati vennero, con apposito decreto, destituiti dalla carica e surrogati subitamente da altri funzionarii.
E fu lo stesso De Ferrari, che, fiutando come un bracco instancabilmente per ogni dove, riuscì a scovare altra preda nell’ interesse della pubblica quiete, assicurando alla giustizia, con generale stupore, quel p. Urbano, cappuccino ormai sì noto, il quale viveasi da gran tempo lontano dalla sua casa religiosa, e lo deferì al magistrato sotto una imputazione— come buccinavasi—perfettamente comune all’avvocato, testé ricordato, e ai cinque delegati destituiti, destituito anch’esso, nel gennaio ’63, per tale causa, dall’ufficio di cap¬pellano delle carceri di Foggia.Fu egli che, per smodata voglia di ficcare il naso anche dove non ci entrasse, gittò lo scompiglio, come vedemmo, fin tra persone dabbene e rispettabili, le quali, in grazia sua, oltre a visite domiciliari, come capitò ai fratelli Freda e Gaetano Della Rocca la sera del 23 aprile 1864, ebbero a soffrire arresti, domicilii coatti ed altre simiglianti umiliazioni senza l’ ombra del peccato.
Fu egli che volle ad ogni costo fosse riformato ed abbellito il palazzo della prefettura con peristilii e porticati nel cortile per dare, con nuove e parecchie anticamere, maggiore rappresentanza ai due grandi saloni ivi esistenti, ed affrontò, per questo, una lotta lunga ed accanita, riportandone però vittoria finale,strepitosa, contro quel direttore del demanio e delle tasse signor Luigi Abbadessa, che si oppose anche con mezzi giudiziarii, e che sosteneva non avesse il prefetto alcun diritto di rinnovare quelle fabbriche di proprietà del ramo Tavoliere, per gli interessi che vantavano su di esse i locati pastori di Puglia. Che anzi costui, il 9 di settembre 1864, per disposizione ministeriale, fu costretto, in conseguenza, ad uscire a dirittura dal palazzo, di unita al ricevitore del Tavoliere Luigi Corigliano, marchese di Rignano, e a prendere abitazione altrove, compiendosi così le vendette del De Ferrari per la sua autorità offesa.
Fu il De Ferrari medesimo che nel 23 ottobre ’63, non tollerando uno di quei palcoscenici di carta, dà cui ogni convulsione chiassosa, clamorosa, ingiuriosa, ogni atto istrionico si fa gustare alle masse,un dissolvente giornale locale,insomma, dal titolo La Daunia, barcaccia navigante duevolte la settimana nel buio mare della politica paesana, i cui marinai restavano quasi sempre ignoti, e che gli creava spesso con le sue artiglierie dei serii imbarazzi, ne soppresse la esistenza senza molti convenevoli e senza cedere innanzi ad. influenze o a rappresaglie.
Fu egli che, coadiuvato dal generale De la Roche, riuscì, come fu rilevato altrove, a scompaginare con ogni mezzo le file della banda brigantesca del famigerato Caruso, che, vistosi a mal partito, in compagnia della sola druda, varcava il confine della Capitanata per Molinara, dove venne soppresso con grande sollievo di tutti ; per lo che ebbe a meritare un indi rizzo di plauso e di gratitudine, il 18 dicembre ’63, da parte degli ufficiali tutti della guardia nazionale.
Fu egli che presiedette il Consiglio di prefettura quando ebbero da esso a giudicarsi parecchi ufficiali della stessa nostra milizia nazionale, i quali si erano stranamente ribellati al loro colonnello Na varrà, sottoscrivendo un indirizzo, con cui gli dichiaravano apertamente il malcontento e la sfiducia che nutrivano per lui. E mostrò pure una volta, in quella occasione, con deliberato del 4 giugno 1864, di saper garentire il principio di autorità, destituendo due di essi, Ferdinando Cipri e Francesco Paolo Pascarella, e sospendendone per due mesi altri diciassette dalle loro funzioni.
Fu egli, finalmente, per tacermi di altro, che, a garentire lo stesso prestigio di autorità, riesci a mettersi in lotta-con la rappresentanza comunale, eccitando così, senza forse neanche prevederlo, mercè il tenace e granitico suo operare, gli animi dei foggiani ad una futura seria divisione dipartiti, micidialissima per l’avvenire della città, e che trovavasi a quel tempo in condizioni meramente embrionali. Ed ecco come si svolsero gli avvenimenti :
In seguito alle elezioni amministrative, fattesi nel dì 11 gennaio ’63, dopo l’amministrazione straordinaria tenutasi dal commissario regio signor Tito De Amicis, consigliere di prefettura di Cosenza, venuto in Foggia il 27 settembre ’62 con decreto di scioglimento dell’amministrazione ordinaria, presieduta dal sindaco marchese di Rose, si riuniva il nuovo Con¬iglio in seduta pubblica il 26 gennaio ’63, con l’intervento del prefetto, e procedette, a norma di legge, alla nomina della Giunta, la quale risultava composta degli assessori titolari, signori Antonio Bianco, Pasquale Scoccherà, Gaetano Longo, Giuseppe Della Rocca, e degli assessori supplenti, signori Michele Parisi e Felice La Stella. Di costoro assunse provvisoriamente le funzioni di sindaco il Longo, come il più anziano di tutti. Non era passato gran tempo da tale insediamento che ebbero a verificarsi delle profonde scissure tra la Giunta e il comandante la guardia nazionale, colonnello Navarra, intorno ad un certo sistema di funzionamento di esso Corpo, sistema stabilito da quest’ ultimo in contraddizione dei concetti municipali, ma con la completa e piena soddisfazione ed approvazione prefettizia. La Giunta, per un tal fatto, si vide in aperto dualismo col capo della provincia, e deliberò di dimettersi irrevocabilmente. Rimasto per tal modo il Comune in un baleno addirittura acefalo, e creatosi all’ amministrazione cittadina un grave imbarazzo, fu assunta pél momento la firma di sindaco dal consigliere anziano signor Felice La Stella, aspettandosi frattanto le elezioni suppletive del prossimo nove giugno per altri quattordici consiglieri, che erano chiamati a surrogare altrettanti dimissionarii. Queste nuove elezioni, in verità, furono assai laboriose, stantechè parecchi giovani, agguerriti, scesero nei comizii a combattere contro taluni candidati, antichi amministratori del Comune ; ma i loro sforzi riuscirono completamente vani, perchè la lista liberale trionfò intera. Vi furono però molte proteste all’uopo, fra le quali una tendente a far dichiarare in eleggibili alquanti dei proclamati, che, quali passati amministratori del Comune, non avevano ancora, a norma di legge, dati i conti di loro gestione. La deputazione provinciale, chiamata in sede tutoria a risolvere l’ardua tesi, rigettò il reclamo, sicché il ventidue di giugno potè riunirsi il Consiglio in seduta plenaria e procedere alla nomina della nuova Giunta (1). E-rano però passati già circa quattro mesi senza che si fosse ottenuto ancora il sindaco titolare, quando il ventisei di ottobre per¬venne un secondo decreto, mercè il quale veniva assunto all’ alta carica il signor Felice La Stella. Tale scelta non andò a sangue ai maggiorenti del partito liberale e quindi alla rappresentanza civica, tanto che il sindaco, dopo aver prestato giuramen¬to alla presenza del prefetto, trovò il vuoto nelle sale della sede comunale il primo giorno che andò a prendere possesso. Il potere esecutivo gli avea dimostrata la sua ostilità con la com¬pleta assenza dagli ufficii. Ma il La Stella non si scompose per questo, e, entrando nel suo gabinetto, chiamò a sé tutti gì’ impiegati e dette loro direttamente, col suo saluto, le dispo sizioni intorno ai varii affari urgenti di amministrazione. Egli, però, che tanta spartana indifferenza avea mostrato in un primo momento, sentendosi spalleggiato dall’ autorità del prefetto, pure man mano ebbe a dar segni evidenti di sconforto per non vedersi coadiuvato affatto dai suoi colleghi della Giunta.
Si trascinò così innanzi alla meglio l’amministrazione per la durata di due mesi, sino a che il 2 gennaio ’64 la Giunta apertamente forzava la mano al sindaco perchè si dimettesse, alligando delle ragioni giuridiche o poco giuridiche, per dimostrarne, non so come, la decadenza già avvenuta. Ciò, naturalmente, venne, comunicato, come di regola, al -prefetto per i provvedimenti analoghi ; ma costui, pur facendo rapporto dello stato anormale delle cose al Ministero, non permise che i granchi mordessero la balena, e volle sfidare le ire dei liberali, piuttosto che cedere alle loro pretese di partito. Garentì quindi ad oltranza il sindaco La Stella ; e questi non si mosse dal suo posto per volontà esclusiva di lui, anzi vi restò fino al trenta gennaio susseguente, quando venne surrogato dal signor Pasquale Scoccherà, perchè il suo protettore non v’era più. Infatti Giuseppe De Ferrari, il 1.° settembre ’64, mentre veniva premiato dal governo del re per questa non comune rigidezza di carattere con la onorificenza di una commenda dell’ Ordine mauriziano, era contemporaneamente trasferito alla prefettura di Caserta.
In verità tutto ciò che il De Ferrari fece con tanto pertinace ed esagerato zelo non mutò poi gran, cosa alle prische condizioni della provincia, né segnò tale un solco pel suo nome da farlo oggi additare come la fenice degli amministratori, secondo forse, in fondo, lui stesso si credeva. Anzi, se ben ci apponiamo, lo si potrebbe rassomigliare, invece, a quel cavaliere romano, pro-zio di Pompeo, vissuto ai tempi di Scipione l’africano, che fu autore di ben trenta libri di satire, ma che di queste non riuscì a pervenire insino a noi neanche un frammento solo, tranne che il nome del poeta, Lucilio, e la sua rinomanza di uomo faceto, emunctce naris, flagellatore del vizio. Troppo scrisse costui, ed è quasi predestino inevitabile, per chi scrive troppo, lo scriver nulla che resista al tempo ; per la qual cosa Orazio, assai tenero della lima, punzecchiava questo poeta estemporaneo, le cui satire erano state scritte con rapidità sbalorditiva, dugento versi all’ ora :
in hora saepe ducentos Ut magnimi, versus dictabat stans pede in uno.
Venne, in cambio del De Ferrari, destinato a Foggia il lombardo cavalier Giuseppe Gadda. E costui che rimase al palazzo della dogana quattordici mesi e pochi giorni, assai si distinse nell’estate del 1865, epoca dolorosa, in cui buona parte di Capitanata, specialmente Sansevero, fu funestata dal terribile morbo asiatico, il colera. Fin dal primo affacciarsi di esso, il ventisei luglio di queir anno, ei corse in codesta città disgraziata, con medici e medele, e, fatto ritorno a Foggia l’indomani, prese ad emettere ancor qui provvedimenti igienici preventivi, come p. e. il far tenere accesi innanzi alle porte delle botteghe del fuoco di legna con pece (sic), e curò di fare approntare, or qua or là, locali di disinfezioni e d’isolamento. E, mentre dopo più giorni ritornava egli stesso, centuplicandosi, con nuovi medici a Sansevero, ove la malattia infieriva e dove era anche accorso il ministro di agricoltura on. Torelli, ne spedì altri a Sannicandro, ad Apricena, a S. Marco in Lamis, a Lucera, ove la brutta bestia esotica avea fatto pur capolino. Né si stancò mai da mane a sera di riunire al palazzo della prefettura e di presiedere, quasi in permanenza, la Commissione sanitaria per ogni più lieve misura da adottarsi in prò di Foggia, ohe n’ era perennemente minacciata dai fuggiaschi, venuti a prendervi asilo. Rimasto quivi solo sulla breccia, solo a combattere, per essere stato invano chiamato più volte il sindaco signor Pasquale Scoccherà da Napoli, ove trovavasi con la sua famiglia, a riprendere il suo posto in un momento sì terribile per la città, egli dovè necessariamente moltiplicare la sua energica vigilanza su tutti e su tutto, e trovossi sempre in mezzo al popolo, in ogni ora, in ogni momento, e trepidò con esso, e ne divise i dolori al capezzale degli attaccati, e ne secondò fin la fervida fede quando la sera del trentuno di agosto si gridava, inneggiando, allo stesso prodigio avvenuto per la prima volta nel 1837, e ripetutosi allora allora nella chiesa di s. Giovanni, del rivolgersi cioè degli occhi al cielo di quella Mater dolorosa, ivi esistente, quasi a preghiera di salvare la città, dal flagello.
Che se le benedizioni di tutto il popolo di Capitanata lo compensarono ad usura delle tante cure affettuose prestate in prò di esso, il governo del re volle pure addimostrargli il suo compiacimento, fregiandolo della commendamauriziana, mentre, d’altra parte, con decreto pervenuto il 23 agosto ’65, destituiva il sindaco di Foggia, che aveva abbandonato il colera sulle ginocchia della Provvidenza.
Giuseppe Gadda lasciava la nostra prefettura il 7 dicembre 1865 per quella di Perugia, facendo serbare di sé grata memoria, e cedette il suo posto all’ avvocato siciliano Giacinto Scelsi, già prefetto della piccola provincia di Sondrio nel lombardo-veneto, il quale prese possésso dell’ ufficio nel 1,° gen¬naio ’66.
E la provincia di Capitanata deve al prefetto Scelsi se i suoi contribuenti appunto nell’anno 1866 non sieno stati fatti segno ad una rovina finanziaria relativamente al prestito nazionale imposto dal governo ai contribuenti dello Stato, non essendo essi, pel cattivo ricolto di queir anno, assolutamente in condizioni di spremere ulteriore succo dalle loro borse, pur troppo esauste ed essiccate. Un tale prestito fu decretato da Firenze il 1.° maggio di quell’ anno. Con esso la Banca Nazionale dava in mutuo al Tesoro dello Stato la somma di dugento cinquanta milioni di lire, aprendosi a tal fine un conto corrente con quest’ ultimo, che avrebbe corrisposto alla Banca l’interesse in ragione dell’ uno e mezzo per cento, pagabile a semestre maturato. Per lo che la detta Banca Nazionale fu dal giorno due di maggio esonerata dall’ obbligo del pagamento in danaro contante ed a vista dei suoi biglietti, i quali sarebbero stati dati e ricevuti come danaro contante per il loro valore nominale nei pagamenti eseguibili nello Stato, tanto tra l’erario pubblico ed i privati, quanto con le Società e Corpi morali d’ogni natura, non ostante qualunque contraria disposizione di legge o patto convenzionale.
Lo Scelsi, dunque, nel ventidue settembre di quell’anno si recò personalmente a Firenze col deputato provinciale signor Giuseppe Della Rocca in cerca di una tavola di salvataggio, trattando ivi con una Società bancaria, la quale avesse voluto contrarre un prestito con la nostra amministrazione provinciale, per poter questa, alla sua volta, essere in grado di adempiere agli obblighi dei contribuenti, o tentando, in difetto di ciò, di ottenere dal governo una proroga alle diverse scadenze di ciascuna rata, scadenze stabilite con r. decreto del ventotto luglio ultimo. Il prefetto rimase otto giorni nella capitale, spendendosi a tutt’uomo e in ogni guisa nell’interesse esclusivo dei suoi amministrati, e riuscì ad ottenere dal governo che i contribuenti della nostra provincia, i quali non volessero o non potessero erogare prontamente le somme di cui erano gravati, venivano facilitati a pagare un interesse del diciotto per cento, in una sola volta, e che poteva anche andar ritardato mercè altro interesse a scalare. Egli fece intanto ritorno a Foggia col Della Rocca il trenta di settembre, ricevuto alla stazione ferroviaria, con evidente prova di unanime gratitudine, dalla Giunta municipale e dagli uffiziali della guardia nazionale, mentre l’ indomani la deputazione provinciale lo acclamava festosamente nel suo seno, quando ivi tale concessione, con solenne deliberato di ratifica, potè dirsi un fatto totalmente compiuto.
Dopo diciotto mesi il governo del re credette di dare alla provincia di Capitanata altro prefetto in persona del comm. Antonio Malusardi, che giunse da Napoli nella nostra città alle sette e mezzo pomeridiane del 16 luglio ’67, e che vi restò, come rara eccezione, per tre anni interi, fino al dì 8 di luglio ’70.
Del Malusardi è d’uopo dire che fu davvero un solerte ed intelligente funzionario, e che spese, per quanto più potette, la sua opera, specialmente in prò dell’agricoltura. Fu egli che facilitò in modo mirabile, nell’ anno 1868, la costituzione in Foggia di un Comizio agrario, e che die sprone alle susseguenti conferenze per la diffusione dell’ istruzione agricola in tutta la Capitanata. Fu egli del pari che rese importante oltre ogni dire nel palazzo della prefettura una Mostra di prodotti industriali, manifatturieri ed artistici, a premura della Camera di commercio e della Società economica, e che sorpassò di gran lunga le altre già tenutesi negli anni ’64 e ’65 sulle basi del programma del 20 agosto 1863, quando.si distinse non poco il nostro Francesco Della Martora, espertissimo in materie agricole ed artistiche, — Mostra, che venne con ogni pompa solennemente inaugurata il 23 novembre ’69. E questa, di cui il Malusardi fu lo spirito informatore, vai qui la pena di ricordare nei suoi più intimi particolari.
Le sale, che il prefetto mise a disposizione degli espositori, furono tre. Nella prima di esse presero posto i campioni dei più scelti vini della nostra provincia, nonché di altri italiani, taluni dei quali finissimi, come quello del maraschino di Zara e di Marsiglia, confezionati dal dottor Francesco Saverio Sorda di Alberona ; — vini assai lodati in apposito discorso fatto nella sede della Camera di commercio, il dieci dicembre consecutivo, dal comm. De Blasiis, consigliere di Stato e deputato al Parlamento, uomo competentissimo in enologia, che fu prescelto a presidente della giuria per tale esposizione. In questa stessa sala si vedevano, in olire, ben disposti in giro, su appositi scaffali, i più pregiati marmi garganici, e varii prodotti indigeni, come paste lavorate a mano e a macchina, cereali d’ogni specie, ghiande, droghe ed altro consimile. Nella seconda vi si ammiravano splendidi quadri artistici di autori diversi, come del pari, in linea secondaria, moltissime pregiate fotografie. Nella terza, finalmente, aveano preso posto esclusivamente lavori donneschi, eseguiti, a preferenza, dalle allieve dei nostri Gonservatorii e dell’ Istituto di civili fanciulle, nonché parecchi saggi calligrafici di bambini, ricami su canovacci, in bianco, in oro, e piccole opere di arte in fiori. A completamento di queste tre sale il prefètto Malusardi avea ceduto giù un fondaco per una fiera e vendita di vini in cassa e a minuto, e lo stesso atrio del palazzo per un’ esposizione di macchine agrarie di ottima precisione. Ed egli stesso, per conseguenza, nel di 8 di maggio 70 porse, con grande compiacenza e con parole d’incoraggiamento, agli espositori, che la giuria avea stimati meritevoli di premio, le medaglie di argento e di bronzo, fattesi all’ uopo coniare dalla Società economica e dalla Camera di commercio.
Ebbe però il Malusardi a mostrar poco tatto di fronte alla cittadinanza foggiana in due momenti della sua amministrazione, il che non gli aggiunse certamente né stima maggiore, né simpatia. Una prima volta, infatti, siccome già vedemmo, ei si scalmanò non poco per privar Foggia del suo orfanotrofio, tentando di trasporta’lo nel bosco di Deliceto, fino a permettersi, secondo ivi dicemmo, d’intervenire il 17 maggio 70 nell’ aula del Consiglio provinciale per prendere la parola in merito a sostegno della sua tesi, contro ogni buona abitu¬dine e con evidente sconvenienza verso il capoluogo. Una seconda volta non seppe o non volle riconoscere le benemerenze verso la città del sindaco Lorenzo Scillitani, non riproponendolo all’alto ufficio nel 1869, alla scadenza del triennio, e facendo invece altra proposta al Ministero con una terna, composta del marchese Saverio Salerni di Rose, di Raffaele Nannarone e di Felice La Stella. E quando il Ministero, non tenendo alcun conto della sua proposta, riconfermava invece Lorenzo Scillitani a sindaco di Foggia per un ulteriore triennio, e questi per sua dignità credè dimettersi, ma, stretto poscia da un A voto affettuoso, redatto e firmato da migliaia di cittadini e di ammiratori, accettava di rimanere, ei si vide un po’ demolito in prestigio, e volle presto rialzarsi e fare pubblica ammenda della sua colpa. Ed allora ideò di offrire al palazzo della prefettura, il dì nove di gennaio, un pranzo al sindaco Scillitani con l’intervento degli assessori e di parecchie autorità del luogo, non escluso il cav. Pietro Piccone, primo intendente di finanze, venuto allora allora a Foggia, in seguito al recente decreto organico del 2S6 settembre ’69. E tra i brindisi e le coppe spumeggianti riuscì a fugare dagli ànimi di tutti ogni più lieve rancore; sicché quando ne andò via il dì 8 luglio 1870, tramutato a Forlì, cedendo il seggio di Capitanata al cav. Raffaele Solinas, già prefetto di Siracusa, la cittadinanza intera gli dette il suo beneaugurante addio.
XXI
Ricordammo pocanzi il nome di Lorenzo Scillitani, come di colui che a torto era stato combattuto dal prefetto Malusardi a riassidersi sulla sedia sindacale nell’ anno 1869, obliandosi così d’un colpo le molteplici benemerenze di costui verso la sua città natale, la quale, se lo amò sinceramente in vita con profondò sentimento di gratitudine, volle, estinto, perpetuarne la memoria in una lapide marmorea, apposta sulla casa ov’ei nacque, visse e si spense. Or queste sue benemerenze, non comuni a tutti coloro ehe riescono ad afferrare la cima della piramide nell’ amministrazione civica, non possono, né debbono andare ignorate da quanti amano di serbare intatte le buone tradizioni di fatti compiutisi ih tèmpi che percorsero i nostri e che ne furono anzi come nocciuolo fecondo. Per lo che non puossi qui fare a meno di rimenare alla memoria, almen di volo, il pubblico cammino da lui percorso.
Fin da quando a Foggia il 20 agosto 1861 il primo sindaco dei nuovi tempi, marchese di Rose, volle dimettersi, pubblicando una rassegna di tutto ciò che erasi operato dall’ amministrazione da lui presieduta, e intitolando quel suo scritto II Municipio del 1° agosto ai foggiani, il pensiero di molti si volse a Lorenzo Scillitani, come a colui che avrebbe potuto col suo senno pratico guidare da abile nocchiero la nave civica, abbastanza sdrucita, attraverso i marosi fmanziarii, che la minacciavano d’ogni parte
La vita di lui potea dirsi fosse — e mi servo del manzo¬niano termine di paragone — come un ruscello che, scaturito limpido dalla roccia, senza ristagnare né intorbidirsi mai, va lìmpido a gittarsi nel fiume. Onesto nel senso più largo della parola, bene avrebbe potuto imitare quel Livio Druso, tribuno della plebe, sì rinomato in Plutarco, il quale sebbene avesse molto della sua casa esposto, agli occhi dei vicini, promise il doppio della somma richiesta a chi proponeva di trasformar¬gliela in modo che tutte le parti di essa, niuna esclusa, fossero viste dal di fuori, affinchè i cittadini sapessero il modo del suo vivere.
Il voto, infatti, divenne una realtà, che un decreto in data del tre settembre di queir anno lo nominava primo magistrato della città, carica ch’egli assunse il mattino del cinque set¬tembre, dopo aver prestato il giuramento di rito innanzi al prefetto Bardesono.
In verità, questo primo periodo di amministrazione fu abbastanza noioso per lui a causa di un nugolo d’invidi avversarti, che, quasi appiattati nell’ ombra, cercavano fiaccarne lo spirito invitto. Un biglietto anonimo, infatti, verso la sera del dieci settembre ebbe a pervenirgli con la sua massima sorpresa, anonimo vigliaccamente minaccioso, che lo incitava a dimettersi dall’onorevole ufficio se avesse voluto aver salva la vita,’ cosa che se lo turbò, non gli mise certo i brividi nelle vene, sicché egli limitossi soltanto a parteciparne accademicamente al governatore il contenuto.
Intanto il 7 novembre ’61 re Vittorio Emmanuele mostrò desiderio che tutt’ i sindaci del regno sì riunissero ad Ancona per la prima volta intorno a lui nell’occasione dell’inaugurazione del tronco ferroviario Ancona-Bologna ; e Lorenzo Scillitani non volle, naturalmente, che il rappresentante di Foggia mancasse al sovrano appello, e, in quel dì, tra’ primi, corse nell’ antica città pontificia, testé strappata alla fiacca soldatesca di un Lamorcière, a salutare il primo re d’Italia. Vittorio Emmanuele fu largo di simpatie con lui ; che anzi, in seguito a formale invito fattoglisi, promise che, venendo in Napoli, avrebbe certamente visitata la nostra città, promessa che infatti mantenne. E, mentre il sindaco con telegramma annunziava ai suoi concittadini la lusinghiera accoglienza avuta e la regale promessa fattagli, il quattordici novembre varii consiglieri municipali gli notificarono un atto protestativo per mezzo di usciere, adducendo eh’ ei fosse in commissum per essersi allontanato da Foggia senza il relativo consenso del municipio. Allo giungere di tal ridevole atto, spoglio di ogni base giuridica, l’assessore funzionante da sindaco (1) riunì d’urgenza il Consiglio e, prospettando ai colleghi la inesistenza del protesto per non esservi bisogno di alcun consenso in un fatto provocato quasi da un ordine del sovrano, ottenne che quel consesso stigmatizasse con fiero deliberato l’inconsulta manovra partigiana.
Lorenzo Scillitani andò quindi innanzi per la sua via, tutta cosparsa di pruni e di rovi, senza però avere nessuna fede in una larga, costante e proficua collaborazione da parte dei suoi colleghi; sicché, dopo avere iniziato fin dal 15 dicembre ’61 il nuovo censimento richiesto dal governo, cominciò man mano ad annunziare delle ragioni potenti di famiglia e di salute, che non gli permettevano di occuparsi d’avvantaggio della cosa pubblica, e nel 3 maggio ’62 rassegnava le sue dimissioni.
Ritornato alla dignità sindacale il dì 11 giugno il marchese di Rose, venne l’amministrazione comunale, con decreto del 18 settembre ’62, disciolta, nominandosi r. commissario straordinario, secondo dicemmo altrove, il signor Tito de Amicis, consigliere della prefettura di Cosenza, il quale prese possesso dell’ ufficio il ventisette settembre consecutivo. E dopo altro periodo lunghissimo, durante il quale il municipio rimase com¬pletamente acefalo, e dopo essersi avuto altresì un sindacato
(1) L’assessore ff. da, sindaco di queir epoca era il signor Vincenzo Campanella.
La Stella, e, più giù, un sindacato Scoccherà, il 15 ottobre’66 riappare la signorile figura di Lorenzo Scillitani sulla sedia curale di primo magistrato civico. Ma questa, volta, circondato da strepitosa maggioranza e nella cittadinanza e nel Consiglio, potette egli compiere intera l’opera sua benefica in prò della città in cui nacque, e che, la mercè sua, venne radicalamente trasformata.
Foggia potea dirsi a quell’epoca, senza far dell’ iperbole, un polipo di straducole malsane, dove il sudiciume materiale gareggiava fors’ anche col sudiciume morale, che ivi trovava il suo ambiente; un ammasso di bruttezze risiedeva nel cuore della città : era come un pugno di fango gettato su di una bianca mensa, la quale aspetti i convitati. Eran brutture, insomma, come ve ne sono tuttavia in ogni paese e in ogni casa, ma non già esposte nei centri più ricercati, non messe in mostra nel salotto. Il mutare il fango in diamante era sogno; ep¬pure il sogno avverossi, e la bonifica di quei centri fu presto un fatto compiuto. Un nuovo aspetto — è d’uopo dirlo ad onor del vero— cominciarono a prendere financo i chiassuoli per igiene e nettezza, essendosi organizzato un regolare sistema di spazzamento, da non invidiare quello delle grandi eittà, ed anche d’inaffiamento con sistema a botte, per quanto lo permettessero le condizioni speciali del luogo, condannato a sem¬pre considerare ogni filo d’acqua come il nettare riserbato agli Dei. E novello aspetto esse ottennero altresì per una pavimentazione più completa e razionale, qui mediante lastre vulcaniche, là con pietra bianca e acciottolato. Fu allora che si vide, fra l’altro, prolungato sino alla villa il lastricamento della sua maggiore strada, detta allora stradone s. Antonio abate, ed oggi corso Vittorio Emmanuele, che fino a quell’epoca raggiungeva appena la chiesa della madonna della croce, e sottratto al sudicio sterrato parecchi chiassuoli, angiporti e viuzze secondarie, tra cui quelle adiacenti al nostro bel teatro, con l’ormai famoso Arco di Nenna Contini, ed altre ancora dei diversi borghi acciottolate, mentre pur piazza municipio rivestivasi a muovo, permutandosi le antiche sgangherate lastre bianche con altrettante vulcaniche. E fu allora del pari che il largo Gesù e Maria ove il sole, senza pietà, saettava nell’estate quanti eran costretti a passarvi, specialmente nelle ore canicolari, da rimanervi arrostiti come oche allo schidione, videsì, con saggio consiglio, fornito di alberatura su doppii filari e proiettante intorno, col suo verde fogliame, ombre fresche e carezzevoli. Ed ecco presso la chiesa di s. Tommaso apostolo che va demolito il 31 agosto ’67 l’indecoroso arco di Portanova, la cui esistenza risaliva fino ai tempi anteriori al secolo XVI, trovandosi esso già costruito il 1642 quando il prossimo palazzo, su cui dall’un canto adagiavasi, fu venduto dal marchese Branda ai signori Nannarone. Ecco che il 22 giugno 1869 va spazzato del pari, a cura del Comune, un mucchio d’indecenti casupole, quasi baracche di zingari o di altra gente primitiva, dal così detto stradone Della Rocca, ora via Cairoli, censendosene il suolo a diversi intraprenditori, per far sorgere colà un fabbricato degno di cospicua città qual’è quello che vedesi oggidì di fronte all’architettonico palazzo dello stesso Scillitani, ormai venduto al Frattarolo di Manfredonia. Ecco finalmente alimentare il sentimento patriottico, consacrando alla memoria di Vincenzo Lanza, il nosologo e clinico italiano rispettabile e rispettato, l’esule insigne dannato nel capo, peregrina e fulgida gloria di nostra terra, uno splendido monumento in marmo in mezzo ad una delle piazze cittadine, che perennemente lo additi al culto delle future generazioni.- Della qual cosa i figli di lui, riconoscenti, offrirono in dono alla città, con lettera del 21 Mag¬gio 70, un autografo del grande estinto, che veniva gelosamente depositato come prezioso cimelio nella nostra biblioteca comunale.
E per questo sindaco impareggiabile, che voleva a tutto costo la sua città esteticamente bella, il municipio offrì gratuiti, il 15 settembre ’69, parecchi suoli edificatorii ad uso di nuove case, oltre ad altre precedenti concessioni con vistosi premii allo scopo sempre utilissimo di moltiplicare le abitazioni e di far diminuire le relative pigioni; e concesse altresì ad una Società assuntrice larghe aree, pur esse gratuite, per due mercati, con la laudabile finalità d’impedire ai venditori, mercè una concorrenza assai prossima, qualsiasi monopolio.
E devesi allo stesso Scillitani, che poneva pensiero anche alle minime cose in aggiungere attrattative maggiori al soggiorno nella nostra città, se il municipio cedeva del pari graziosamente l’elegante salone, coi locali adiacenti, sito sul porticato del teatro, ad uno scelto e forte nucleo di gentiluomini foggiani per installarvi un pubblico ritrovo, che, addimandossi Circolo Datino, dal nome dello stesso teatro che si era nei nuovi tempi ribattezzato. Esso inaugurassi la sera del 10 novembre ’67 con grande intervento di signori e di signore, nella quale occasione si scoprirono per la prima volta le quattro statue colossali, ivi esistenti, e che raffigurano Francesco I, Elisabetta, Ferdinando, II e Maria Teresa.
E non lasciò, ad un tempo, quest’uomo di rivolgere e pensiero e cuore alla sventura, che, a parte tutto quello che egli operava in vantaggio degli attaccati dal colera del ’67, volle che, in un pianterreno sottostante all’ospedale di s. Giovanni.di Dio, sorgesse a spese del Comune, il 14 marzo ’68, una sala con venti letti destinati ai poverelli foggiani, i quali quotidianamente avrebbero ivi ottenuto tutto ciò che loro abbisognasse e per cibaria e per vestimento.
E quando l’11 novembre ’69 la principessa Margherita di Savoia dava alla luce in Napoli l’attuale nostro re Vittorio Emmanuele III, Lorenzo Scillitani non seppe festeggiare in Foggia più degnamente il lieto evento, se non correndo col pensiero agli umili e agl’infelici, e fece quindi adottare, l’indomani, dal municipio una deliberazióne di urgenza, con la quale, oltre alle solite pubbliche luminarie, ai concerti delle bande musicali e ad una serata di gaia al teatro, si dispo¬eva di fondarsi in Foggia un ricovero per le fanciulle abbandonate, battezzandolo dal nome dell’augusta signora, e per esso stanziandosi in bilancio apposita somma in lire ventimila; di dividersi elemosine tra i poveri della città; e, a spese e cure dell’ amministrazione, spegnorarsi dal Monte di Pietà, a favore dei piccoli proprietarii, tutt’ i pegni in metallo prezioso, in rame, in pannini e simili del valore al di sotto di lire cinque e centesimi dieci ; di dotarsi, finalmente, tutt’i fanciulli d’ambo i sessi, nati nel fausto giorno, con libretti di Cassa di risparmio per la somma di lire dugento, ciascuno sotto il titolo: Dono Principe di Napoli.
E il 24 marzo ’70, quando fu stabilito in Foggia per la prima volta una sede succursale del Banco di Napoli, nella casa dei signori Serra allo stradone s. Antonio abate, con a capo il direttore signor Biagio Giacchi, il sindaco Scillitani venne ivi assunto in qualità di censore con la corrisponsione di un tenue gettone di lire mille annue. Ebbene egli rifiutò di ritenerlo per sé, e, con sentimento altruistico encomi abilissimo e che non trova facili riscontri, lo destinava generosamente ad un istituto di carità.
E mentre in” un primo momento si affaticò, come innanzi notammo, a garentire i reclusi trovatelli contro le strane pre¬tese del prefetto e del consesso provinciale, che, con esiliarli nel bosco di Deliceto, volevano completamente mutarne le sorti, peggiorandole, ottenne finalmente che l’orfanotrofio si riaprisse il dì 8 settembre 1866, e si liquidasse ogni questione pendente con gli appaltatori, cosa che e rasi sperata invano per anni lun¬ghissimi. Sicché esso, col riaprirsi, potè accogliere un numero vistoso di diseredati, abbandonandosi così, con unanime compiacimento, l’angusta e precaria dimora nella casa Fuiani alla strada s. Agostino.,
E si compenetrò, del pari, della condizione dei non abbienti e dei piccoli proprietarii, che venivano insidiati da due Banche usurarie, surte in Foggia nel 1870 ad imitazione delle mol¬teplici napoletane Ruffo Scilla e compagni di orrorosa memoria, mercè un proclama lanciato al paese il dodici febbraio di quell’anno, che rivelava pure una volta la nobiltà e la rettitudine dell’animo suo, nonché l’affetto vigile per gli amministrati. Con forma elevata ei dimostrava come questa nuova forma di ladroneria, mediante la lusinga di premii favolosi, veniva ad usurpare il risparmio di colui che ne rimaneva pel momento adescato, e che un giorno non lontano avrebbe assaporate in¬vece le tristi conseguenze dell’inganno tesogli. Per lo che, sia per una ragione morale, che per un interesse materiale, si sentiva egli nell’obbligo di levar la voce e di mettere in guardia gli onesti dalla nuova setta di spoliatori, suggerendo di aspettarsi fiduciosi, per contrario, dal lavoro e dall’industria ogni sostanziale miglioramento di fortuna. «Concittadini, — così chiude-vasi il savio proclama — ho creduto mio sacro dovere di avvertirvene; voi, da parte vostra, mostrate di essere un popolo laborioso e civile, e provate coi fatti che in mezzo a noi non trovano a prosperare che le idee oneste».
E, come dalle insidie, cercò egli in oltre di difendere dalle angarie e dalle vessazioni fiscali i suoi concittadini, e fu perciò inspiratore dell’atto nobile e disdegnoso del Consiglio comunale nella seduta del 6 novembre ’69, quando, invitato ad indicare un novello esattore di fondiaria pel biennio 1870-71, rifiuta vasi di procedere a tale nomina, per protestare formalmente contro le straripanti esigenze del governo, che, ad ottenere il pagamento del tributo, non ritraevasi, per sistema, dall’opprimere hinc et nunc i contribuenti con ogni mezzo coercitivo, negando ad essi anche un’ ora sola di tregua e di respiro. Con tale decisione si lasciava ogni qualsiasi respon-sabilità unicamente al governo medesimo, che, d’allora innanzi, avrebbe potuto provvedere da sé agl’interessi fiscali senza complicità di chicchessia.
E fu per Lorenzo Scillitani, antesignano di ogni bella iniziativa, che il 16 maggio ’68 si organizzava un’esposizione ip¬pica importantissima in locali magnifici, elegantemente eostruiti in legno presso il parco comunale, richiamandosi così in Foggia, con grande utilità pubblica, una folla di forestieri, allietati il ventuno di maggio altresì dal simpatico svago di due corse di cavalli di grande attrattiva, cui e ministro e municipio offrirono vistosi premii d’incoraggiamento. E a tale espo¬sizione tenne dietro un’ altra ancora, il 27 maggio ’69, nell’identico sito, auspice lo stesso Scillitani e con l’intervento di una giuria, presieduta dal barone Farina, con eguale affollamento di forestieri e con pari brio.
Fu per lui, inoltre, eh’ebbero grande impulso le scuole d’ogni grado da far considerare dal governo il municipio di Foggia qual benemerito della pubblica istruzione, e fregiarlo di medaglia d’argento, che gli veniva consegnata nel 6 giugno 1869 a mezzo del prefetto Antonio Malusardi. E gran parte di codeste scuole ebbero altresì il loro definitivo assetto nell’ex-monastero degli scolopii, fabbricato di cui lo stesso sindaco zelantissimo seppe rivendicare la proprietà al Comune, come rivendicava ad un tempo quella dell’ ospedale Fate-bene-fratelli, con altre rendite annesse, recandosi di persona più e più volte nell’anno ’69 a Firenze.
E, con le scuole, dette lo Scillitani degna sede, secondo dissi altrove, alla nostra biblioteca, e fondò alla dipendenza di essa una biblioteca popolare, dotandola in un primo momento de proprio con lire trecento” per acquisto di libri, il cui esempio fu presto imitato da un nugolo di privati cittadini, invitati all’uopo da lui stesso il 15 febbraio ’70, e coronato dal concorso municipale, votatosi, il ventisei marzo di quel-l’anno, per lo che si raggiunse in poco tempo il numero vistoso di circa novecento volumi, di cui sin dal 31 luglio ’71 si avvalsero gli studiosi (1).
Mille e mille altre da riempirne un mondo furono le benemerenze di questo sindaco eccellentissimo ; e il cenno fugace che noi abbiamo fatto di talune di esse va completato col ricordo di due altri atti di sua amministrazione, che gli guadagnarono, a preferenza, schietta popolarità nelle masse. L’uno fu lo stipulato definitivo con la Casa Riedinger di Augusta del contratto per l’illuminazione a gas, che procurò ai foggiani il vanto di dirsi appartenenti ad una città, ricca ormai di ogni vantaggio della civiltà moderna, separandoli così d’un colpo da quanti, retrogradi o miseri, erravano tuttora tra la penombra delle loro vie. L’altro parrebbe, a prima vista e solo ai gonzi, quasi un nonnulla, ma costituiva invece uno dei pubblici interessi, cui tenevasi al sommo grado specialmente dal popolino, pel quale il suono della grande campana dell’Ico-navetere, la marangone, dei nostro campanile, dai suoi rintocchi squillanti, armoniosi, costituiva, come costituisce tuttavia, il suo più soave e geloso tesoro, siccome suole, per altro, avvenire comunemente per tutte le campane in ogni altro paese o villaggio che sia, tal che inspiravasi al vero, nella sua sem¬plicità, il melodioso poeta quando veniva cantando:
Suona o campana, suona o campana, Suona vicina, suona lontana. Tu sei la musica del poveretto, Che nel sentirti piange di affetto ; Ei sol comprende la tua parola, Quando sonora per V aria vola.
Ma se le campane rappresentano la musica speciale del povero, ben si elevano, altresì, a importanzamaggiore nell’esistenza, dell’uomo, a qualsiasi classe sociale egli appartenga, non soltanto perchè esse si mescono sempre mai e si confondono con le nostre gioie più pure, coi nostri più intensi dolori, ma perchè esse simboleggiano, sul campanile del proprio paese, la fede della sua casa e dei suoi maggiori, sicché ad ogni loro rintocco ben si commuove lo spirito e ben freme altresì una parte della sua storia, la storia dei primi anni infantili, delle evanescenti speranze, della poesia, che deponeva in fondo al cuore il polline fecondo del futuro germoglio. E ciò non è tutto, che utili e gravi missioni esse assunsero talvolta, la cui rinomanza non saprebbe né potrebbe chicchessia cancellare dalla memoria giammai. Non v’ha, infatti, chi non ricordi che il popolo di Venezia si radunava al suono dei suoi bronzi sulla pubblica piazza, nel secolo undecimo, per assistere alle urgenti e gravi comunicazioni del Senato. Non v7ha chi non ricordi che, a suon di campana, e Cinzia nella notte del 1005 salvò Pisa dall’ assalto dei corsari, condotti da Mu-set, — e i frati di Montecassino nel 1045 scongiurarono il tra¬dimento di Rainolbo, — e la Sicilia nel 1228 annientò il giogo degli Angioini, — e Caterina de’ Medici nel 1572 dette il segnale della strage orrorosa degli Ugonotti. E si giunse perfino ad averne talvolta devota adorazione da indurre popoli moltissimi a fonderne di dimensioni colossali, come in Erfurt esistette, dal 1497 al 1614, una campana alta otto cubiti, spessa sei dita e mezzo, pesante 9240 kilog. : e a Mosca, il paese dalle duemila campane, veniva collocato il 1737 sul campanile della cattedrale l’immenso tsarkolokol (l’ imperatore dei campanoni), per cui si ebbe un culto veramente ascetico, e che pesava 144,400 kilog., ed avea 49 centimetri di spessezza, 3 metri di diametro e 12m, 50 di circonferenza; nonché altra campana, collocata il 1819, di una grandezza tale che il solo batocchio pesava 2000 kilog. e che destò in ognuno tale sentimento di compiacenza e di gratitudine pel costruttore Bogdanof, che si giunse financo, da pazzi, a lacerargli i vestiti di dosso per conservarne presso di sé un qualche frammento in memoria. E in Cina, che ha perfino campane di oro massiccio, e al Giappone, in Francia, a Venezia, a Firenze, a Roma, che ne posseggono ormai le più sonore e gigantesche, no, che non sarebbe stato mai ridevole il sostenere che rientrino nei gravi ed urgenti interessi cittadini quelle campane che, nate modestamente a Nola fin dal .quinto secolo, infusero poi nei più grandi uomini del mondo, dal primo Bonaparte a Victor Hugo,a Schiller, a Chateaubriand, a Lamartine, a Pindemonte e a mille altri le sensazioni più dolci e deliziose.
Or dunque, ritornando a Foggia, diciamo che la campana della Iconavetere, chiamata più comunemente « campana della madonna », la più grossa del nostro bel campanile, erasi fin dalla sera del 21 aprile 1866 spezzata, quella campana ch’ era la prima ad annunziare ognidì ai dormienti il mattino, quella che, all’ avemmaria, era come melanconica squilla,che paia il giorno pianger che si muore,quella che, qual voce di preghiera, innalzava il suo suono alle regioni superne per lenire, ovunque, spasimi, sofferenze e sventure. Ed essa rimase in abbandono per diversi anni, perchè le finanze comunali, — ridotte ormai, sin da parecchio, così al verde, che gli amministratori, nel 1862, per annaffiare un pò l’assetato erario, vagheggiavano fin l’idea di schiantare le robuste quercie dell’ Incoronata e dissodare parte di quel magnifico bosco, — le finanze comunali, dicevo, non permisero mai si stornasse una somma qualsiasi per rifarla, e perchè fors’ anche un pochino di buona volontà da parte degli ammi-nistratori vi era pure mancata.
Ma Lorenzo Scillitani, intepetre profondo dell’ animo dei cittadini, che si aspettavano, con ansia crescente ed a costo di qualsivoglia sacrificio, la resurrezione della secolare campana, che parea per loro, sopra tutto, rievocazione di tempi che furono, circonfusi quasi d’ un senso indefinito, sacro, epico, arcano, fece stanziare dal municipio in bilancio la cifra di lire quattromila dugento cinquanta, come compimento della somma richiesta per la nuova fusione di essa, oltre all’ acquisto di molto metallo all’ uopo necessario, ed esaudiva così l’universal voto..
E la gran marea del popolo foggiano, che tanto si, appassionò alla conservazione della sua campana prediletta, corse a baciarla il 14 ottobre 1869v quando la si ridiscese, dal campanile, ove era stata elevata il 12 agosto 180Q, dopo che venne fusa a Venezia il 1799 mercè elemosine raccolte tra’ fedeli; e ne invigilò la nuova fusione che ne fecero i fratelli Barigozzi di Milano nell’ atrio del giardino dei conventuali alcanterini, gittando persino devotamente nella fornace, ove trovavasi in combustione, manate di oro, di argento, di rame e di bronzo.
E nel dì del reaurrevit volle fosse impresso sull’estremo di essa, oltre alla effigie della Icone e alla vecchia epigrafe, il nome di Lorenzo Scillitani, decretando così l’apoteosi a chi seppe ridare finalmente alla città l’estasi delle antiche armoniche vibrazioni (1).
Ecco dunque le principali benemerenze di Lorenzo Scillitani, che spese tuttodì con vero intelletto d’amore ogni sua energia in prò dì Foggia, e il cui nome resterà come monito ed esempio per coloro che son chiamati dal favore cittadino ad amministrarne le sorti.
Non sono le grandi e magnifiche opere soltanto che sappiano guadagnare il lauro a saggi amministratori civici, ma spessissimo sono, a preferenza, le più microscopiche e le meno ponderabili, purché esse riescano a riparare necessità vere ed urgenti, reclamate dagli amministrati, pel cui vantaggio escluivo è dovere, come padri di famiglia pei loro figli, di spendere, per ogni verso la propria attività, la quale, altrimenti, andrebbe affatto sprecata e perduta.
Oh come talvolta rappresenta un nonnulla e costa quindi assai poco il’nocciuolo della popolarità, e come basta pur troppo il modesto sapere di un uomo pratico e virtuoso, anzi che il fuoco sacro di un ingegno superiore, a beneficare la patria e a consolarla !
XXII.
La vita cittadina fu in Poggia sempre sempre movimentata, e raggiunse talvolta, senza iperboleggiamenti, anche il brio della metropoli, non solo negli antichi tempi quando Federico lo svevo la elevava addirittura a sua sede imperiale, arricchendola di palagi architettonici, di ville amene, di siti deliziosi, e adunandovi entro le sue mura i più potenti vas¬salli e i giustizieri del regno, o quando Carlo d’ Angiò la prescelse a sua abituale dimora, trasportandovi aristocratica Corte, e solennizzandovi le nozze di sua figlia Beatrice con Filippo V, ma fin nei tempi aragonesi di Alfonso I, di Ferrante, di Ludovico II, d’Isabella e di Ferdinando il cattolico, che la onorarono sovente di loro presenza nelle più grandi regali occasioni, sia pubbliche che private. Né decadde questo suo eccezional brio all’ epoca dei primi Borboni, che ognuno certamente ricorderà, fra l’ altro, le fauste nozze ivi celebratesi, nel giugno dell’ anno 1797, da Francesco I, nipote di Carlo III e figlio di Ferdinando IV, con Maria Clementina, arcidu¬chessa d’Austria, quando lo stesso re Ferdinando e la regina Carolina, col loro seguito imponente di duchi e di cavalieri napoletani, vennero, fin dall’aprile innanzi, a prendervi dimora, e, con essi, ben quattro reggimenti di cavalleria, due di, fanteria e la guardia reale, rigurgitanti dai diversi quartieri e dalle tende multicolori, poeticamente disposte intorno alla città. Né affievolì vasi ai tempi dei napoleonidi, quando Foggia, a mezzo del generale Championet, venne dichiarata concapitale, cioè capitale delle due Provincie,di Capitanata e del contado di Molise, e quando sì Giuseppe Bonaparte nel 1806, che Gioacchino Murat nel 1808 vennero pur essi a soggiornarvi con loro grande compiacimento. Gli ultimi principi di Casa Borbone, come vedemmo, tennero pur vivo questo brio cittadino in parecchie occasioni, tra le quali primeggiò quella per lo sbarco a Manfredonia di Maria Sofia di Baviera, la sposa di Francesco II, ohe, per la malattia del re, siccome vedemmo, non ebbe poi ad avverarsi. Lo stesso Ferdinando II vi venne spesso da semplice privato, all’epoca della famosa fiera di maggio, la prima del regno, che richiamava ogni anno gran mole di uomini e di bestie da tutte le provincie, per suoi interessi personali, avendo egli, come ognun sa, feudi importantissimi in Capitanata, e per farvi acquisti specialmente di cavalli, che erano la sua predilezione,; e lo si vedeva girare su pel Piano della croce, in veste da borghese, col tradizionale uncino tra mano, al pari di ogni buon massaro del luogo, e con un codazzo di buttari che gì’ indicavano or quella razza or quell’ altra, appartenenti ai migliori proprietarii di Puglia .
E, oltre ai coronati, che in ogni epoca ebbero a dimorarvi con soddisfazione e a tenerla in gran conto, Foggia Una folla accolse sempre, addirittura una folla d’illustri personaggi, di scienziati, di letterati e di artisti, ritraendone non solo prestigio grandissimo, ma, ad un tempo, dólce e invidiabile rigoglio nella vita del pensiero. Non ne sarebbe facile lo elenco se ne fosse qui il posto, e se io ne avessi il tempo e la voglia di farlo. Solo ricorderò che Giovanni Paisiello, — il primo riformatore dell’arte musicale, colui che superò e vinse Guglielmi e Gimarosa, suoi coevi, rimanendo modello peregrino dei maestri avvenire, e che fu valutato in tutta Europa quale faro luminoso del suo secolo, — Giovanni Paisiello, dicevo, venne a far risuonaré delle sue note divine, su di un’imponente orchestra, il nostro maggior tempio nel 25 giugno 1797 per le nozze di Francesco di Borbone, e che diresse la sera stessa da par suo una Cantata, anche di proprio sacco, al r. palazzo, dove Ferdinando IV volle dare un ricevimento sfarzoso ed un gran ballo. Ricorderò che Francesco Saverio Mercadante, altra gloria pugliese, come il primo, l’emulo di Gaetano Donizetti, di Vincenzo Bellini e di Giuseppe Verdi, che seppe elevarsi, insignito della favilla del genio, sino alle più alte vette dell’arte, non disdegnò, più giù, anch’egli l’ammirazione ed il plauso dei foggiani nel r. teatro Ferdinando. Così facendo, entrambi quasi presagirono il sorriso che Euterpe riserbavà a questa terra, divenuta ormai anch’essa, nei tempi nuovi, madre di’genii fecondi (1). E ricorderò deipari che quel cigno carezzevole e fascinatore, vagabondo come Omero e biondo come Apollo, al dir di Autran, quell’anima gentile ed entusiasta che destò fanatismo oltr’Alpe, e che ebbe ad ammiratori un La-martine, un Lammenais, un Quinet, un Victor Hugo, quell’illustre e libero figlio di Novara, Giuseppe Regaldi, predilesse Foggia in tutto il mezzogiorno della penisola, Foggia, ove più é più volte si compiacque riprodurre con le sue felici improvvisazioni il miracolo della cetra di Orfeo. E Giannina Milli, la gentile,la vivacela facile rimatrice; e Pietro Paolo Parzanese,il poeta irpino « dall’irresistibile magìa», al dir di Carlo De Ferrariis (1), colui « che t’inonda il petto di piacere e ti dispone a olcissima melanconia, come il preludio di un’arpa o di canto di donna innamorata » (2). E Rosa Taddéi, V angelo delizioso dell’armonia, che questi chiamò, nella dedica della traduzionedella Preghiera per tutti di Victor Hugo, « donna di mente e dicuore italiana » ; e Francesco Meterangelis, e Saverio Baldacchini, e Niccola Sole, e il marchese di Montrone, e mille e millealtri ingegni peregrini tennero desta anch’essi sempremai lavita foggiana, massime nei tempi di generale abbandono, molcendo, con le vibrazioni delle loro corde soavi, ogni anima eletta, invaghita del bello. Di quanti altri, però, passati puressi come.fulgide comete su pel nostro orizzonte di fuoco, pittando qua e là sprazzi abbaglianti di luce, la tradizione, forse o senza forse, ebbe anche a disperderne totalmente la memoria. E questa nota tematica della nostra città non si spense punto nel nuovo evo. Infatti Vittorio Emmanuele II, pel primo, non volle aspettare molto per visitare Foggia, anzi colse l’occasione favorevole dell’inaugurazione di un tronco della sua rete ferroviaria, il 9 novembre 1863, per procurarle l’orgoglio di esser prescelta, a preferenza delle altre sorelle pugliesi, in rendergli il vergine omaggio qual redentore dell’Italia e del nostro Mezzogiorno. In questa Solenne occasione la provincia di Capitanata, a parte tutta la magistratura delle tre Puglie, parve intera riunirsi, con le sue legioni di guardie nazionali, nel capoluogo, che spese con vero entusiasmo ogni sua febbrile attività ed energia in ricevere l’universalmente amato re. E si vestì a festa la gaia città, si adornò dei suoi più sfarzosi vezzi per fargli maggiore onore, per mostrarsi così degna della preferenza ottenuta. Un lungo, ininterrotto tappeto di fiori si espandeva sulla strada che dalla stazione ferroviaria porta all’abitato, strada fiancheggiata di statue, di colonne, di trofei dai colori nazionali ; e sul gran piazzale della villa comunale,
(1) Ebbe culla in Foggia, fra gli altri, Umberto Giordano, il fortunato autore di Andrea Chénier, di Fedora e di Sibèria, testé decorato dal governò della repubblica francese dell’alta Onorificenza della Legion d’onore, e che ci auguriamo voglia, a gloria della sua terra e dell’Italia intera,
Del creator suo spìrito
Più vasta orma stampar.
(i) Necrologio di P. P. Parzanese, pubblicato nel Polìorama pittoresco di Napoli, anno XIV, 1852, n. 25, pag. 193.
dirimpetto al suo artistico e bel porticato (1), ricco anch’esso di labari sventolanti al sorriso di un cielo azzurro e luminoso, sulla soglia della città, tra festoni di drappi e di veli, inghirlandato di mirto e di alloro, tra scudi e pennoni tricolori, si ergeva gigante un arco trionfale. A pochi passi di distanza, al largo Gesù e Maria, un padiglione dalle linee svelte ed eleganti, in mezzo a piante ornamentali assai rare, accoglieva una ricca sedia a bracciuoli di velluto cremisi dagli orli dorati, destinata al re per assistere alla sfilata delle milizie nazionali è delle truppe, di cui già rigurgitavano le caserme, e che ebbe poi luogo in altro sito. La stazione, all’ arrivo del treno reale da Ancona, era siffattamente gremita di rappresentanze ufficiali, come di popolo, che un granello di rena non avrebbe saputo insinuarsi a traverso quel mare di corpi umani sino a trovarvi il fondo. Era l’ansia che spingeva tutti a farsi innanzi, per scoprire ed ammirare, tra’ primi, la maestosa figura del re guerriero. Ma il treno arrivò sull’annottar e : al fischio assordante della vaporiera rispose, in un uragano di applausi, un grido solo :« Viva Vittorio Emmanuele », tra le note solenni della marcia reale, intuonata, d’ogni parte, dalle bande musicali. Vittorio, apparso tra ministri e generali, sulla predella del vagone reale, e salutato dal sindaco La Stella, dalla Giunta,
(1) Degno di nota è davvero l’ingresso della villa comunale di Foggia, che va de¬corato di un prospetto con due serie di colonne, ciascuna nel numero di quattordici. Èsse sono disposte in portico rettilineo; e l’ordine dorico, cui appartengono, è quello stesso che presenta il teatro Marcello, ideato da Cesare ed eretto in Roma da Ottaviano Augusto, nella sua decorazione esteriore, la di cui robusta, perfetta ed armonica archi¬tettura, che fin nei suoi ruderi tuttavia si scopre, attrae non poco l’attenzione dei com¬petenti. Ciò non ostante, si moderò qualche parte dell’ ordine medesimo per renderlo più bello e più caratteristico per l’uffizio, cui era destinato. Detto portico lascia vedere alle sue estremità due casinine, l’uso delle quali è unicamente indicato per sale da caffè, da buvette, da biliardo, sebbene sieno ora occupate assai diversamente. Le faccie esterne di esse sono vagamente bugnate e coronate dalla cornice, che sovrasta alle colonne. Un attico, sorretto ad epistilio, ne completa il prospetto, mentre il passaggio degrinterco-lunnii è raccomandato ad eleganti ringhiere di ferro, che sì aprono in tre diversi punti, uno in centro e gli altri ai lati. Dalla forma adottata si può immaginare il movimento che offrono le colonne, indipendentemente da quanto ne danno la vaghezza delle aiuole, il verde degli alberi e l’intravvedersi dei lunghi e diritti viali a certa distanza, ancor prima che si entri in villa. Autore di tale opera fu l’architetto Luigi Oberty di Mon-dovì, che P ideava nell’ anno 1824, sotto gli auspicii dell’ intendente dell’ epoca cav. Ni¬cola Santangelo, mentre venn« eseguito in prosieguo di tempo, quando potette ottener¬sene, la relativa approvazione dal governo per le premurose cure del sindaco marchese Tommasantonio Celentano, il quale andò più volte in Napoli all’oggetto, e donde ritornò definitivamente, per avere avuta la concessione, il 20 gennaio *1827.
dalle autorità, volle poscia a piedi, nel cuore del suo popolo, sorridente ai più vicini che gli facevano delirante festa, entrare in città e recarsi direttamente al duomo, mentre le guardie nazionali e le truppe, scaglionate ai fianchi dell’intero percorso, gli presentavano le armi. Uno spettacolo davvero indimenticabile ! A pie dello scalone del sacro tempio l’intero Capitolo in cappa magna e i deputati della cappella lo attendevano, e gli fecero ala sin dentro il presbiterio, dov’era collocato apposito seggio e donde assistette alla benedizione, impartita dal vescovo di s. Angelo dei Lombardi. Di qui Vittorio Emmanuele si recò anche a piedi al palazzo della prefettura, destinato, come sempre, a real dimora, e fra le stesse acclamazioni di tutta intera la città, riversatasi sulle vie, sui terrazzini, alle finestre, e fin su’ tetti delle case, adorne tutte di damaschi, di bandiere, di astri luminosi. Dopo essere apparso al balcone più volte per ringraziare la folla, che non si stancava di acclamarlo con grida di gioia e battimani, ricevette in quelle sale, splendidamente illuminate, le autorità tutte, mostrandosi compiaciuto del ricevimento entusiastico avuto, e trattando tutti, specialmente il sindaco e la Giunta, con una cordialità veramente unica e de-gna ptir troppo delle tradizioni di Casa Savoia. Invitato quindi di partecipare al pranzo approntatosi sontuosamente per trecento coperti dal Bastogi, come già accennammo altrove, pregò di dispensamelo, preferendo di rimanere con pochi intimi a palazzo; e invece, la sera istessa, intervenne ad una festa da ballo, che il municipio volle dare, in suo onore, nella grandiosa e splendida sala sovrastante al teatro.
Il dì appresso, dieci novembre, alle otto del mattino, il,re, col suo seguito dagli eleganti equipaggi, veniva sulla via di Lucera a passare in rivista ben seimila uomini di guardie nazionali, che, sfilando poscia in parata, si schierarono su doppia fila, fino a raggiungere, pel gran numero, un miglio di distesa dall’abitato, lungo la strada che mena a Napoli, per la quale passò l’imponente corteo delle carrozze reali, conducenti il sovrano che ne partiva. E, partendo, Vittorio Emmanuele volle lasciare un ricordo della sua real munificenza col fregiare delle insegne di cavalieri di s. Maurizio e Lazzaro il sindaco La Stella, il colonnello Navarca della guardia nazionale foggiana e i maggiori di quella di Bovino, di Sansevero e di Tròia, nonché cól lasciare al prefètto lire quattromila pei poveri della città.
Ed ei ritornò in Foggia anche altre volte, rapidamente, di passaggio, intrattenendosi, ora più, ora meno, coi suoi rappresentanti, sempre quando recavasi a Napoli; e, dopo di lui, Umberto, Amedeo e Margherita, per tacermi di quanti altri li seguirono dappoi, non volendo io trasmodare dai limiti del periodo di tempo,di cui tratto, toccarono pur essi la nostra terra, con suscitare ovunque sempre più allegria, tripudio e, ad un tempo, affetto e riverenza per la Casa sabauda. Che anzi codesti due primi vollero, più che altri, dar prova a Foggia della loro regale simpatia; e una delle volte, in cui vennero insieme da Brindisi, perchè Umberto, il principe ereditario, vi tornava da solo il 18 gennaio 1866, entrambi vi rimasero per due giorni interi, il ’27 e il 28 maggio 1865, accompagnati dall’ on. Farina e dall’on. Torelli, ministri, l’uno dei lavori pubblici, l’altro di agricoltura e commercio. Addirittura essi si confusero in quel rincontro con la cittadinanza, la quale tributò loro i più devoti onori e in istrada, e a convito, e a teatro e fin nel duomo, ove assistettero, nella cappella del santuàrio dell’Iconavetere, in piedi, dietro a due genuflessori ornati di fiammante drappo vellutato, presso due sedie a bracciuoli al sacrifizio della messa (1). E come segno ulteriore di compiacenza e di soddisfazione verso una città che mostrò veramente di amarli, vollero che il re, augusto loro genitore, decorasse della croce di cavalieri mauriziani il sindaco dell’epoca Pasquale Scoccherà, i due maggiori della guardia nazionale Raffaele Nannarone e Giovanni Barone, nonché il marchese Saverio Salerni di Rose, presidente la Commissione ordinatrice del ricevimento (2). s
Ma il periodo, in cui accentuossi per davvero il movimento nella nostra città, fu quello dell’anno 1886, l’epoca cioè della guerra contro l’Austria, quando, coi nuovi richiamati di leva, cominciò a verificarsi un inesauribile passaggio di truppe, e quando altresì la folla delle camicie rosse copriva
(1) La messa fu celebrata dal canonico Michele Petrosillo, che alla fine dell’e van¬gelo, pronunziò del pari 1′ Oremus prò rege, come di consueto praticano i cappellani della truppa.
(2) Gli altri componenti la Commissione furono i signori: marchese Pasquale Sag-gese, cav- Lorenzo Scillitani e eav. Giuseppe Della Rocca.
addirittura, in ogni ora del giorno, le vie di Foggia pel concentrarsi quivi, a centinaia a migliaia, da Como, da Varese, da Firenze, da Bologna, da Roma, da Terni, da Pescara, da Pesaro, da Rimini, da Cosenza, da Ancona, da Barletta, da Brindisi e sin dall’Egitto, d’una gioventù balda e fiera, pronta a versare per la patria il suo sangue contro un nemico indomito e costante, e a riprodurre così pure una volta gli eroismi di Curtatone e di Montanara. Onde non bastarono i quartieri, non bastarono i locali privati e pubblici a contenerli, e visi adibirono, per conseguenza, anche le chiese. Ohi come, da mane a sera, dolce risuonava all’ orecchio dalla strada e dall’ interno dei pubblici ritrovi, dalle trattorie, dalle bettole improvvisate all’ aperto, tra il tintinnio dei bicchieri, la strofa sentimentale dei giovani partenti, pieni di slancio e di fede:
Addio, biondina, addio, ;
L armata se ne va.,:
E come, d’altra parte, disponeva gli animi a pugna feroce contro l’aquila grifagna il canzonatorio e sarcastico loro ritmò :
Dalla pancia dei tedeschi
I tamburi far dobbiam…
Periodo codesto assai simpatico per la nostra città, trasformata, per l’occasione, pure una volta in una grande caserma, felice di accogliere i combattenti italiani, che dovevano scrivere col proprio sangue le ulteriori e. fulgenti pagine della nostra epopea. Or questo periodo, assai movimentato, ben va ritratto nel già cennato diario dei miei avi, dalle cui pagine rilevasi altresì come il venti di maggio pervennero a Foggia l’ onorevole Giovanni Nicotera, l’eroe di Sapri, colonnello comandante garibaldino anch’ egli, e, il nove giugno consecutivo, Menotti Garibaldi. In ogni classe della cittadinanza vi fu nobile gara per degnamente festeggiarli, come per prestare del pari la loro opera utile e generosa verso i partenti, per cinquecento dei quali si andò in giro da apposita Commissione con a capo Domenico Varo, proprietario di Troia, allo scopo di fornirli di camicie rosse che non avevano, e che loro si consegnarono il ventotto di giugno con grande slancio di filantropia e di pa¬triottismo, tra gli augurii della vittoria.
Le notizie, intanto, delle varie vicende della guerra e del valore dei nostri soldati, affermatosi su’campi di battaglia non secondo al prussiano contro il nemico comune destarono in Foggia continuata eccitazione e febbrile entusiasmo. Che anzi la sua rappresentanza comunale, grandemente commossa dagli splendidi atti di eroismo, di cui avea dato prova, il giorno trenta di giugno, il 4.° squadrone lancieri di Foggia, attaccando e ponendo in fuga a Gazzoldo quattro squadroni di cavalleria austriaca, deliberò per acclamazióne di far coniare per quei prodi una medaglia commemorativa di argento medaglia, che nella postuma ricorrenza della festa dello Statuto, nel 2 giu¬gno 1867, fu destinata, con apposito elenco, in pubblica adunanza tenutasi nella chiesa di san Gaetano, a ciascuno di quelli, e spedita al Ministero per la relativa distribuzione.
Né è a dire, poi, quai lutto si sparse rapidamente per la città all’annunzio improvviso dell’arrivo a Manfredonia dei feriti di Lissa, dei pochi fortunati ripescati dalle acque nel-l’orrendo eccidio, imprevvisto da tutti, ma vigliaccamente voluto da un uomo solo, di quella giornata che rimarrà per gl’ita¬liani, tra il più profondo e fosco dolore, un semplice sogno di vittoria. Oh’ quante lagrime si mescolarono allora con le lagrime delle madri italiane ! quanti imprecarono con esse, nella più santa angoscia, al tradimento di un Persano, la cui respon¬sabilità i contemporanei vollero, chissà per quali inconfessabili cagioni, attenuare, ma che i futuri, innanzi all’ inesorabile tribunale della storia, sapranno severamente giudicare! E mosse allora, altresì, da Foggia per l’antica città di Manfredi una folla di generosi per dir loro una parola di conforto, per dare a ciascuno un sollievp; e il prefetto Scelsi vi mandò persino un medito valorosissimo, il nostro concittadino dottor Vincenzo Nigri, con carabinieri di scorta, per apportare, ai figli della patria comune, urgente, valido, salutare soccorso.
E bene ho sentito anch’io, giovinetto qual’ ero; i maschi lamenti d’un mio vecchio congiunto,ch’ebbe allora un suo figliuolo, baldo e bello, ricco di energie, d’illusioni e di speranze, miseramente affogato e sepolto ivi tra le onde, a ventun’anno appena. Ei non piangeva, no, —lo ricordò ancora, come se fosse ieri—ma dentro impietrava; e, inspirando dappoi il franto
e nobile animo suo a sentimenti degni delle spartane leggende, scriveva il 17 gennaio ’67 a Mariano d’Àyala queste testuali parole, che costituiscono da sé monumento per davvero sublime di patriottismo e di fede: « La sua morte mi ha tolta la pace, non perchè egli sia morto in servizio della patria, che è quanto un uomo possa di meglio desiderare, ma per lo assassinio col quale quel bel legno e lo scelto Stato maggiore, che vi era imbarcato, furono abbandonati all’ira nemica; cordoglio ehe né la punizione del Persano, né quella di mille altri potranno sanare nei desolati nostri cuori (1) ».
E dopo sì grande scempio del nome e della dignità della nostra marineria, il riscatto di Venezia non poteva risollevare gl’italiani, come infatti non li risollevò dall’abbattimento, in cui erano immersi; e se Foggia, dopo avere oh ! quanto esultato durante tutto un periodo di guerra innanzi al valore delle nostre truppe, inneggiava, posteriormente, il 4 novembre ’66, nel tempio e sulle piazze al congiugnimento della nuova regione con la gran madre comune, non potette, per altro, cancellare né allora né mai dal più profondo dell’animo suo l’aculeo tormentoso del ricordo di Lissa.
XXIII.
Dal 1866 al 1870 precipitarono gli avvenimenti politici, che con l’annessione del Veneto si acuì vie maggiormente l’antico voto di completare presto l’unità italiana con Roma ca¬pitale.
Il gran re Vittorio Emmanuele, inaugurando la seconda sessione della nona legislatura del Parlamento italiano, usciva
(1) Vedi Mariano d’Àyala, Vita degì’Italiani benemeriti della libertà e della pa¬
tria, pag, 84, — Torino 1883.
Il giovane caduto, di cui l’orbato genitore plorava la tragica fine, rispondeva al nome di Luigi Bonghi, figlio di Giuseppe (della stessa famiglia di Ruggiero e cugino dilettissimo di mio padre) e della nobil donna» Giuseppina De Bourcard, di origine sviz¬zera. Nato nel 26 gennàio 1845, ed entrato nella marineria di guerra il 17 di ottobre 1860, in qualità di secondo commissario, trovavasi, nel di della battaglia, qual primo com-missario sulla fregata Re d’Italia.
in questi detti: « La patria è libera finalmente da ogni signoria straniera. L’animo mio esulta nel dichiararlo ai rappresentanti di venticinque milioni d’italiani. La nazione ebbe fede in me, io l’ebbi nella nazione. Questo grande avvenimento, coronando gli sforzi comuni, dà nuovo vigore all’opera della civiltà e rende più sicuro l’equilibrio politico dell’Europa. Il pronto ordinamento militare e la rapida unione dei suoi popoli acquistarono all’Italia quel credito che le era necessario, perchè potesse conseguire per virtù propria e per concorso di efficaci alleanze la sua Indipendenza. Aggiunse stimolo e conforto a quest’o¬pera laboriosa la simpatia dei governi e dei popoli civili, alimentata ed accresciuta dal coraggioso perseverare delle Provincie venete nel comune proposito del nazionale riscatto. Il trattato di pace con l’impero austriaco, che vi verrà presen¬tato, sarà seguito dai negoziati, che rendono più ageveli i reciprociscambii. Il governo francese, fedele agli obblighi assunti con la Convenzione del settembre 1864, ha già ritirate le sue milizie da Roma. Dal canto suo il governo italiano, mantenendo gli impegni presi, ha rispettato e rispetterà il territorio pontificio. La buona intelligenza con l’imperatore dei francesi, al quale ci legano vincoli di amicizia e di gratitudine, la temperanza dei romani, la sapienza del pontefice, il sentimento religioso ed il retto giudizio del popolo italiano aiuteranno a distinguere e conciliare gì’interessi cattolici e le aspirazioni nazionali, che si confondono e si agitano in Roma. Ossequioso alla religione dei nostri maggiori, che è pur quella della massima parte degl’ italiani, io rendo omaggio in pari tempo al principio di libertà che informa le nostre istituzioni, e che, applicato con sincerità e con larghezza, gioverà a rimuovere le cagioni delle vecchie differenze fra la Chiesa e lo Stato. Questi nostri intendimenti, rassicurando le coscienze cattoliche, faranno, io spero, esaudito il mio voto che il Sommo Pontefice continui a rimanere indipendente in Roma ecc. »
Ciò nonostante, dalle Alpi al Lilibeo cominciò ad udirsi tra le masse, con più insistenza e con maggiore strepito da non ammetter soste ulteriori al coronamento del programma nazionale, il fatidico grido : a Roma ! a Roma !
I partiti di Destra e di Sinistra si erano accentuati in malo modo sin dopo il fatto lacrimoso di Aspromonte, seguendo l’uno la politica cavourriana e l’altro le non represse ansie garibaldine. I cavourriani, col così detto partito di ordine, si aspettavano di ottenere Roma mercè l’autorità regia; i garibaldini, per contrario, fremevano ed avevano giurato di conquistarla financo con la rivoluzione. Questo stato di cose si propagò anche in Foggia, ove l’antico comitato di azione, ribattezzatosi con altro nome, non lasciava, a quando a quando, di dare anch’ esso segni non dubbii d’impazienza febbrile pel compimento del comun voto della nazione, e provocavansi quindi, continuamente, congiure, dimostrazioni e insurrezioni, che mettevano in angustie il prefetto, costretto a sguinzagliare, per soffocarle in sul nascere, i suoi fidi segugi ed a minacciare spesso financo di chiusura il comitato medesimo. La stessa rappresentanza municipale credette emettere, sin dal marzo 1862, sotto il primo sindacato di Lorenzo Scillitani, siccome già accennammo, un solenne deliberato, col quale protestavasi contro l’ulteriore permanenza del potere temporale nel pontefice, e faceasi voto perchè si affrettasse l’unione di Roma al nuovo regno d’Italia.
Il 28 di ottobre ’67, intanto, il prefetto Malusardi, con affisso a stampa, comunicava ai foggiani un proclama reale in data ventisette ottobre da Firenze e controfirmato dal ministro dell’interno, col quale Vittorio Emmanuele esortava gl’italiani a moderare le loro intemperanze e le gare, che disperdevano la vigoria delle menti e degli animi, e a mettere un freno ai loro audaci propositi di ardite imprese, diretti ad ingrossare le mene del partito di azione, subillato da Garibaldi e seguaci, per la rapida conquista di Roma a capitale del regno. Contale proclama si ricordava agl’italiani il rispetto egualmente dovuto da tutt’ i cittadini alle leggi ed ai patti internazionali, sanciti dal Parlamento e dal re, con cui si stabiliva, in codeste gravi circostanze, un inesorabile debito di onore. E face-asi noto che l’Europa era bene a conoscenza che la bandiera innalzata nelle terre vicine alle nostre, e su cui fu scritta la distruzione della suprema autorità spirituale del capo della religione cattolica, non era opera del re. Tale tentativo — soggi unge vasi— pone, la patria comune in un grave pericolo, ed ingiunge al re l’imperioso dovere di salvare ad un tempo l’onore del paese, e di non confondere, in una, due cause assolutamente distinte, due obbietti diversi. Che l’Italia debba essere rassicurata dai pericoli che può correre; che l’ Europa debba essere convìnta che l’Italia, fedele ai suoi impegni, non suole, né può essere perturbatrice dell’ordine pubblico. Che la guerra con la Francia, nostra alleata, sarebbe stata una guerra fratricida fra due eserciti che pugnarono per la causa medesima. Che, qual depositario del dritto di pace e di guerra, non poteva Sua Maestà tollerare niuna insurrezione, e confidava quindi che la voce della ragione fosse stata ascoltata, e che i cittadini d’Italia, i quali violarono quel dritto, si sarebbero posti prontamente dietro le linee delle nostre truppe. Che i pericoli creatisi, possibilmente, dal disordine e da inconsulti propositi, dovevano ad ogni costo scongiurarsi, mantenendo ferma l’autorità del governo e l’inviolabilità delle leggi. Che l’onore del paese era nelle mani del re, e che la fiducia avuta in lui dalla nazione, nei suoi giorni più luttuosi, non potea venirgli meno. Che quando la calma fosse subentrata negli animi, e l’ordine pubblico fosse pienamente ristabilito, il governo del re avrebbe, d’accordo con la Francia e secondo il voto del Parlamento, curato con ogni lealtà e con ogni sforzo di trovare un utile Componimento, che fosse valso a porre un termine alla grave ed importante questione romana. «Italiani!—conchiudeva Vit¬torio Emmanuele II nel suo proclama — io feci e farò sempre a fidanza col vostro senno, come voi lo faceste con l’affetto del vostro re per questa grande patria, la quale, mercè non comuni sagrifizii, ricollocammo finalmente nel novero delle nazioni, e che dobbiamo consegnare ai nostri figli integra ed onorata ».
E alla comunicazione di questo proclama tosto tenne dietro la comunicazione di un telegramma, ricevutosi il trenta di ottobre da Firenze, col quale il governo rassicurava gl’itataliani che, verificandosi per avventura un qualsiasi sbarco di francesi, si sarebbe provveduto in modo da garentire i diritti della nazione ; e poi di un altro ancora del trentuno ottobre, pubblicatosi del pari nella Gazzetta ufficiale, mercè il quale annùnziavasi che, avendo il Moniteur di Francia fatto noto che la bandiera francese sventoli,sulle mura di Civitavecchia, il governo del re, in coerenza delle dichiarazioni antecedentemente fatte alle potenze amiche in vista di una tale eventualità, avea dato ordine alle truppe di varcare la frontiera per occupare alcuni punti del territorio pontifìcio.
La parola moderatrice del re ben riusciva nell’intento d’insinuare negli animi la calma e la fiducia per una regolare evoluzione di circostanze adatte al conseguimento delle comuni finalità. Ma se le popolazioni mostrarono di volere aspettare, sia pure col piede in istaffa, lo svolgersi degli eventi, i comitati, d’altra parte, non lasciarono, quasi come la guadiana nelle viscere dei campi di Castiglia, di lavorare in modo latente e persistente per scoppiare in punto opportuno, sfidando così le ire e fin le rappresaglie del governo.
Il comitato liberale foggiano fin dal primo giorno di suo nascimento, abbastanza remoto, mostrò anch’ esso di voler essere centro di un moto anticlericale nella nostra città. Non appena, infatti, inauguratisi i suoi locali la sera del 13 feb¬braio 1862, là, in un pianterreno a piazza mercantile, stabilì di far l’indomani una pubblica dimostrazione, che affermasse appunto un tale concetto. E 1 indomani si convenne dapprima, in adunanza plenaria, nella sede sociale, ove il cappuccino p. Urbano arringò, dimostrando, con fluidità di parola, che il pontefice Pio IX avrebbe dovuto lasciare ad ogni costo il governo temporale, e che non dovevasi perciò secondare stupidi riguardi e nocive convenienze, non potendosi il cammino della civiltà e della redenzione italiana arrestarsi a mezzo la via. Egli quindi incitava il popolo ad iniziare in Foggia un movimento tale, che, in armonia di ogni altra contrada, rendesse presto tal vivo desiderio della nazione intera un fatto compiuto. Un uragano di applausi salutò l’oratore; e, scioltasi l’adunanza, si uscì con bandiere tricolori e tra le suggestive note dell’inno garibaldino sulla strada, ov’ erasi ragunata una folta studentesca, mista a curiosi di ogni gradazione sociale, Il marchese Saverio Salerai di Rose, Gaetano Postiglione, Ferdinando Ro¬sati, l’ex-scolopio Gabriele Cicella, Ferdinando Cipri, Pietro De Plato ed altri liberali di primo rango aprivano il corteo, che prese a girare per la città, gridandosi a squarciagola: Abbasso il papa re; viva il papa-prete; viva Vittorio Emmanuele II in Campidoglio ; viva Garibaldi; e, giunto in -siti centrali, soffermavasi, dando così luogo ad altri pubblici sermoni, tra cui ricordasi, pieno di fuoco scoppiettante, quello tenutosi dallo scolopio p. Grilli a piazza Portareale. Fattasi sosfa per poco alle ore ventuno, la dimostrazione si riprese, » con maggiore veemenza e con maggior concorso, la sera, quando, muovendosi per le vie principali e pe’sobborghi con torce a vento e con fuochi di bengala, si tennero affaticati i mantici di migliaia di polmoni fino a notte fonda, senza sentirsi mai stanchi o satolli. Così, dunque, solennizzava il suo battesimo nel 1862 il comitato dei liberali, che, per conseguenza, in prosieguo, allorché il governo volle stringere i freni per mettere un argine al torrente che minacciava travolgere ogni accordo diplomatico, fu tenuto di mira dall’ autorità politica e quotidianamente invigilato in tutti i suoi piccoli movimenti.!
E alquanti giorni prima del 26 agosto ’62, epoca in cui Foggia, come già dicemmo in altro luogo, al pari delle altre città del regno fu messa in istato di assedio dal generale Alfonso Lamarmora, commissario straordinario nelle Provincie napoletane, per l’avvenimento di Aspromonte, lo stesso comir tato aveva di nuovo eccitati gli animi dei foggiani in prò del-. Fazione garibaldina e contro il volere esplicito del governo, dando causa ad altre consimili dimostrazioni di piazza, delle quali, a dir vero, riusciva imponentissima quella del 16 ago¬sto ’62, avendovi preso parte i più accesi liberali quali Ferdinando Cipri, Antonio Carelli, Leonardo Albanese, Giuseppe Raho, Pietro De Plato, Giovan Battista e Gaetano Postiglione, nonché altri moltissimi che di quel comitato erano i maggiorenti, menare le facciate degli editìzìi si vedevano addirittura ricoperti da stampati bellicosi, e p. Urbano, il tribuno cappuccino, rivolgeva in sulle piazze alle masse la sua parola incendiaria. Per lo che, il venti di ottobre consecutivo, là sede del comitato venne violentemente chiusa a mezzo di un commis¬sario della polizia, ad onta di vivaci proteste sollevate da alcuni componenti di esso, ch’ivi trovavansi per caso, fra i quali due liberali di buona tempra, Antonio de Maria e Ferdinando Rosati.
Ma, anche a comitato chiuso, l’influenza che esercitavano sempre sempre i componenti di esso sulle masse era tale, che l’autorità prefettizia ne temette sul serio in ogni occasione, e non lasciò di tenerli d’occhio anche singolarmente sotto ogni pretesto o fals’ombra.
Si volle festeggiare una volta, ad esempio, dai liberali, di accordo col municipio e con la guardia nazionale, di cui quelli erano magna pars, il terzo anniversario dell’entrata di Garibaldi in Napoli; e il prefetto, non potendosi legalmente opporvisi, non vi prese però parte con tutte le altre autorità governative; che anzi, per paura di una sommossa, i cui limiti non poteansi prevedere, facea consegnare in quartiere la truppa.
E quando, nel 20 marzo ’64, si vollero ripetere, sempre ad opera degli stessi liberali, dimostrazioni simiglianti di simpatia al vindice Trasibulo di Caprera, sulla cui fronte, come disse il poeta,
Più sacri lauri crebbero
Le selve d’Aspromonte
portandosi in giro per la città un quadro con l’effìgie di codesto generoso ribelle ed eccitando così il popolo oltremisura, si vide la necessità di sbaragliarne le file in piazza del teatro a mezzo dei carabinieri della vicina caserma. I quali ne arrestarono parecchi, e tentarono strappar loro quel quadro; al che, risoluti e impassibili, tutti esclamarono: « Arrestateci pure, ma il nostro divino eroe verrà con noi in carcere anche a prezzo di sangue ».Sicché, essendosi poi ricomposto in altro sito il vecchio comitato, sì ricominciò ad esercitare su di esso un’assidua vigilanza; e fu perciò che notavansi da mane a sera, senza interruzione guardie di pubblica sicurezza andare su e giù, in quei pressi, per via Portareale, dall’angolo cioè del teatro sino al portone dei signori Buonfiglio (1); e se ne videro, in quel torno, persino nella strada denominata Bruno, precisamente dirimpetto al palazzo Sipari, ove abitavano i signori Gaetano Postiglione e Pietro De Plato per studiarne i passi. Che anzi a quest’ultimo fu addirittura collocato ai panni un angelo custode, che prese a seguirlo come ombra al corpo, e che il giorno 6 aprile ’64 giunse perfino a vietargli di poter salire in vettura per recarsi in un suo podere di campagna, non permettendosi dal prefetto De Ferrari ch’egli si allontanasse da Foggia neanche per un solo istante.
Le preoccupazioni dell’autorità politica, insomma, si aumentavano tuttodì, sempre più,
- ci) In epoea posteriore, precisamente sptto il palazzo Buonfiglio a Portareale s’in¬stallava altra associazione politica, la Costituzionale, occupando quivi gli antichi lo¬cali dell’ elegante Caffè Nazionale, che fu inaugurato il 21 novembre 1865, e che appar¬tenne a quei fratelli Guardabassi di Poggia, i quali, pervenuti tra’primi a Roma, nel¬l’anno 1870, conseguirono colà notorietà e fortuna.
innanzi alle tassative disposizioni del governo, impensierito alla sua volta per possibili complicazioni internazionali; e tali preoccupazioni sorgevano anche a causa d’inezie, di un nonnulla.
Ebbe, infatti, a venire la pelle d’ oca al prefetto il 14 a-prile ’66, quando, incedendo per le vie di Foggia la processione del venerdì santo, si fu ad un pelo per aversi una pericolosa sommossa. Alcuni uffìziali piemontesi, tal Vietti e Del Vecchi del 55.° di linea, affacciatisi ad una delle finestre del quartiere dell’Annunziata, prospicienti sul largo Pozzo Rotondo, per dove la processione trovavasi a transitare, e, mentre incomìnciavasi una delle solite prediche che usano tenere colà, per l’occasione, ai diversi angoli delle strade su ciascun Mistero, presero a ridere, a fischiare, a beffeggiare il predicatore (1), nonché a scagliargli addosso dei sassolini per fargli sfregio maggiore, Ciò produsse un finimondo, che la penna non sa riprodurre, ma che la fantasia può agevolmente immaginare. Il popolino, superstizioso fino al midollo, fremette come iena ferita, e, non sapendo in qual modo reagire, cominciò a vomi-tare insulti contro i due provocatori e a scagliarsi su quanti gli venivano a tiro, sieno soldati, sieno liberi pensatori,, di cui qualcuno ebbe la imprudenza di gridare: «abbasso il papa! morte ai preti !» Un povero fantaccino, come un cappone da sgozzare, fu preso allora pel collo da un pugno di terrazzani inferociti, e per poco non andò a capo fitto giù nel vicino pozzo a rintracciarne il fondo. La folla, impaurita, prese a fuggire da ogni lato, e persino coloro che portavano l’urna di cristallo, ove giaceva un Cristo morto, se la dettero a gambe levate, tanto che, a salvarla dallo infrangersi, dovettero sorreggerla lo stesso sindaco Pasquale Scocchera e l’assessore Gaetano Postiglione, i quali, secondo l’usato, seguivano, in frac, a capo scoperto e con un cero tra mano la processione. Un capitano dell’arma benemerita, con un forte nerbo di carabinieri e di guardie di pubblica sicurezza, si fece strada nella calca tumultuante, e potè, strappare il malcapitato da certa morte, menandolo pesto, malconcio e insanguinato com’era, all’ospedale, mentre riusciva con molto tatto a calmare gli animi dei più eccitati. Obbligò intanto il predicatore a riallacciare lo spezzato filo del sermone, dopo di che la processione fu messa in grado di poter riprendere il suo cammino sino alla cattedrale. A sera il prefetto, sospettando che i liberali volessero, ai loro fini, profittare della circostanza, o per lo meno volessero sfruttarla i facinorosi, che accorrono sempre alla notizia di un tumulto popolare come stuolo di corvi al campo dove vi è stata la mischia, ordinò che le chiese tutte rimanessero ermeticamente chiuse, tranne quella del Purgatorio dei Bianchi, dove ebbe invece ad affollarsi molta gente pacifica é devota. L’indomani, intanto, il colonnello punì i due temerarii uffìziali, mettendoli agli arresti in quartiere. Così operando, volle egli rammentare ciò che, ventun secolo e mezzo prima di noi, fece un re buddista, Asoka, quando nell’anno 308 innanzi l’era volgare emise questo editto: « Onorate solo la vostra credenza, ma non insultate le altrui. Anzi talvolta vi converrà onorare l’altrui fede, perchè la fede è sempre degna di rispetto. Col rispettarla sempre, si fortifica la propria, non si scardina quella degli altri. Insultando la credenza altrui, si nuoce non solo a questa, ma anche alla propria, perchè si offende la fede ».
E, tacendomi di mille altre occasioni, in cui temevasi sempremai uno scoppio di elettricità, andatasi accumulando dai liberali nelle file del popolo, ricorderò che fin per un meeting che si volle tenere il 20 febbraio 1866 nella sala del teatro Danno da parecchi gentiluomini foggiani con a capo i signori Antonio Carelli, presidente, e Antonio De Nittis, segretario, per protestare contro la minaccia di tasse ulteriori in aggravio di quelle già esistenti e di fresco attuate, il prefetto tentennò un poco e cedette quasi per necessità a concedere il relativo permesso. Ma quando nella sala affollatissima vibrarono discorsi assai pungenti all’indirizzo del governo da parte del Carelli, del De Nittis, del Cipri e di un tal Pace, abruzzese, la P. S. corse a fare, intorno al teatro, un apparato straordinario di forze per ogni evento, mentre si riunirono dugento carabinieri nella vicina caserma, pronti ad uscirne al primo allarme. Eppure tutto procedette in ordine, e nessuno sconcio si avverò, neanche allora, dei tanti temuti dall’autorità politica, come non mai se ne avverarono in prosieguo, pur quando s’improvvisava altra pubblica dimostrazione per Giuseppe Mazzini, che trovavasi allora in Inghilterra, in occasione del suo prosciogli¬mento dalla pena di morte e della seguita riabilitazione da parte del governo italiano, dimostrazione che fece saltare la mosca al naso del prefetto Scelsi, il quale redarguì senz’alcuna misura il bravo ff, sindaco di allora, Nicola Celentano, per aver permesso l’uscita della banda musicale dell’ospizio Maria Cristina.
Ma il nostro buon popolo, insomma, — e ciò vada a sua lode—, ad onta di potenti e continue suggestioni in ogni tempo, ad onta delle notizie dell’ardimentoso avanzarsi di Garibaldi sul territorio pontificio, alla testa di cinquemila uomini nell’ottobre e nel novembre del 1867,come delle sue vicende guerresche e a Monte Rotondo, e alle cascine di S. Colombo, e a Mentana, quando i francesi, rinalberando su Castel s. Angelo il vessillo napoleonico, che avea cessato di sventolare FU dicembre 1866, vollero con le armi riaffermare ad oltranza la tutela del papa, ad onta di sentir poscia, dopo quest’ultima disgraziata giornata, il nostro eroe quasi sequestrato dal governo italiano e violentemente condotto a Spezia ed a Caprera per. sottrarlo così ai suoi fidi volontarii e ad una sicura vittoria finale, ad onta di tutto questo, il nostro buon popolo, di¬cevo , non osò mai trasmodare, ma mostrossi sempre amico dell’ordine, ossequiente alle leggi del suo paese e ligio ai desiderii del governo.
L’infermità di re Vittorio Emmanuele, colpito a S. Rossore da pleurite infettiva nel novembre ’69, prostrò gli animi di tutti i foggiani, che nel gennaio di quell’anno lo avevano ri¬visto dopo il 10 novembre ’65, allorché transitava in carrozza per le vie di Foggia, e.lo avevano acclamato l’ultima volta alla stazione ferroviaria quando, muovendo per Napoli, ove la sera tenevasi una festa da ballo al palazzo reale, era stato financo accompagnato dal prefetto e dal sindaco Scillitani sino a Camporeale, termine ultimo della strada ferrata, e donde proseguì poi il suo viaggio, giovandosi di sei superbi cavalli dello stesso Scillitani, e di altri cinque, non meno bravi, del signor Raffaele Nannarone. Il sindaco vide la necessità, perciò, di pubblicare il bollettino sanitario e di farlo affìggere su pei cantoni della città, che pur troppo erano affollati in ogni momento per ansia inesauribile di notizie.
- A. R. il principe Umberto, il quale trovavasi in Napoli «on la principessa Margherita, già prossima per un lieto evento, volle accorrere al capezzale del morente augusto Genitore, epassò nel 7 novembre per Foggia, ove si ebbe la più affettuosa accoglienza da una folla di popolo, che rispettosamente volle andarlo a salutare, coi suoi rappresentanti, alla stazione della ferrovia per mostrargli, nella sua mestizia, che il cuore della nazione batteva all’ unisono con quello di Casa Savoia. E tale spontanea e mutola dimostrazione di affetto volle ripetersi pure una volta ad Amedeo, quando, dopo pochi giorni, transitava anch’ egli per Foggia, diretto a S. Rossore e provveniente dall’ Egitto, ove trovavasi per la solennità dall’ apertura del canale di Suez.
Ma il buon genio d’Italia non permise che sì grande fi¬gura di re sparisse dalla scena del mondo prima che la redenzione del suo popolo non fosse interamente compiuta ; sicché, da un dì all’altro, si seppe che ogni pericolo di morte era stato scongiurato, e eh’ egli man mano riprendeva salute e vigore. Foggia esultò a tale annunzio con sincero ed unanime sentimento, e manifestò, nel suo gradito omaggio, tutta la gioia di cui era compresa quando il nove di novembre ebbe a rivedere il principe ereditario, che ritornava a Napoli, e quando lo stesso re Vittorio Emmanuele il 25 febbraio ’70, vegeto come prima o più di prima, si soffermava alla nostra stazione ferroviaria per soli dieci minuti, diretto da Napoli a Milano in occasione degli ultimi giorni del carnevale. Né paga di ciò ancora, aspettò il quattordici marzo susseguente, la ricorrenza cioè del genetliaco di lui e del principe ereditario per dare maggiore sfogo alla sua esultanza, e in una grande festa scolastica, che volle, fra l’altro, tenere quel dì al teatro Danno, dette con grande concorso di gente d’ ogni classe, e con l’intervento bensì delle più belle e sfarzose nostre signore, magico simbolo di sorriso e di amore, massima solennità alla festa del cuore. E premiò gì’ innocenti nel nome adorato del re, mentre tutti lo acclamavano d’ ogni parte, rinsaldando così pure una volta la loro fede incrollabile nella Casa Savoia, e facendo rinfocolare eziandio con la parola forbita del preside di quel liceo, Ambrogio Marcangelo, i teneri animi della nuova generazione.
E qui riappare la simpatica figura di Lorenzo Scillitani nel più chiaro splendore, che le ulteriori dimissioni, nel-1′ anno 1870, di Giuseppe Ricciardi da rappresentante politico di Foggia dopo le altre, date nel 1864, quando il corpo elettorale non gli dette ascolto e lo rimandò alla Camera il trentuno gennaio con votazione di ballottaggio, lasciando nella tromba il suo avversario marchese Luigi De Luca, fecero si eh’ ei fosse questa volta il preconizzato, senza discussione,, ad esserne il successore.
E fu davvero il. quasi unanime designato, perchè egli era non solo la sintesi vivente di ogni speranza, di ogni aspirazione e di ogni più nobile e santo orgoglio cittadino, ma, sebbene di una gradazione politica diversa dal Ricciardi, rappresentava come lui un carattere. E il carattere, questa vera forza di ogni uomo, è il sommo delle virtù per un uomo politico, il quale rassembra, né più né meno, un soldato, che,, inscritto in un battaglione, debba continuatamente e senza interruzione in quello marciare, un soldato che, avendo giurato di difendere e di far trionfare il labaro affidatogli, non ha poi il dritto, lunghesso il cammino, di arrotolarlo e di chiuderlo nel fodero per farlo credere, a suo talento, bianco ai bianchi, nero ai neri. Pari a queir olandese, cui venne domandato da sant’ Olaf qual fede avesse, dovrà,fìero, sempre sempre rispondere: « non ho altra fede che in me stesso. » Né entrambi furon mai meschini istrumenti di clientele,né d’interessi singoli o poco confessagli, ma serbarono, sotto diversa divisa pubblica,, intatte sempre quella dignità e correttezza, di che un’alta coscienza non deve mai dispogliarsi. E quando il deputato—era Marco Minghetti che lo diceva in uno dei suoi splendidi discorsi — non rappresenta più dei principii, e quando non è mosso dal sentimento dell’ interesse nazionale, ma è invece l’organo d’interessi locali, è il patrono, il sollecitatore, l’a-gente di coloro che lo mandano, ivi è principio di corruttela, giacché in uno sviluppo d’intrighi si smarrisce il sacro e delicato ufficio di rappresentante del popolo.
I pochi avversarli di Lorenzo Scillitani, capitanati dal marchese Saverio Salerni di Rose e da Giuseppe Fioritto di Sannicandrogarganico, vollero contrastargli il passo, e gli contrapposero un illustre avvocato napoletano, Giuseppe De Biasio, che risultava ignoto alla massa degli elettori, e che nessuno interesse diretto, personale avrebbe poi avuto pel collegio, cui era estraneo, in garentirne e difenderne le sorti. Ma la maggioranza dei foggiani, sicura di prescegliere nello Scillitani l’autentico rappresentante della loro città e dei loro sentimenti,ne fece una vera questione di campanile e, guidata dal nobile e supremo concetto che la rinuncia spontanea al candidato naturale sia cosa poco edificante, anzi sia addirittura un riconoscimento umiliante della propria inferiorità, sfidò con animo intrepido gli avversarli, quasi ripetendo le altiere parole di Pier Capponi a Carlo Vili pretendente alla signoria di Firenze: « Date pure fiato alle vostre trombe, noi suoneremo le nostre campane ».
E l’ appello agli elettori, fatto in nome del decoro cittadino, ottenne—e non poteva altrimenti avvenire—efficace risultato, che, il giorno 3 di aprile ’70, su cinquecentodiciotto votanti della città, Lorenzo Scillitani riportava ben quattrocento novantadue voti; sicché egli trionfò clamorosamente mercè il largo suffragio di settecento cinquanta voti, ottenuti col massimo entusiasmo dall’ intero collegio.
Una folla di popolo andò ad acclamarlo sotto i balconi del suo palazzo, donde quegli, per tre volte affacciatosi commosso, ringraziò tutti della nuova prova di affetto datagli; e di qui quella si recò sotto i balconi del Fioritto in via dell’ Epitaffio, ove si abbandonò ad una strepitosa dimostrazione ostile, con fischi, cori sberleffi e con rottura di vetri. La sera tutta la città fu in festa con pubbliche luminarie e con rappresentazione di gala in teatro. Così Foggia completò il monumento di gratitudine e di affetto che aveva eretto in cuor suo a Lorenzo Scillitani, confutando bellamente col suo operato, sia pure in linea eccezionalissima, il giudizio che Pietro Giannone ebbe, con assai rigore, a pronunziare intorno alla instabilità delle passioni di nostra napoletana gente.
E Lorenzo Scillitani andò quindi a sedere in Parlamento tra i rappresentanti del gran partito moderato italiano, quando Destra e Sinistra non eran pure divenute due vecchie carcasse come oggidì, ma trovavansi invece, nel loro vero momento psichico; e se non potè brillare nell’arena tra le file dei pugnaci, privo com’era di doti oratorie, rappresentò però il suo collegio con grande dignità e decoro.
Ed eccoci ora all’ultima tappa del glorioso cammino della rivoluzione, al fatidico giorno in cui, con la conquista di Roma, reclamata dall’amore e dalla venerazione degl’ italiani, e resa finalmente a sé stessa, alla patria comune ed al mondo moderno,Vittorio Eramanuele scioglieva la sua promessa e completava, in nome del dritto nazionale, l’impresa che ventitre anni prima aveva iniziata Carlo Alberto, il magnanimo vinto di Novara, e l’Italia, libera ed una, coronata in Campidoglio, lasciava d’ora in poi a’ suoi figli l’alto dovere di farla grande e felice.
La Francia e la Prussia, i due grandi popoli del continente, gloriosi rappresentanti entrambi di civiltà, si straziavano in terribile lotta su’ campi di battaglia, e l’Europa assisteva, con la più rigorosa neutralità verso i belligeranti, al terribile certame. Ma la notizia delle disfatte precipitose di Napoleone cominciarono a pervenire man mano presso di noi, e in Foggia, specialmente, dove con ansia crescente se ne seguivano le sorti. Ma con le notizie della guerra e di così complicata situazione internazionale, che avevano già preoccupate le autorità tutte per tema d’improvvisate dimostrazioni, pericolose di accidenti imprevedibili, pervennero altre più importanti notizie, atte a scuotere quell’unità di patriottismo che Cambon vantava a Robespierre in una delle più tempestose giornate della Convenzione, e che Foggia avea mostrato in altre occasioni di andare già perdendo con lo scindersi delle sue forze: il ritiro cioè delle truppe francesi da Roma, annunziato dal conte di Grammont a Banneville, il loro imbarco a Civitavecchia, le sollecitazioni del Parlamento italiano al Ministero, il quale, disciolto da ogni impegno pel mutamento della forma di governo già avvenuto in Francia dopo la disfatta di Sédan e la resa dell’imperatore, decise finalmente l’occupazione di Roma con l’inviare Ponza di San Martino a Pio IX perchè aprisse il varco agl’italiani, e la nota risposta di lui col famoso non possumus, e la marcia delle nostre truppe per la conquista della capitale del regno, e il tuonare del cannone in breccia, e la caduta dì porta Pia, ultimo vestigio dell’età eroica, e l’entrata, finalmente, trionfale del generale Cadorna nella città eterna.
Il Giornale patrio consacra un’ ultima ed esauriente pagina a questo climax dell’epopea nazionale, che venne a stupire l’ universale per la grandezza senza limiti di un evento, che niun giudizio umano avrebbe pututo mai prevedere si fosse avverato quasi per incanto, mercè un rapido e precipitoso evolversi di fatti importantissimi e inaspettati. E in questa pagina, ricca di emozione e di entusiasmo, che specchiavasi nella smisurata letizia di quel momento singolarissimo, quando, proclamandosi la sepaiazione dello Stato dalla Chiesa e ricono¬scendosi la piena indipendenza dell’autorità spirituale, la nazione intera sentivasi di avere riconquistato il suo posto nel mondo e di aver dischiusa così un’ era novella alla sua storia civile, in questa pagina — dicevo — si trovano riprodotti altresì i due telegrammi che il 20 settembre 1870 ricevette da Firenze il prefetto della provincia, e che, come circolari, il Ministero mandò ovunque.
Il primo di essi suonava così:
La divisione Bixio apriva stamane alle sei il fuoco contro porta s. Pancrazio (1) e bastioni laterali. Successivamente si avvicinò atta cinta occupando il convento s. Pancrazio e Quattroventi. La piazza mantenne un fuoco vivo per qualche ora.Verso le ore 10 antimeridiane inalberò bandiera bianca sopra tutte le batterie per ordine del pontefice. Spedito parlamentare al quartiere generale del comandante in capo Cadorna. Perdite lievi. Il ministro Lanza
lì secondo, firmato dallo stesso, è questo: Truppe entrate Roma porta Pia.
Affissi entrambi codesti due telegrammi sulle cantonate della città, a sì fatto annunzio, l’animo di ogni cittadino abbandonossi alla più pazza gioia. Dal Piano della croce echeggiarono, come nelle grandi occasioni echeggiano anche oggidì, più tiri di mastio in segno di tripudio e di festa, mentre le bande musicali uscirono per le vie a suonare inni patriottici, seguite da una fiumana di dimostranti, tra cui si vedevano tutti tutti i liberali di Foggia e i componenti la Società operaia, capitanati dal loro benemerito presidente prof. Pietro Vecchi della scuola magistrale femminile, che veniva agitando una grossa bandiera tricolore. Tra gli evviva a Vittorio Emmanuele e a Roma capitale si videro festosamente illuminati, a sera, i balconi e le finestre degli edifizii pubblici e di moltissime case private, cui tennero dietro parecchie altre ritardatane, alla richiesta frenetica dei dimostranti. Un vero delirio ! — E il dì seguente le manifestazioni di gioia continuarono, continuarono tuttavia sotto mille forme patriottiche diverse, mostrando così Foggia di sentirsi pure una volta all’unisono con le cento città d’Italia, inneggianti alla realizzazione di un sogno, che sembrava follia sperare.
E qui, mettendo fine a questa Cronistoria, inspirata a null’altro che all’amore della mia terra natale, rendo a questa, dal profondo dell’animo l’augurio sincero di un avvenire di grandezza, di felicità e di gloria, carezzato dall’amplesso e dal bacio unanime di tutt’i suoi figli, riaffratellati finalmente, con l’oblio dei passati rancori, da un nuovo battesimo di amore, necessario a ringagliardire nel sogno, nell’ attesa, nel presentimento di così alti destini, la bellezza austera delle dormienti forze,, delle loro agonizzanti energie. Così fulgido avvenire, animato da un solo impulso, da un solo impeto concorde, nudo di rammarichi e di rimpianti, ma ricco di fremiti e di fede, venga sempre sempre fecondato all’ombra del tricolore, sventolante ormai, nell’orgoglio della vittoria, sulla vecchia torre capitolina della terza Roma. Questo vessillo da’ tre colori, che è la nostra bandiera nazionale e che simboleggia l’unità della patria sotto la gloiosa dinastia reggitrice delle sue sorti, non fletta mai, per trascorrere di tempo e di generazioni, la sua cima superba, ma si erga costantemente, in perpetua apoteosi, verso la faccia del cielo, ove splende come un sole la stella protettrice della patria, e che io saluto in questo istante, in cui depongo la penna, con le soavi e magiche parole del nostro maggior poeta dei tempi moderni, di lui che, per un momento fugace, dubitò della nuova Italia, e che finì con Fumeggiare alla sua fatidica bandiera.
Sii benedetta — esclamava Giosuè Carducci in quella sua prosa che ha l’ ala d’un canto, ed io esclamo con lui, — benedetta ne la immacolata origine, benedetta ne la via di prove e di sventure, per cui, immacolata ancora, procedesti, benedetta ne la battaglia e ne la vittoria, ora e sempre nei secoli. Non rampare di aquile e leoni, non sormontare di belve rapaci nel santo vessillo , ma i colori della nostra primavera e del nostro paese, dal Cenisio all’Etna: le nevi delle Alpi, l’aprile delle valli, le fiamme dei vulcani. E subito quei colori parlarono alle anime generose e gentili, con le ispirazioni e gli effetti delle virtù, onde la patria sta e si augusta : — il bianco, la fede serena alle idee, che fanno divina l’anima nella costanza dei savi,—il verde, la perpetua rifioritura della speranza a frutto di bene nella gioventù dei poeti, — il rosso, la passione ed il sangue dei martiri e degli eroi. E subito il popolo cantò alla sua bandiera che Ella era la più bella di tutte e che sempre voleva Lei e con Lei la libertà; ond’ è che Ella, come dice una scritta, piena di fati mosse alla gloria del Campidoglio.